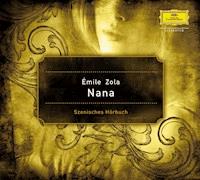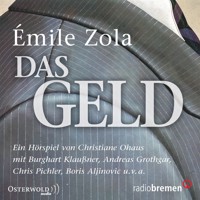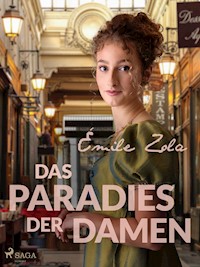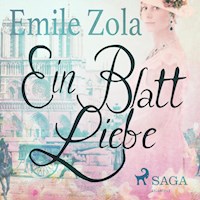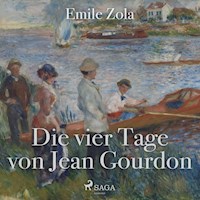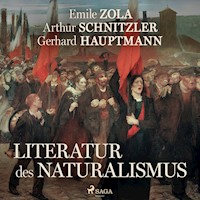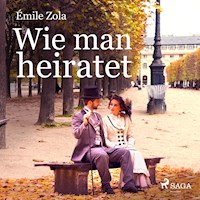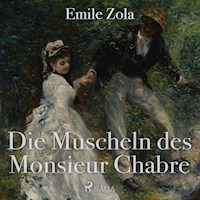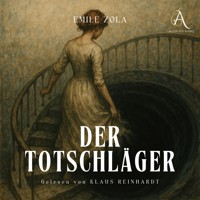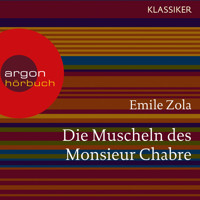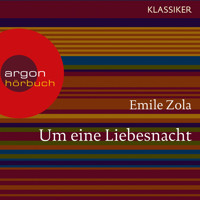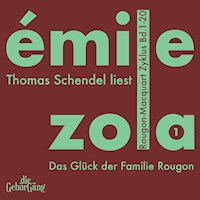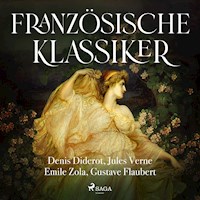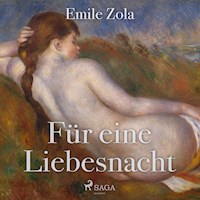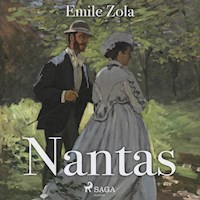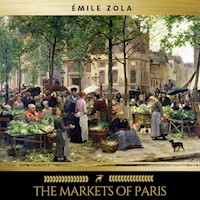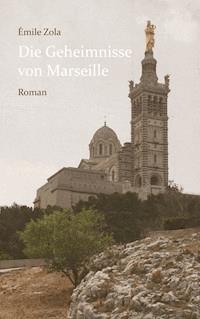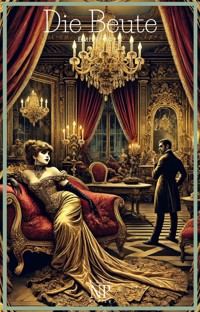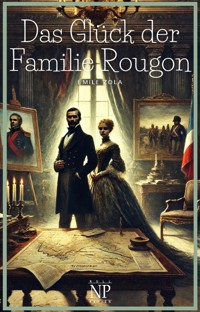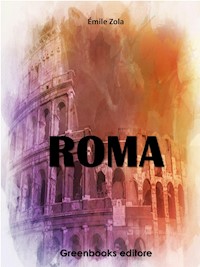
0,99 €
0,99 €
oder
-100%
Sammeln Sie Punkte in unserem Gutscheinprogramm und kaufen Sie E-Books und Hörbücher mit bis zu 100% Rabatt.
Mehr erfahren.
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Greenbooks editore
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Englisch
- "Pierre Froment, giovane abate vissuto nei quartieri più degradati di Parigi, scrive un libro ispirato a ideali di giustizia sociale e carità cristiana, "Roma novella", subito messo all'Indice dalla Chiesa. Giunto a Roma per difendere la propria opera e ottenere udienza da papa Leone XIII, si renderà conto che il suo lavoro non potrà mai ottenere l'approvazione di quel Cattolicesimo attento a difendere il proprio potere temporale. Alle vicende dell'abate Froment, ospite nel Palazzo Boccanera in via Giulia, si intreccia la tragica storia d'amore dei cugini Dario e Benedetta, alla ricerca di un'impossibile felicità. L'incredibile, dimenticato capolavoro del maestro del naturalismo."
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
0,0
Bewertungen werden von Nutzern von Legimi sowie anderen Partner-Webseiten vergeben.
Legimi prüft nicht, ob Rezensionen von Nutzern stammen, die den betreffenden Titel tatsächlich gekauft oder gelesen/gehört haben. Wir entfernen aber gefälschte Rezensionen.
Ähnliche
Émile Zola
PARIGI
Tradotto da Carola Tognetti
ISBN 979-12-5453-085-6
Greenbooks editore
Edizione digitale
Novembre 2021
www.greenbooks-editore.com
ISBN: 979-12-5453-085-6
Questo libro è stato realizzato con StreetLib Writehttps://writeapp.io
Indice
LIBRO PRIMO
LIBRO SECONDO
LIBRO TERZO
LIBRO QUARTO
LIBRO QUINTO
LIBRO PRIMO
LIBRO PRIMO
I.
L’abate Pietro Froment, che aveva
in quel giorno della fine di gennaio una messa da dire al Sacro
Cuore di Montmartre, si trovava fin dalle otto sul poggio davanti
alla basilica.
E prima d’entrare guardò per un
momento Parigi che gli si svolgeva, sterminata, sotto i
piedi.
Era, dopo due mesi di freddo
intenso, di neve e di ghiaccio, una Parigi sommersa sotto
un’umidità tetra e piena di brividi. Dal vasto cielo color di
piombo, pioveva il lutto di una fitta nebbia. Tutta la parte
orientale della città, i quartieri di miseria e di lavoro, pareva
affondata in nembi di fumo rossastro dove s’indovinavano i soffi
dei cantieri e delle officine; mentre verso l’occidente, verso i
quartieri di ricchezza e di godimento, l’inondazione della nebbia
si diradava, diventando un velo tenue, immobile di vapore.
S’intravedeva appena la linea dell’orizzonte; il campo sconfinato
delle case somigliava un deserto sassoso, sparso di gore stagnanti,
che mettevano nei vani un vapore pallido, a cui sovrastavano le
cime degli edifizi e delle vie superiori, di un nero di fuliggine.
Una Parigi di mistero, velata di nembi, come sepolta sotto la
cenere di qualche disastro, già quasi scomparsa nel dolore e
nell’obbrobrio che la sua immensità dissimulava.
Magra forma esile nella sottana
aderente, Pietro guardava, quando l’abate Rose, che pareva si fosse
riparato dietro uno dei pilastri del portico per spiarlo, gli mosse
incontro.
— Ah! siete qui finalmente, caro
figliuolo! Ho qualcosa da chiedervi.
Sembrava impacciato, inquieto. Si
accertò con una occhiata diffidente che non v’era alcuno. Poi,
quasi la solitudine non bastasse a rassicurarlo, lo condusse un po’
più in là, sotto la brezza glaciale di cui pareva che egli non si
avvedesse.
— Ecco; è un povero uomo di cui
mi hanno parlato, un ex-imbianchino, un vecchio di settant’anni che
non è più in grado di lavorare naturalmente e muore di fame in uno
stambugio di via dei Salici… E così, caro figliuolo, ho pensato a
voi; mi son detto che acconsentireste a portargli queste tre lire
da parte mia perchè abbia, se non altro, un po’ di pane per alcuni
giorni.
— Ma perchè non vi andate in
persona?
Di nuovo, l’abate Rose parve
sbigottito, e con sguardi paurosi e confusi, disse:
— Oh! no, oh! no: non posso più
io, dopo tutte le noie che ho avute! Sapete che mi fanno la
guardia, che avrei delle altre ramanzine se mi sorprendessero a far
la limosina senza saper precisamente a chi la fo. E’ vero che per
aver queste tre lire ho dovuto vendere qualche cosa… Ve ne
scongiuro, caro figliuolo, rendetemi questo servizio!
Pietro, col cuore stretto,
considerava il buon prete canuto, con la tumida bocca piena di
bontà, i limpidi occhi infantili nella faccia rotonda e sorridente.
E ricordava con un rifluire di amarezza nell’anima la storia di
quell’amante della povertà, la disgrazia in cui era caduto pel suo
candore sublime da sant’uomo caritatevole. Il suo piccolo
pianterreno di via Charonne di cui faceva un asilo, raccogliendovi
tutte le miserie del trivio, era diventato una fonte di scandalo.
Delle sgualdrine vi riparavano quando non avevano trovato un uomo
che le conducesse seco.
Vi si davano degli appuntamenti
turpi in una promiscuità mostruosa. Ed una bella notte la questura
vi era calata per arrestare una ragazzetta tredicenne accusata
d’infanticidio. L’autorità diocesana, molto turbata, aveva
costretto l’abate a chiudere il suo asilo, mandandolo, dalla chiesa
di S. Margherita, a S. Pietro di Montmartre, dove aveva ritrovato
il suo posto di vicario. Non era una disgrazia, ma uno spostamento.
Lo avevano rimproverato però e lo sorvegliavano, come diceva, ed
egli si sentiva molto infelice ed umiliato di non poter fare la
limosina che di nascosto, come un prodigo senza cervello che
arrossisce delle sue colpe.
Pietro prese le tre lire.
— Vi prometto, caro amico, di far
la vostra commissione, oh! di tutto cuore.
— Andateci dopo la messa, eh? Si
chiama Laveuve, sta in via dei Salici, una casa con cortile, prima
della via Mercadet… Oh! la troverete subito… E sareste pur buono di
venire e rendermi conto della visita questa sera, verso le cinque,
alla Maddalena, dove vado alla conferenza di monsignor Martha. E’
stato così buono per me!… Non ci verrete anche voi?
Pietro rispose con un gesto
evasivo. Monsignor Martha, vescovo di Persepolis, influentissimo
all’Arcivescovado dacchè si era consacrato, con propaganda piena di
genio, ad aumentar del decimo le sottoscrizioni del Sacro Cuore,
aveva infatti preso le parti dell’abate Rose, ed era lui che aveva
ottenuto che lo lasciassero a Parigi, collocandolo a San Pietro di
Montmartre.
— Non so se potrò assistere alla
conferenza ‒ disse Pietro; ‒ ma in tutti i modi verrò a cercar di
voi.
Il vento soffiava, un freddo
intenso li penetrava entrambi, su quel poggio deserto, nella nebbia
che trasformava l’ampia città in un oceano di vapori. Ma si udì un
passo, e l’abate, voltandosi ripreso da diffidenza, vide un uomo
altissimo, robustissimo, calzato di soprascarpe di gomma e con la
testa nuda, una testa con folti capelli bianchi tagliati a
spazzola, che passava con l’aria di uno che abita nel
vicinato.
— Non è vostro fratello? ‒
domandò il vecchio prete.
Pietro non aveva fatto nessun
movimento; rispose con voce pacata:
— Infatti, è mio fratello
Guglielmo. L’ho riveduto dacchè vengo alle volte al Sacro Cuore.
Possiede qui vicino una casa, dove sta da vent’anni, credo. Quando
lo incontro ci diamo una stretta di mano. Ma non sono neppure
andato da lui… Ah! tutto è morto tra noi, non abbiamo più nulla in
comune, dei mondi ci separano.
Il tenero sorriso dell’abate
ricomparve. Fece un gesto come per dire che non si doveva mai
disperare dell’amore. Guglielmo Froment, scienziato di grande
intelligenza, chimico che viveva in disparte, da ribelle, era suo
parrocchiano ora, ed egli sognava probabilmente di riconquistarlo a
Dio, quando passava davanti alla casa, rumorosa per costante
attività, dove il chimico abitava con tre figli già adulti.
— Ma, caro figliuolo, vi tengo
qui al freddo ‒ rispose ‒ e non avrete caldo!… Andate a dire la
vostra messa; ci vedremo questa sera alla Maddalena.
E, supplice, assicurandosi di
nuovo che nessuno origliava, soggiunse, col suo fare da bambino in
colpa:
— E non ne fate motto con
nessuno, oh! mi raccomando; direbbero di nuovo che non so condurmi
a dovere.
Pietro lo seguì con lo sguardo,
mentre si allontanava, dirigendosi verso via Cortot, dove abitava
un piccolo pianterreno umido, rallegrato da un lembo di
giardino.
La cenere di disastro che
sommergeva Parigi si faceva più fitta sotto le raffiche del vento
gelido.
Ed entrò finalmente nella
basilica, col cuore a brani, traboccante dell’amarezza che quella
storia vi aveva fatto rifluire, quel fallimento della carità,
l’ironia atroce di quel sant’uomo che, punito per aver fatto la
limosina, si nascondeva per farla ancora. Nulla potè calmare il
bruciore della ferita riaperta in lui, nè la pace tepida in cui
penetrava, nè la muta solennità dell’ambiente largo e profondo,
nella sua nudità di marmi nuovi, senza quadro, senza fregio alcuno,
con la nave tagliata a metà dell’armatura che turava la cupola del
duomo ancora in costruzione. In quell’ora mattutina, sotto la luce
scialba che penetrava dalle finestre alte e strette, si udivano già
delle messe di supplicazione a parecchi altari; dei ceri
d’implorazione ardevano già in fondo all’abside. Ed egli si
affrettò a recarsi in sacrestia e ad indossare i paludamenti sacri
per dire la sua messa alla cappella di San Vincenzo de’
Paoli.
Ma i ricordi avevano sciolto il
freno, e Pietro era intieramente ripreso dal dolore, mentre seguiva
i riti, facendo da automa i gesti professionali.
Dacchè era tornato da Roma, tre
anni prima, egli viveva nell’angoscia più amara in cui un uomo
possa cadere. Anzitutto, tentando una prima esperienza per
ritrovare la fede perduta, era andato a Lourdes per ottenere la
credenza ingenua del fanciullo che si inginocchia e prega, la fede
primitiva dei giovani popoli, prostrati sotto il terrore
dell’ignoranza. E si era ribellato maggiormente davanti alla
glorificazione dell’assurdo, la decadenza del senso comune,
convinto che la salvezza e la pace degli uomini, dei popoli
dell’oggi, non poteva essere in quella rinunzia puerile alla
ragione.
Poi, ripreso dal bisogno di
amare, pur facendo la parte intellettuale di quella ragione
esigente, aveva giuocato la sua pace in una seconda esperienza,
andando a Roma per vedere se il cattolicismo poteva rinnovellarsi,
tornando allo spirito del cristianesimo primitivo, diventando la
religione della democrazia, la fede che il mondo moderno a
soqquadro ed in pericolo di morte aspettava per pacificarsi e
vivere; e non vi aveva trovato che delle rovine, il tronco fradicio
di un albero inetto ormai a rifiorire in nuove primavere; non vi
aveva udito che lo schianto supremo del vecchio edifizio sociale,
prossimo a sfasciarsi.
Allora, ripiombato nel dubbio
infinito, nello scetticismo completo, era tornato a Parigi,
richiamatovi dall’abate Rose, in nome dei loro poveri, per
dimenticarsi, sacrificarsi, credere in loro, poichè essi soli gli
restavano con le loro spaventose sofferenze; ed allora, dopo tre
anni, aveva veduto quel naufragio della bontà stessa, la carità
inutile e schernita.
Quei tre anni, Pietro li aveva
vissuti in una tormenta sempre più aspra, in cui tutto l’essere suo
era naufragato, la sua fede era morta per sempre e morta persino la
sua speranza di valersi della fede delle masse per la salvezza
comune. Egli negava tutto ormai, non aspettando che la catastrofe
finale, inevitabile, la rivolta, la strage, l’incendio, che
dovevano annientare un mondo colpevole e condannato.
Vigilando, prete senza fede,
sulla fede altrui, faceva castamente, onestamente il suo mestiere,
nell’altera tristezza di non aver potuto abdicare alla sua
intelligenza come aveva abdicato al fremito amoroso delle sue carni
ed al suo sogno di redentore delle genti, sempre in piedi sulla
breccia, in una maestà fosca e solitaria.
E quello scettico disperato, che
aveva toccato il fondo dell’abisso, serbava un’attitudine così
nobile, un contegno da cui spirava un profumo di bontà così pura,
che si era acquistato nella sua parrocchia di Neuilly la fama di un
giovane santo amato da Dio, di cui la preghiera otteneva dei
miracoli. Egli non osservava che la forma esteriore, non aveva che
il gesto del prete ormai, come un sepolcro vuoto in cui non rimane
nemmeno più la cenere della speranza; e delle donne addolorate,
delle parrocchiane in lacrime, lo adoravano, baciandogli la
sottana: ed era una madre torturata di cui la creaturina giaceva in
punto di morte nella culla, che lo aveva scongiurato di chiederne
la guarigione a Gesù, sicura che Gesù gliela avrebbe concessa, in
quel santuario di Montmartre, in cui ardeva il prodigio del suo
Cuore incendiato d’amore.
Frattanto Pietro, vestito dei
paludamenti sacri, era entrato nella cappella di San Vincenzo de’
Paoli. Salì i gradini dell’altare, cominciò a dir messa, e, quando
si volse, con le braccia allargate, per benedire, apparve con la
faccia incavata, la bocca soave e stirata dall’amarezza, gli occhi
tenerissimi, fatti cupi dal dolore.
Non era più il giovane sacerdote,
che, col volto acceso da intensa febbre di tenerezza, partiva per
Lourdes; non era più l’apostolo che partiva per Roma colla fronte
raggiante.
Il suo doppio retaggio restava in
lotta perenne: il padre, a cui doveva la torre inespugnabile della
fronte; la madre, a cui doveva le sue labbra assetate d’amore,
continuavano il conflitto, la battaglia umana del sentimento e
della ragione, in quel volto, oggi solcato dal dolore, in cui, nei
momenti di oblìo, si leggeva lo scompiglio dell’interna
disperazione.
Le labbra confessavano ancora la
sete insaziata di amare e di vivere, una sete che era certo ormai
di non appagare, mentre la fronte altera, la cittadella che gli
imponeva il lutto, si ostinava a non arrendersi, sotto gli assalti
dell’errore.
Ma egli si irrigidiva,
dissimulando lo spavento del nulla in cui si dibatteva, restando
superbo nel contegno, facendo i gesti, profferendo le parole del
rito con maestà.
E la madre, che se ne stava fra
alcune donne genuflesse, la madre che aspettava da lui un
intervento supremo, che lo credeva a colloquio con Gesù per la
salvezza della sua creatura, lo vedeva raggiare, fra il pianto, di
una bellezza d’angelo, nunzio della grazia divina.
Quando, dopo l’offertorio, Pietro
scoprì il calice, ebbe un senso di disprezzo per sè medesimo. La
scossa avuta da lui era troppo profonda e pensava sempre a quelle
cose.
Che fanciullaggini nelle sue due
esperienze di Lourdes e di Roma, che ingenuità da povero essere
smarrito, consumato dalla smania intensa di credere e di amare,
essersi imaginato che la scienza attuale potesse patteggiare in lui
con la fede del nulla, e sopratutto credere che lui, infimo
pretucolo, potesse fare da maestro al papa, deciderlo ad essere un
santo ed a cambiare la faccia del mondo! Ne sentiva una immensa
vergogna.
Poi, era anche la sua idea di
scisma che lo faceva arrossire. Si rivedeva a Roma, col sogno di
scrivere un libro in cui si staccherebbe con violenza dal
cattolicismo per predicare la nuova religione delle democrazie, il
Vangelo epurato, vivo, umano! Che ridicola follìa! Uno scisma!
Aveva conosciuto a Parigi un abate di gran cuore e di grande
ingegno, che aveva tentato di promuoverlo, quel famoso scisma
pronosticato ed aspettato! Ah! pover’uomo, che tristo e derisorio
assunto si era preso, fra l’incredulità universale, la gelida
indifferenza degli uni, gli scherni e le ingiurie degli altri! Se
Lutero ricomparisse ai tempi nostri, finirebbe col morir di fame,
dimenticato, in una soffitta di Batignolles. Uno scisma non può
riuscire dove il popolo non ha più fede e si stacca dalla Chiesa
per mettere le sue speranze altrove. Tutto il cattolicismo, anzi,
tutto il cristianesimo stava per essere travolto nell’abisso,
perchè, all’infuori di alcune massime morali, il Vangelo non era
più un codice sociale possibile. E quella certezza accresceva il
suo tormento, nei giorni in cui finiva col disprezzarsi perchè
celebrava il mistero divino di quella messa, che era diventata per
lui il gesto di una religione defunta.
Pietro, che aveva colmato a metà
il calice col vino dell’ampolla, si lavò le mani e scorse ancor una
volta la madre, col viso spirante calda supplicazione. Allora pensò
che era per lei, per un pensiero pietoso d’uomo vincolato da un
giuramento, che era rimasto il sacerdote senza fede che alimenta la
fede altrui col pane dell’illusione. Ma quell’attitudine eroica,
quel dovere superbo in cui si rinchiudeva, non potevano
scompagnarsi da un’angoscia crescente.
L’onestà la più elementare non
gli consigliava forse di spogliare le vesti sacerdotali, di tornare
fra gli uomini? V’erano dei momenti in cui la falsità della sua
posizione gli metteva la nausea del suo inutile eroismo, ed egli si
chiedeva di nuovo se non era codardo e pericoloso lasciare che le
turbe vivessero nella superstizione. Certo, s’era per molto tempo
stimata necessaria la menzogna di un Dio di giustizia e di
vigilanza, di un paradiso futuro in cui erano compensate tutte le
pene di quaggiù, facendolo servir di conforto alle miserie dei
poveri mortali; ma che inganno, che sfruttamento tirannico dei
popoli, e come sarebbe più virile amputar brutalmente le genti,
dando loro il coraggio di vivere la vita vera, foss’anche nelle
lagrime!
Infatti, se oggi voltavano le
spalle al Cristianesimo, non era perchè sentivano il bisogno di un
ideale più umano, di una religione di salute e di gioia che non
fosse una religione della morte?
Il giorno in cui il concetto
della carità venisse a mancare, il Cristianesimo andrebbe in
isfacelo con esso, perchè era edificato sull’idea della carità
divina che corregge l’ingiustizia del fato, promettendo i premi
futuri a quelli che soffrono quaggiù.
E la carità veniva meno davvero;
i poveri non avevano più fede in lui, irritandosi di fronte a quel
paradiso bugiardo di cui la promessa aveva per tanto tempo
alimentato la loro pazienza, esigendo che non si prorogasse più la
resa di conto della loro parte di felicità fino al di là del
sepolcro.
Un grido di giustizia erompeva da
tutte le labbra; la giustizia su questa terra, la giustizia per chi
ha fame, per chi ha sete, per quelli che l’elemosina è stanca di
soccorrere e che dopo diciotto secoli di Vangelo sono ancora senza
pane.
Quando Pietro ebbe, coi gomiti
sulla tavola dell’altare, vuotato il calice, dopo avervi spezzato
l’ostia, si sentì invaso da una angoscia ancora più intensa.
Era dunque una terza esperienza
che s’iniziava in lui, quella lotta suprema della giustizia contro
la carità in cui il suo cuore e la sua ragione s’erano impegnati,
in quell’immensa Parigi, velata di cenere, gravida di un arcano
così terribile?
L’anelito del divino combatteva
in lui contro l’intelligenza dominatrice. Come si potrebbe mai
appagare nelle turbe la sete del mistero? La scienza poteva
bastare, toltine pochi eletti, per appagare i desideri, cullare il
dolore, esaudire il sogno delle genti? E che ne sarebbe di lui
stesso nel fallimento di quella carità che era la sola scusa che lo
tenesse in piedi da tre anni, occupando tutte le sue ore, dandogli
l’illusione di sacrificarsi agli altri, di essere utile?
Ad un tratto, la terra gli
mancava sotto i piedi, non udiva che il grido del popolo, il muto
secolare che chiedeva giustizia, invocando e minacciando di
riprendere la sua parte, trattenuta con la violenza e
l’astuzia.
Nulla più poteva ritardare
l’inevitabile catastrofe, la lotta fratricida delle classi che
distruggerebbe il mondo decrepito, condannato a sparire sotto il
cumulo dei suoi delitti. Ne aspettava d’ora in ora lo sfacelo.
Parigi sommersa nel sangue, Parigi in fiamme, in una tristezza
atroce.
E nel suo raccapriccio della
violenza si sentiva agghiacciato, non sapeva dove trovare la fede
novella che doveva scongiurare il pericolo, conscio che il problema
sociale formava una cosa stessa col problema religioso, ed era
l’unico in giuoco nel terribile e quotidiano travaglio di Parigi;
ma, troppo turbato egli stesso, messo troppo in disparte dal suo
carattere sacerdotale, troppo straziato dal dubbio e dall’impotenza
per dire dove si trovassero la verità, la salute, la vita. Ah!
essere sani, vivere; appagare finalmente la ragione ed il cuore
nella pace, nel lavoro placido, semplice ed onesto che l’uomo è
venuto a compiere sulla terra!
La messa era finita e Pietro
scendeva dall’altare, quando la madre in lagrime accanto a cui egli
passava, afferrò con le mani tremanti un lembo del camice e lo
baciò fervidamente, appassionatamente, come si bacia la reliquia
del santo da cui si aspetta la salvezza.
Essa lo ringraziava del miracolo
che aveva certamente ottenuto, sicura di trovare la sua creatura
guarita.
Egli fu profondamente scosso da
quell’amore, da quella fede ardente, sebbene sentisse con maggior
amarezza il dolore di non essere il ministro sovrano che quella
donna lo credeva, il santo capace di ottenere una proroga alla
morte. Ma la rimandava confortata, rincorata, e fu con invocazione
ardente che scongiurò la Forza ignota e cosciente (se esisteva!),
di venir in aiuto a quella misera creatura. Poi, quando si fu
svestito in sacrestia e si ritrovò fuori, davanti alla basilica,
sferzato dal rigido soffio invernale, fu ripreso da un brivido
intenso, e si sentì agghiacciato mentre guardava attraverso alla
nebbia se il nembo d’ira e di giustizia non aveva già spazzato
Parigi, se non era già matura la catastrofe che doveva inghiottirla
una mattina, non lasciando sotto il cielo di piombo, che
l’appestata palude delle sue macerie. Subito si mosse per far la
commissione dell’abate Rose, e seguendo la via Norvins, sulla
cresta di Montmartre, giunse in via dei Salici, di cui scese l’erto
pendìo, fra mura muscose, dall’altro lato di Parigi.
Le tre lire che teneva in mano,
in fondo alla tasca della sottana, gli mettevano in cuore un misto
di emozione pietosa e di sordo sdegno contro la vana, l’inutile
carità. Man mano che scendeva però le file interminabili di scale
delle terrazze, certi luoghi miserabili intraveduti da lui, gli
stringevano il cuore di pietà infinita. V’era in quel punto tutto
un rione nuovo, in costruzione, lungo le larghe vie aperte dopo i
grandi lavori del Sacro Cuore.
Delle case borghesi a molti
piani, sorgevano già in mezzo ai giardini sventrati, fra terreni
incolti, ancora cinti di steccati.
E le loro eleganti facciate d’un
bianco d’intonaco fresco, facevano apparir più tetre, più lebbrose
le vecchie bicocche cadenti, ancora in piedi, lì vicino: delle
taverne losche con mura color di sangue, dei quartieri di povertà e
di dolore, con case luride e nere, dove il gregge umano si
accatastava in orribile promiscuità.
In quel giorno, sotto il cielo
fosco, la melma inondava il lastrico sfondato dai carri, un’umidità
glaciale invadeva le mura, una tristezza infinita spirava da tanto
sudiciume e da tanta miseria.
Pietro che era andato fino alla
via Mercadet, tornò indietro, ed in via dei Salici, certo di non
sbagliare, entrò nel cortile di una specie di caserma o d’ospedale,
cortile cinto da tre fabbricati irregolari. Era una cloaca dove le
immondizie accumulate nei due mesi di gelo, si scioglievano ora: un
odore fetido saliva da quell’immondo lago di fanghiglia.
La casa era smantellata, degli
antri si aprivano boccheggianti come ingressi di cantina, dei fogli
di carta screziavano i vetri sucidi, dei cenci infami pendevano dai
ballatoi come bandiere di morte. In fondo alla botteguccia che
serviva da portineria, Pietro non vide che un uomo infermo,
ravvolto nei brandelli senza nome di una vecchia coperta di
cavallo.
— Sta qui un vecchio operaio,
chiamato Laveuve? Che scala, che piano?
L’uomo non rispose, sbarrando due
occhi stralunati da idiota che si spaventa.
Probabilmente il portinaio era
fuori.
Il prete aspettò per un momento,
poi, scorgendo una bambina in fondo alla corte, si fece animo ed
attraversò in punta di piedi la cloaca.
— Figliuola, conosci qui in casa
un vecchio operaio che si chiama Laveuve?
La ragazzetta, di cui la magra
personcina non era coperta che da una veste di tela rosa in
brandelli, batteva i denti, con le mani deturpate dai geloni. Alzò
il viso delicato e bello sotto l’aspro morso del freddo.
— Laveuve, non so, non so…
E con gesto inconscio da
mendicante stendeva una delle povere manine, gonfie, sanguinanti.
Poi, quando ebbe ricevuto da Pietro una moneta d’argento si diede a
galoppare come una capra scappata, in mezzo alla fanghiglia,
cantando con voce stridula:
— Non so, non so…
Pietro si decise a seguirla. Era
sparita in uno degli antri spalancati, ed egli salì dietro di lei
una scala scura e fetida, dai gradini logori, così viscida per
buccie di legumi, che dovette aggrapparsi alla corda unta mercè cui
si saliva. Ma tutte le porte erano chiuse, bussò inutilmente a
parecchie, non ottenendo che all’ultima dei ruggiti sordi, quasi
quasi qualche belva disperata stesse rinchiusa là entro.
Tornato nel cortile esitò, poi si
mise per un’altra scala ‒ e qui delle grida acute, grida da bambino
sgozzato, lo assordarono. Salì seguendo quel rumore e finì col
trovarsi davanti ad una camera spalancata in cui un bambino, solo,
legato ad una seggiolina, probabilmente perchè non cadesse, urlava
senza riprender fiato. Scese di nuovo, scombussolato per tanta
penuria e tanto squallore.
Ma una donna rincasava portando
tre patate nel grembiale, ed egli la interrogò, mentre ella
guardava con diffidenza la sua sottana.
— Laveuve, Laveuve; non potrei
dire. Se ci fosse la portinaia saprebbe forse… Capirete abbiamo
cinque scale… non ci si conosce tutti, eppoi la gente cambia così
spesso… Ad ogni modo, guardate laggiù in fondo.
La scala del fondo era la più
orribile di tutte, coi gradini torti, le mura viscide, come
stillanti un sudore di agonia.
Ad ogni pianerottolo, le porte
soffiavano un lezzo pestifero, e da ogni casa uscivano lamenti,
alterchi, un atroce tanfo di miseria. Un uscio si aprì,
sbattacchiando, ed apparve un uomo che trascinava una donna pei
capelli mentre tre marmocchi piangevano.
Al secondo piano, in una visione
rapidamente intraveduta, Pietro notò una ragazza gracile che
tossiva, col petto già avvizzito, portando attorno con impeto un
lattante a cui, disperata, non aveva più latte da dare.
Poi, in un appartamento vicino,
scorse il gruppo straziante di tre esseri, coperti appena in parte
da cenci, esseri senza età nè sesso, i quali nell’assoluto
squallore di una camera vuota, mangiavano voracemente nella stessa
scodella una zuppa che nessun cane avrebbe accettato. Alzarono
appena il capo, brontolando, senza rispondere alle domande.
Pietro stava per scendere, quando
in cima, all’ingresso di un androne, tentò per l’ultima volta di
bussare ad un uscio.
Gli aprì una donna di cui i
capelli arruffati cominciavano già ad incanutire, sebbene non
dovesse avere più di quaranta anni. Le sue labbra scolorite, gli
occhi incavati nella faccia gialla, spiravano una stanchezza
assoluta, avevano un’espressione di umiltà e di timore continuo
sotto i colpi accaniti della miseria.
Si sbigottì nel vedere la sottana
e balbettò inquieta:
— Entrate, entrate, signor
abate.
Ma un uomo che Pietro non aveva
veduto sulle prime, un operaio sui quarant’anni anche lui, alto,
scarno, calvo, d’un fulvo brizzolato, coi capelli ed i baffi radi,
fece un gesto impetuoso, la minaccia abbozzata di gettare il prete
fuori dell’uscio. Si frenò peraltro, e, sedendo accanto ad una
tavola sbilenca, gli voltò le spalle con ostentazione. E siccome
v’era in camera una ragazzetta bionda, dagli undici ai dodici anni,
col viso affilato e dolce, e quell’aria intelligente ed un po’
vecchia che la gran miseria dà ai bambini, la chiamò e se la tenne
fra le ginocchia, come per preservarla dal contatto della
sottana.
Col cuore stretto da
quell’accoglienza, Pietro leggendo la miseria assoluta di quella
famiglia, nella stanza nuda e senza fuoco, nella tetra tristezza di
quelle tre creature, si decise però a fare la sua domanda:
— Non conoscereste in questa
casa, signora, un vecchio operaio che si chiama Laveuve?
La donna che tremava ora di
averlo introdotto, vedendo che spiaceva evidentemente al suo uomo,
tentò in atto timido di combinar le cose.
— Laveuve, Laveuve, no… Di’ su,
Salvat, hai udito? lo conosci forse tu?
Salvat si limitò a far un alzata
di spalle; ma la piccina non potè tenere la lingua in freno.
— Di’ su, mamma Teodora… E’ forse
il Filosofo.
— Un ex‒imbianchino ‒ continuò
Pietro ‒ un vecchio ammalato che non può più lavorare.
Questa volta, madama Teodora
comprese:
— In tal caso, sì, è lui… è lui…
Lo chiamiamo il Filosofo, un soprannome che gli hanno dato nel
vicinato. Ma può darsi benissimo che si chiami Laveuve.
Alzando il pugno verso il
soffitto, verso il cielo, Salvat parve protestare contro l’infamia
di una società e d’un Dio che lasciavano i vecchi lavoratori morir
di fame come cavalli bolsi.
Ma non parlò, ricadde in un
silenzio tetro e profondo, in quella specie di bieca fantasticheria
in cui era già immerso, all’apparire di Pietro.
Faceva il meccanico e guardava
persistentemente la borsa dei suoi ferri posta sul tavolo, una
piccola borsa di pelle, che un oggetto qualsiasi gonfiava da una
parte.
Pensava probabilmente al lungo
sciopero, alla sua inutile ricerca di lavoro nei due ultimi mesi di
quell’inverno terribile. O fors’anche vedeva nella fantasticheria
incendiaria che gli illuminava i grandi occhi azzurri, strani,
torbidi ed ardenti, la rivincita prossima e sanguinaria.
Ad un tratto, si accorse che sua
figlia aveva preso la borsa, procurando di aprirla per vedere. Ebbe
un fremito e parlò finalmente con la bocca amara, nell’improvvisa
emozione che lo faceva impallidire.
— Celina, lascia un po’ stare!
T’ho vietato di toccare i ferri.
Prese la borsa e la pose dietro
di sè, vicino alla parete, con grande cura.
— E così, signora? ‒ domandò
Pietro ‒ quel Laveuve sta a questo piano?
Madama Teodora consultò Salvat
con un’occhiata paurosa.
Non era d’avviso di maltrattare i
curati quando si prendevano la briga di venire, perchè qualche
volta c’era da guadagnare con loro. E quando si avvide che Salvat,
ripiombato nelle sue fosche meditazioni, la lasciava libera di fare
a modo suo, si profferse subito.
— Se il signor curato desidera,
lo accompagno. E’ per l’appunto in fondo all’andito. Ma bisogna
esser pratici, perchè vi sono degli altri gradini da salire.
Celina vedendo un divertimento in
quella gita, scappò dalle ginocchia del padre per accompagnare il
prete anche lei.
E Salvat rimase solo nella camera
di squallore e di angoscia, d’ingiustizia e d’ira, senza legna,
senza pane, perseguitato dal suo sogno di fuoco, inchiodando di
nuovo i suoi occhi sulla borsa, come se là, in quegli arnesi,
stesse la guarigione del mondo.
Infatti bisognò fare qualche
gradino e Pietro, seguendo madama Teodora e Celina, si trovò in una
specie d’angusto solaio, sotto il tetto, una tana di pochi metri
quadrati in cui non si poteva star ritti.
La luce non entrava che da un
abbaino, ma siccome la neve ostruiva il vetro, dovettero lasciar la
porta spalancata per vederci. Penetrava invece l’acqua della neve
che si scioglieva a goccia a goccia, inondando l’ammattonato.
Dopo quelle lunghe settimane di
freddo intenso, una umidità scialba sommergeva tutto nel suo
brivido. E colà, senza una seggiola, senza neppure un pezzo di
legno per tavola, in un angolo del suolo nudo, Laveuve giaceva
sopra un mucchio di cenci luridi, come una bestia quasi crepata
sopra un mondezzaio.
— Guardate! ‒ disse Celina con la
sua voce strascicante, ‒ eccolo qua. Quest’è il Filosofo.
Madama Teodora si era chinata per
origliare se viveva ancora.
— Sì, ‒ rispose, ‒ credo che
dorma. Oh! se mangiasse tutti i giorni, starebbe bene. Ma come si
fa? Non ha più nessuno, e quando si è sui settanta il meglio
sarebbe di buttarsi in acqua. Nel suo mestiere d’imbianchino, fin
dai cinquant’anni alle volte non si può più lavorare sulle scale.
Lui ha trovato sulle prime dei lavori a livello. Poi ha avuto la
fortuna di custodire dei cantieri. Ed ora è finita, non lo vogliono
in nessun luogo, e da due mesi è piombato in questo cantuccio per
morire. Il padrone di casa non ha avuto il coraggio di buttarlo in
strada, sebbene non sia la voglia di farlo che gli manchi… Noi, gli
si porta alle volte un po’ di vino, qualche crosta di pane… Ma
quando non si ha più nulla per sè, come volete che si dia agli
altri?
Inorridito, Pietro guardava
quella spaventosa rovina, quello che cinquant’anni di lavoro, di
miseria e d’ingiustizia sociale avevano fatto d’un uomo. Finì col
distinguere la testa bianca, logora, depressa, sformata, tutti i
solchi messi da un arduo lavoro senza speranza sopra una faccia
umana.
La barba incolta che invadeva i
lineamenti, dava all’uomo un aspetto di vecchio cavallo intonso;
aveva le mascelle torte, i denti erano caduti, gli occhi vitrei, il
naso affondava nella bocca. E quello che colpiva specialmente in
lui era quell’aspetto di bestia rovinata dalle fatiche del
mestiere, logora, distrutta, buona solo per lo scannatoio.
— Ah! povera creatura! ‒ mormorò
il prete, fremendo. ‒ E lo lasciano morire di fame così, solo,
senza soccorso? E nessun ospedale, nessun ospizio l’ha
raccolto?
— Caspita! ‒ riprese madama
Teodora con la sua voce dolente e rassegnata ‒ gli ospedali sono
per gli ammalati, e non è ammalato Laveuve; si esaurisce
semplicemente per difetto di forze. Eppoi, non è sempre facile di
trattare con lui; sono venuti anche poco tempo fa per metterlo in
un asilo, ma non vuol star rinchiuso, risponde delle villanie a
quelli che lo interrogano, tacendo che corre voce che beva e che
sparli dei signori… Ah! grazie al cielo sarà liberato fra
poco!
Pietro si chinò vedendo che
Laveuve spalancava gli occhi, e parlandogli con tenerezza gli disse
che veniva per conto di un amico a recargli un po’ di danaro,
perchè si comperasse le cose più necessarie. Sulle prime il
vecchio, vedendo la veste da prete, aveva borbottato delle
parolacce. Ma serbava nel suo grande sfinimento la malizia
birichina dell’operaio di Parigi.
— Se è così, ne berrei volentieri
un goccio ‒ disse con voce chiara ‒ e mangerei un boccone di pane
se il danaro basta, perchè da due giorni non ne sento il
sapore.
Celina si profferse, e madama
Teodora la mandò a prendere una micca ed un litro coi danari
dell’abate Rose.
E nel frattempo disse a Pietro
che Laveuve doveva entrare nell’asilo degli Invalidi del lavoro,
un’Opera pia, presieduta dalla baronessa Duvillard, ma
probabilmente l’inchiesta aveva dato dei risultati sfavorevoli,
perchè non se n’era fatto nulla.
— La baronessa Duvillard? Ma io
la conosco, andrò oggi stesso da lei! ‒ esclamò Pietro di cui il
cuore sanguinava. ‒ E’ impossibile lasciar un uomo in questo
stato.
E, siccome Celina tornava col
pane e col litro, sollevarono tutti insieme Laveuve, lo posero più
saldo sul suo mucchio di cenci, gli diedero da bere e da mangiare,
lasciandogli vicino l’avanzo del pane, un gran pane di quattro
libbre, e quello del vino, raccomandandogli però di non finirlo
subito se non voleva restar soffocato.
— Il signor abate dovrebbe darmi
il suo indirizzo pel caso in cui io avessi qualcosa da comunicargli
‒ disse madama Teodora, quando si ritrovò davanti alla sua
porta.
Pietro non aveva biglietti da
visita, e tornarono in camera tutti e tre. Ma Salvat non era più
solo: discorreva molto piano, molto presto, vicin vicino, bocca a
bocca, con un giovine sui vent’anni. Questi, esile, bruno, coi
capelli tagliati a spazzola e la barba nascente, aveva occhi
chiari, un naso dritto, labbra sottili in una faccia pallida
segnata da alcune lentiggini e lampeggiante di viva intelligenza.
Rabbrividiva sotto la giacca logora, con la fronte dura e
caparbia.
— E’ il signor abate che vuoi
lasciarmi il suo indirizzo per l’affare del Filosofo ‒ spiegò
madama Teodora, indispettita di trovare un estraneo.
I due uomini fissarono il prete,
poi si sogguardarono con espressione terribile, e subito tacquero,
non dissero più sillaba nel freddo glaciale che pioveva dalla
vôlta.
Salvat andò a prendere la borsa
dei ferri con nuove e grandi precauzioni.
— Dunque torni a cercar lavoro? ‒
chiese madama Teodora.
Non rispose, facendo un atto di
collera, quasi per dire che non voleva più saperne del lavoro
giacchè da tanto tempo il lavoro non voleva più saperne di
lui.
— Tenta ad ogni modo di riportar
qualche cosa, sai che non abbiamo nulla in casa… A che ora
torni?
Con un altro gesto parve che egli
significasse che tornerebbe quando gli fosse possibile, forse mai.
E, per quanto volesse ostentar l’eroismo, delle lagrime offuscarono
i suoi torbidi occhi azzurri, accesi da strana fiamma, ed afferrò
sua figlia, l’abbracciò impetuosamente, disperatamente, poi se ne
andò con la borsa sotto al braccio, seguìto dal giovane
compagno.
— Celina ‒ riprese madama Teodora
‒ da’ la tua matita al signor abate. Così, mettetevi qui, sarete
più comodo per scrivere.
Poi, quando Pietro ebbe preso
posto sulla seggiola, poco prima occupata da Salvat:
— Non è cattivo ‒ proseguì per
scusare la poca creanza del suo uomo ‒ ma ha avuto tante seccature
nella vita che s’è fatto un po’ rustico. Appunto come quel giovane
che avete veduto qui, il signor Vittorio Mathis. Anche lui,
poveretto, non ha fortuna, ed è un giovane molto bene educato,
molto colto, di cui la madre, una vedova, ha appena quanto basti
per mangiare un pezzo di pane. Si capisce dunque, non è vero? che i
guai turbino il loro cervello e che parlino di far saltare in aria
il mondo. Per conto mio, queste idee non le ho, ma le compatisco in
loro, oh! con tutta l’anima.
Turbato, incuriosito dall’ignoto
e dal terribile che intuiva attorno a sè, Pietro non si affrettò a
scrivere l’indirizzo, ascoltandola, spingendola alle
confidenze.
— Se sapeste, signor abate, la
sorte di quel povero Salvat, un trovatello, senza padre, nè madre,
che è stato per anni sul lastrico, che ha dovuto fare un po’ di
tutti i mestieri per vivere! Col tempo si è messo alla meccanica ed
era un buon operaio, ve lo affermo, molto destro e laborioso. Ma
aveva già le sue idee, litigava, voleva tirare dalla sua i
compagni, per cui non poteva restare in nessun posto. Finalmente, a
trent’anni, ha fatto la corbelleria di partire per l’America con un
ingegnere che lo ha sfruttato laggiù, a segno che dopo sei anni è
tornato infermo e senza un soldo… Devo dirvi che aveva sposato la
mia sorella minore Leonia, morta prima della sua partenza per
l’America, lasciandogli la piccola Celina che aveva un anno. Io ero
con mio marito allora, Teodoro Labitte, un muratore; e non lo dico
per vantarmi, ma, per quanto mi rovinassi gli occhi sul cucito, mi
picchiava in modo da lasciarmi in terra come morta. Ha finito col
piantarmi, prendendo il largo con una giovinetta di vent’anni, il
che mi ha fatto più piacere che altro… E, naturalmente, quando
Salvat è tornato e mi ha trovata sola con la piccola Celina, che
m’aveva affidata partendo, e che mi chiamava mamma, ci siamo messi
a vivere insieme per la forza delle circostanze. Non siamo
maritati, ma fa lo stesso, non è vero, signor abate?
Era rimasta un po’ confusa però,
e riprese, per mostrare che aveva della gente per bene in
famiglia:
— Non ho avuto fortuna, io, ma ho
un’altra sorella, Ortensia, che ha sposato un impiegato, un certo
Chretiennot, che sta in un bell’appartamento del boulevard
Rochechouart. Eravamo tre di un secondo letto, Ortensia, l’ultima;
Leonia, che è morta, ed io, la maggiore, Paolina. Ed ho anche un
fratellastro, Eugenio Toussaint, che ha dieci anni più di me, un
meccanico anche lui che lavora, dal tempo della guerra in poi nella
stessa casa, l’officina Grandidier, a cento passi da qui, in via
Mercadet. Per disgrazia ha avuto un colpo, poco tempo fa… In quanto
a me, non ci vedo più, mi sono sciupata gli occhi cucendo delle
dieci ore di fila. Adesso non posso fare un rammendo, senza che le
lagrime mi appannino la vista. Ho cercato di fare la serva
avventizia, ma non trovo più lavoro, la disdetta ci perseguita. E
così non abbiamo più nulla, siamo in una miseria completa, senza
cibo per due o tre giorni di seguito alle volte, una vitaccia da
bestie, che mangia a caso quello che trova, e, con questi ultimi
due mesi di freddo intenso, che ci hanno agghiacciato in modo da
credere, alle volte, la sera, che non ci si desterebbe più… Come si
fa! non sono mai stata felice io, prima percossa, oggi sciupata,
abbandonata in un angolo, rimasta al mondo non so perchè.
Le tremava la voce e i suoi occhi
rossi si inumidivano, e Pietro sentì che attraversava la vita
lagrimando, da brava donna, senza forza di volontà, quasi
cancellata già dall’esistenza, accasata senza amore, secondo i
capricci della sorte.
— Oh! ‒ riprese ‒ non mi lagno di
Salvat. E’ un brav’uomo che sogna la felicità di tutti, e non beve
e lavora quando può. Soltanto, questo è sicuro, che, se non si
occupasse di politica, lavorerebbe di più. Non si può discutere coi
compagni, andare alle adunanze ed al lavoro. Sbaglia in questo, è
evidente… Ma ciò non toglie che egli abbia ragione di lamentarsi,
perchè ha avuto una disdetta unica: tutti i guai gli sono piovuti
addosso, lo hanno schiacciato. Un santo stesso perderebbe la testa,
e si capisce che un povero disgraziato come lui finisca col
diventare idrofobo… Da due mesi non ha trovato che un uomo pietoso,
uno scienziato, che sta lassù, sul poggio, un certo Guglielmo
Froment, che gli dà qualche volta del lavoro, tanto da far la
minestra.
Molto sorpreso di udire il nome
del fratello, Pietro si disponeva a fare alcune domande: poi una
sensazione strana, un misto di prudenza e di timore, lo indusse a
tacere. Guardò Celina che ascoltava in piedi, davanti a lui, muta,
con l’aspetto gracile e serio. E madama Teodora vedendo che
sorrideva alla piccina, soggiunse un’ultima riflessione:
— Ecco! E’ sopratutto l’idea di
quella bambina che lo mette fuori di sè. L’adora! ammazzerebbe
tutti quanti quando la vede andar a letto senza cena. E’ così
carina, imparava così bene alla scuola comunale!
Pietro, che aveva finalmente
scritto l’indirizzo, fece scivolare uno scudo nelle mani della
bambina e per tagliar corto ai ringraziamenti si affrettò a
dire:
— Sapete dove trovarmi ora, se
aveste bisogno di me per Laveuve. Ma io mi occuperò subito del caso
suo e spero che, senz’altro, verranno a prenderlo questa
sera.
Madama Teodora non ascoltava,
profondendosi in benedizioni, mentre Celina, colpita di trovarsi in
mano uno scudo, mormorava:
— Oh! quel povero babbo che è
andato a caccia di soldi! Se corressi a dirgli che per oggi c’è da
mangiare?
Ed il prete, che era già
nell’andito, udì la donna rispondere:
— E’ lontano, se ha sempre
camminato… Ma forse tornerà.
Mentre Pietro fuggiva
dall’orribile casa dolente, con la testa in fiamme, il cuore invaso
di tristezza, ebbe la sorpresa di scorgere Salvat e Vittorio
Mathis, fermi in un angolo dell’immondo cortile, nelle esalazioni
pestilenziali della cloaca: erano scesi per continuare il colloquio
interrotto in casa, e discorrevano di nuovo piano e prestissimo,
bocca a bocca, assorti nella foga che schizzava dai loro sguardi;
ma udirono i passi, riconobbero l’abate; e fatti improvvisamente
freddi e calmi non soggiunsero più parola, scambiando una ruvida
stretta di mano. Vittorio risalì verso Montmartre, Salvat esitò,
con l’aspetto d’un uomo che consulta il destino. Poi, avviandosi a
casaccio, bieco, rizzò la scarna persona da lavoratore stanco ed
affamato ed entrando in via Mercadet, mosse verso Parigi, con la
borsa sotto il braccio.
Per un attimo, Pietro ebbe
l’impulso di corrergli dietro, di gridargli che la sua piccina lo
richiamava. Ma si sentì ripreso dallo stesso turbamento di prima:
un senso di discrezione, di paura, di sorda persuasione che nulla
arresterebbe il destino.
Ed egli stesso aveva perduta la
calma, non era più sopito nel gelido annientamento del
mattino.
Ritrovandosi fra le nebbie umide
della via, era ripreso dalla sua antica febbre di carità che
l’aspetto di miserie così inaudite ridestava in lui. No, no! I
dolori umani erano troppi; egli voleva continuare la lotta, salvar
Laveuve, render un po’ di gioia a quella povera gente.
La nuova esperienza gli
s’imponeva in quella Parigi che aveva veduto così velata di cenere,
così misteriosa e perturbante sotto la minaccia dell’inevitabile
giustizia.
E sognava un sole di fecondità e
di salute che facesse dell’immensa città il campo fertile, da cui
sorgesse la società più virtuosa del domani.
II.
Quella mattina, come quasi sempre
d’altronde, v’era una colazione di intimi in casa Duvillard; pochi
amici i quali più che invitati, venivano spontaneamente.
E nella glaciale giornata di
umidità e di nebbia, la principesca palazzina di via
Godot-de-Mauroy sul boulevard della Maddalena, era fiorita delle
corolle più rare, una delle passioni della baronessa che trasmutava
le sale alte e sfarzose, piene di meraviglie artistiche, in serre
tepide e fragranti, dove la triste luce scialba di Parigi diventava
di una dolcezza blanda, infinitamente soave.
Le sale di ricevimento erano a
pianterreno e davano sull’ampio cortile, preceduto da un giardino
d’inverno, che serviva da atrio vetrato, ed in cui stavano sempre
due servitori in livrea verde cupo e oro.
La celebre galleria di quadri,
stimata parecchi milioni, occupava tutta l’ala
settentrionale.
E lo scalone, celebre anch’esso
per sfarzo, metteva all’appartamento abitato di solito dalla
famiglia, una sala rossa, un salottino azzurro ed argento, uno
studio, dalle pareti rivestite di cuoio antico, una sala da pranzo
addobbata di verde pallido e mobiliata all’inglese, tacendo della
camera da letto e degli abbigliatoi.
La palazzina, eretta sotto Luigi
XIV, serbava una maestà aristocratica, temperata in certo modo ed
assoggettata ai gusti voluttuosi della borghesia che da un secolo
regnava trionfante, mercè l’onnipotenza moderna dell’oro.
Il mezzodì non era ancora
suonato, quando il barone, anticipando contro il solito, entrò pel
primo nel salottino azzurro e argento.
Era un uomo sui sessanta, alto e
robusto, col naso grosso, le guancie massiccie, la bocca larga,
tumida, con zanne di lupo ancora belle. Calvo da poco tempo, si
tingeva i capelli, come si radeva la barba, dacchè era diventata
bianca. L’audacia ardeva nei suoi occhi grigi, la conquista vibrava
nel suo riso. E tutta la sua faccia esprimeva l’autorità di quella
conquista, la sovranità del padrone senza scrupoli, che usava ed
abusava del potere rubato e serbato dalla sua casta.
Fece alcuni passi, fermandosi nel
vano della finestra, vicino ad un mirabile canestro di orchidee.
Sul camino, sulla tavola, delle ciocche di mammole diffondevano una
fragranza sottile: poi si allungò in uno dei seggioloni di raso
azzurro, lamato d’argento, nella soavità soporifica del profumo,
nel silenzio tiepido che pioveva dagli addobbi.
Prese un giornale in tasca e si
diede a rileggere un articolo, mentre attorno a lui la palazzina
tutt’intera evocava la sua immensa ricchezza, la sua possa sovrana,
tutta la storia del secolo che lo aveva innalzato al potere.
A diciotto anni, nel 1788,
Gerolamo Duvillard, l’avo suo, figlio di un avvocatuccio del
Poitou, era venuto a Parigi come scrivano di notaio, ed
intelligente, ostinato, cupidissimo, aveva guadagnato i suoi primi
tre milioni, prima coll’aggio sui fondi nazionali, poi come
fornitore degli eserciti dell’impero.
Suo padre, Gregorio Duvillard,
figlio di Gerolamo, nato nel 1805, il vero grand’uomo della
famiglia, quegli che aveva regnato pel primo in via
Godot-de-Mauroy, dopo aver avuto dal re Luigi Filippo il titolo di
barone, restava uno degli eroi della finanza moderna per gli
scandalosi guadagni fatti da lui durante la monarchia di luglio e
sotto il secondo impero e pei furti celebri delle sue speculazioni,
ferrovie, miniere, l’istmo di Suez.
Ed Enrico, nato nel 1836, non si
era dato sul serio agli affari che a trentacinque anni, dopo la
guerra, alla morte del barone Gregorio, ma con una tal cupidigia
che in un quarto di secolo aveva raddoppiato le sue sostanze.
Era il corruttore, il divoratore
che deturpava ed inghiottiva tutto ciò che toccava, ed anche il
tentatore, il compratore delle coscienze in vendita, avendo egli
l’intuito della lotta dei tempi nuovi contro la democrazia affamata
ed impaziente dell’oggi. Inferiore al padre ed all’avo, avendo la
tara del sensualismo, con un minor istinto di conquista ed una
smania maggiore di godimento, era comunque un uomo terribile, un
trionfatore epicureo, che operava a colpo sicuro, arraffando dei
milioni ad ogni colpo di rastrello, trattando da pari a pari coi
Governi ed in grado di mettersi in tasca, se non tutta la Francia,
almeno un Ministero.
In un quarto di secolo, in tre
generazioni, la sovranità si era incarnata in lui, già minacciata e
scossa dalla bufera del domani.
E la sua faccia a volte pareva
ingigantisse, diventando la borghesia stessa, quella che nella
ripartizione dell’89 ha preso ogni cosa, s’è ingrassata alle spese
del quarto Stato e non vuol restituirgli nulla.
L’articolo, che il barone
rileggeva in un giornalucolo d’un soldo, lo interessava.
La Voce del Popolo era un foglio
chiassoso, il quale, sotto colore di difendere la giustizia, e la
moralità offese, bandiva ogni mattina un nuovo scandalo, colla
speranza di far salire la tiratura. Quel giorno vi figurava in
lettere di scatola il titolo: «L’affare delle Ferrovie africane, un
benefizio di cinque milioni, due ministri venduti, trenta deputati
e senatori compromessi». Poi il redattore capo, il famoso Sagnier,
annunziava, in un articolo odiosamente feroce, che pubblicherebbe
la lista dei trentadue parlamentari di cui il barone Duvillard
aveva comperate le voci, all’epoca del voto della Camera sulle
Ferrovie africane. A queste notizie si associava la storia
romanzesca delle avventure di un certo Hunter, oggi latitante, che
il barone aveva impiegato come intermediario.
Con la massima calma il barone
ricominciava le frasi, pesando ogni parola, e, sebbene fosse solo,
si stringeva nelle spalle, parlava forte nella placida sicurezza di
un uomo che è al coperto e sa di essere troppo potente perchè lo si
possa molestare.
— Che imbecille! Ne sa ancora
meno di quanto dice.
Ma giungeva per l’appunto un
primo commensale, un giovane sui trentaquattro anni vestito con
eleganza, bell’uomo bruno, con occhi ridenti, naso fine, barba e
capelli crespi, e qualcosa di sventato, di leggero nel passo,
un’aria di uccello. Quel giorno, per eccezione, sembrava nervoso,
inquieto, con sorriso studiato.
— Ah! siete voi, Duthil? ‒ disse
il barone, alzandosi; ‒ avete letto?
E gli mostrò la Voce del Popolo,
che ripiegava per metterla in tasca.
— Ma sì, ho letto… E’ insensato!
Come mai Sagnier ha potuto procurarsi la lista dei nomi?… C’è
dunque un traditore fra noi?
Il barone lo guardava, pacato,
divertendosi della sua ansia segreta. Figlio di un notaio di
Angoulême, quasi povero e molto onesto, eletto ancor giovanissimo a
deputato, mercè la buona fama del padre, Duthil conduceva a Parigi
una vita da gaudente, la vita di ozio e di piaceri già condottavi
altre volte quando era studente; ma la sua graziosa garçonnière di
via Suresnes, i suoi successi di bel giovine nel vortice di donne
in mezzo a cui viveva, gli costavano caro, e si era quindi adattato
allegramente, privo com’era di senso morale, a tutte le
transazioni, a tutte le decadenze, da uomo leggiero e superiore, da
simpatico ragazzo incosciente che non dà nessuna importanza alle
bazzecole di questo genere.
— Eh! via! ‒ disse infine il
barone; ‒ l’ha poi davvero quella lista, Sagnier? Ne dubito perchè
non c’è lista; Hunter non ha certo commesso la balordaggine di
farne una. Eppoi, che monta? E’ un affare dei soliti, e non si è
fatto che quello che si fa sempre in casi consimili.
Inquieto per la prima volta in
vita sua, Duthil lo ascoltava col bisogno di sentirsi
assicurato.
— Ah! lo dite anche voi, eh! ‒
esclamò. ‒ Gli è quello che pensavo; non è il caso di fare tanto
chiasso.
Procurava di ritrovare la sua
allegria non ricordando neppur precisamente come avesse potuto
incassare una diecina di mille lire in quell’avventura a titolo di
prestito o sotto colore di una pubblicità fittizia, perchè Hunter
aveva mostrato una grande scaltrezza nel rispettare il pudore delle
coscienze anche le meno verginali.
— No, non è il caso di far tanto
chiasso, ‒ ripetè Duvillard, che si divertiva dello sgomento di
Duthil. ‒ E, d’altronde, si sa; vi sono certuni che cadono sempre
in piedi! Avete veduto Silviana?
— La lascio or ora ed è in furore
contro di voi. Ha saputo questa mattina che il suo affare della
Commedia era andato in fumo.
All’improvviso una vampa di
collera imporporò la faccia del barone. Egli, così calmo, così
beffardo poc’anzi di fronte alla minaccia dello scandalo delle
Ferrovie africane, perdeva la testa, col sangue acceso, quando si
trattava di quella creatura, l’ultima ed imperiosa passione dei
suoi sessant’anni.
— Come, in fumo? Se ieri l’altro
ancora, alle Belle Arti, mi hanno dato quasi formalmente parola di
prenderla?
Quella Silviana d’Aulnay, che
fino allora non aveva avuto sulle scene che dei successi di
bellezza, si era incapricciata con feroce ostinazione di essere
ammessa alla Commedia Francese per esordirvi nella parte di Paolina
nel Poliuto, una parte che studiava con accanimento da mesi.
Era una cosa pazza, tutta Parigi
ne rideva, perchè la donzella, a quanto si diceva, aveva tutti i
vizi, tutti i gusti depravati, era turpemente corrotta.
Ma lei si metteva in mostra
orgogliosamente, ed esigeva quella parte, sicura di vincere.
— E’ il ministro che non ha
voluto ‒ spiegò Duthil.
Il barone soffocava.
— Il ministro, il ministro oh! lo
farò ballare io, quel ministro!
Dovette tacere perchè la
baronessa entrava.
A quarantasei anni, era ancora
bellissima. Molto, bionda, alta, un po’ grassa, con braccia e
spalle mirabili, una pelle di raso senza una tara, si sciupava solo
nel viso leggermente avvizzito, invaso da macchie rossastre; e
quello era il suo tormento, la sua preoccupazione d’ogni ora.
L’origine israelita si tradiva
nel suo volto un po’ lungo, dalla grazia strana, dagli occhi
azzurri, di una dolcezza voluttuosa. La baronessa, indolente come
una schiava orientale, rifuggendo dal muoversi, dal camminare e
persino dal parlare, sembrava fatta per l’harem, per le continue
cure della persona. Quel giorno vestiva tutta di bianco, una seta
bianca d’una semplicità squisita ed abbagliante.
Duthil la complimentò, le baciò
la mano, con fisionomia beata.
— Ah! signora, mi rimettete un
po’ di primavera nell’anima. Parigi è così tetro, così fangoso
stamane!
Ma giungeva un secondo
commensale, un uomo alto e bello dai trentacinque ai trentasei
anni, ed il barone agitato dalla sua passione, ne profittò per
scappare. Condusse Duthil nel suo studio, che era vicino,
dicendo:
— Venite qua un momento, caro
amico. Ho ancora una parola da dirvi sull’affare di cui si tratta…
Il conte di Quinsac farà compagnia a mia moglie frattanto.
Appena fu sola col nuovo venuto,
il quale le aveva, come l’altro commensale, baciata molto
rispettosamente la mano, Eva Duvillard lo guardò a lungo, in
silenzio, mentre i suoi begli occhi teneri si riempivano di
lagrime. Poi, nel silenzio un po’ impacciato che s’era diffuso,
finì col dire pianissimo:
— Gerardo mio, come sono felice
di trovarmi sola per un momento con voi! E’ più di un mese che non
mi date questa gioia!
Il modo con cui Enrico Duvillard
aveva sposata la figlia minore di Giusto Steinberg, il ricco
banchiere ebreo, era rimasto leggendario.
Come i Rotschild, gli Steinberg
erano in origine parecchi fratelli, quattro, Giusto a Parigi, gli
altri a Berlino, a Vienna, a Londra, il che dava alla loro
associazione segreta una forza formidabile, una sovranità
internazionale ed onnipotente sui mercati finanziari
d’Europa.
Giusto però era il meno ricco dei
tre, ed aveva nel barone Gregorio un avversario terribile, contro
cui doveva lottare per tutte le prede più ambite. Era stato appunto
in seguito ad uno scontro feroce tra di loro, dopo l’avara
ripartizione del bottino, che gli era sòrta l’idea profonda di dare
in moglie, per sopra mercato, Eva, la sua figlia minore, al figlio
del barone, Enrico. Fin allora, questi era reputato un giovane
amabile, uomo di sport e di club, ed il calcolo di Giusto era di
mettere, morto che fosse il temuto barone, già condannato, la mano
sulla banca rivale ove non avrebbe avuto di fronte che un giovine
facile a debellare. Enrico si era acceso per l’appunto di una
passione impetuosa per la bionda bellezza di Eva, allora in pieno
fiore. L’aveva voluta, ed il padre, che conosceva suo figlio, aveva
acconsentito, rallegrandosi molto in fondo del pessimo affare che
Giusto faceva.
Diventò infatti disastroso per
quest’ultimo, quando Enrico succedendo al padre, l’uomo di preda
apparve nel gaudente, ed egli si prese una parte da leone nello
sfruttamento degli appetiti scatenati di quella democrazia borghese
che giungeva finalmente al potere. Non solo Eva non aveva vinto
Enrico, diventato a sua volta il banchiere onnipotente, padrone più
che mai del mercato, ma era il barone che aveva vinto Eva, l’aveva
annientata in meno di quattro anni.
Dopo aver avuto da lei, l’uno
dopo l’altro, un maschio ed una femmina, se ne era stancato
all’improvviso, quasi nauseato nella bramosia potente che l’aveva
indotto a sposarla, e l’aveva respinta, come si scaglia lontano un
frutto di cui si è sazi. Sulle prime, nell’udire che egli era
tornato alla vita da celibe e ne amava un’altra, essa era rimasta
sorpresa e disperata. Poi, senza recriminazione alcuna, senza ira,
senza darsi neppure molte brighe per riconquistarlo, aveva dal
canto suo preso un amante. Non poteva vivere senza amare, non
pareva nata che per essere bella, piacere, passare la vita tra
braccia di adorazione e di carezze.
Serbò per quindici anni l’amante,
scelto a venticinque, e gli fu perfettamente fedele, come lo
sarebbe stata al marito. La sua morte fu un immenso dolore per lei,
una vera vedovanza. Ma, sei mesi dopo, incontrando il conte Gerardo
di Quinsac, non seppe resistere al suo bisogno di affetto, e si
diede di nuovo.
— Mio caro Gerardo ‒ riprese con
fare maternamente carezzevole, notando che il giovane sembrava
confuso ‒ vi siete sentito male forse, mi dissimulate qualche
dispiacere?
Essa aveva dieci anni più di lui,
e si aggrappava disperatamente a questo ultimo amore, adorando quel
bel giovane con tutto l’esser suo in ribellione contro la
vecchiaia, pronta a lottare per serbarlo ad ogni costo.
— No, non vi dissimulo nulla, ve
lo attesto ‒ rispose il conte. ‒ Mia madre mi ha accaparrato molto
in questi giorni.
Essa continuava a guardarlo con
passione e turbamento, trovandolo così maestoso e nobile d’aspetto,
col viso regolare, i baffi ed i capelli neri, tenuti con somma
cura.
Uscito da una delle più antiche
famiglie di Francia, Quinsac abitava colla madre, vedova e rovinata
da un marito avventuroso, in un pianterreno di via San Domenico,
dove essa sapeva conservare la dignità del suo grado con
quindicimila lire di rendita. Lui non aveva mai lavorato,
limitandosi al suo anno di servizio obbligatorio, e rinunziando
all’esercito come aveva rinunziato alla carriera diplomatica, la
sola che gli fosse aperta. Passava i giorni in quell’ozio così
laborioso dei giovani che conducono la vita parigina. E sua madre
stessa, benchè d’una severità altera, pareva lo scusasse, anzi
trovasse che, sotto la Repubblica, un uomo della sua stirpe dovesse
tenersi in disparte per protesta. Ma aveva probabilmente dei motivi
d’indulgenza più intimi e più dolorosi. A sette anni aveva corso
rischio di perder il figlio per una febbre cerebrale: a diciotto
egli si era lagnato di mal di cuore, ed i medici raccomandavano di
risparmiarlo in tutto. Essa sapeva che sotto il maestoso aspetto
della razza, quell’alta statura, quella presenza superba, si
dissimulava la menzogna e che egli non era che cenere, perennemente
minacciato dalla malattia e dallo sfacelo, come in fondo alla sua
virilità apparente non v’era che una fiacchezza da femmina, da
essere debole e buono, capace di tutte le decadenze.
In una visita fatta colla madre,
molto pia, all’Asilo degli Invalidi del Lavoro, Gerardo aveva
incontrato Eva per la prima volta. Essa lo aveva conquistato con la
dedizione ed egli continuava a frequentare la sua casa perchè la
trovava ancora desiderabile, e perchè non sapeva come rompere con
lei. Sua madre chiudeva gli occhi su quel vincolo colpevole in una
società che disprezzava, come li aveva chiusi su tanti altri
errori, perdonandogli ogni cosa come ad un bambino infermo. Eva
l’aveva anche conquistato con una decisione che aveva fatto stupire
il mondo. All’improvviso si era venuti a sapere che monsignor
Martha l’aveva convertita al cattolicismo; essa aveva fatto per
assicurarsi l’amore d’un amante, quello che non aveva concesso al
marito legittimo.
E Parigi era ancora commossa
dalla magnificenza con cui si era celebrato, alla Maddalena, il
battesimo di quell’ebrea di quarantacinque anni, di cui la bellezza
e le lagrime avevano intenerito tutti i cuori.
Quell’atto di immensa tenerezza
aveva lusingato Gerardo. Ma cominciava a stancarsi di lei, tentava
di rompere, schivando gli appuntamenti, e comprendeva ora quello
che essa gli chiedeva con occhi supplici.
— Vi assicuro, ‒ ripeteva,
cedendo già, ‒ che mia madre non m’ha lasciato un giorno libero.
Naturalmente, sarei stato felicissimo…
Senza una parola, essa continuava
ad implorarlo e delle lagrime le brillavano sulle ciglia. Da un
mese intero egli non la riceveva più, nella cameretta di via
Matignon, in fondo al cortile, dove s’incontravano di solito. E
Quinsac buono e fiacco come lei, disperato di quel momento di
solitudine in cui lo avevano lasciato, si arrese, incapace di
rifiutarsi più a lungo.
— Ebbene! questo dopo pranzo, se
vi pare, alle quattro, come al solito.
Parlava a bassa voce, ma un lieve
fruscìo gli fece voltar la testa col sussulto di un uomo colto in
fallo.
Era Camilla, la figlia della
baronessa, che entrava. Non aveva udito, ma dal sorriso dei due
amanti, dal fremito stesso dell’aria, aveva compreso ogni cosa: un
altro appuntamento, laggiù nella via che sospettava, e per quel
giorno stesso. Vi fu un momento d’imbarazzo, uno scambio di sguardi
inquieti ed ostili.
A ventitrè anni Camilla era una
personcina dal colorito olivastro, quasi deforme per una spalla più
alta dell’altra. Non aveva nulla del padre nè della madre, per uno
di quei casi impreveduti nell’eredità di una famiglia che vi
spingono a domandare con curiosità donde possono risultare. Il suo
solo orgoglio erano i begli occhi neri ed i mirabili capelli che,
piccina come era, bastavano a vestirla, a quanto diceva. Ma il naso
era lungo, la faccia deviava a sinistra, con lineamenti irregolari
e lunga bazza. La bocca fine, arguta, maligna, rivelava il rancore
segreto, la collera perversa che fervevano in fondo a quell’anima
di fanciulla brutta e furente di esserlo.
La creatura che essa abborriva di
più al mondo era certamente sua madre, quella innamorata, così poco
madre, che non l’aveva mai amata, che non si era mai curata di lei,
abbandonandola, fin dalla culla, a mani mercenarie, cosicchè un
vero odio era sorto fra le due donne, odio muto e freddo nell’una,
attivo ed ardente nell’altra. La figlia odiava la madre perchè la
trovava bella e l’accusava di non averla fatta a sua immagine;
bella di quella bellezza con cui l’ecclissava. Il suo dolore
quotidiano era di non sentirsi desiderata, di accorgersi che tutti
i desideri andavano verso sua madre. Siccome era d’una malignità
divertente, la si ascoltava, si rideva; soltanto gli sguardi di
tutti gli uomini vecchi e giovani, e persino ed anzi quelli dei più
giovani, tornavano a quella madre trionfante che non voleva
invecchiare. Ed era stato perciò che essa si era decisa, nella sua
energia feroce, a portarle via l’ultimo amante, a farsi sposare da
Gerardo, di cui la perdita le darebbe un dolore mortale. Grazie ai
suoi cinque milioni di dote, i pretendenti non le mancavano; ma
poco lusingata, essa soleva dire col suo risolino amaro: ‒
Perdinci! per cinque milioni andrebbero a pigliarsene una alla
Salpetrière! ‒ Poi s’era messa ad amar davvero Gerardo, che si
mostrava cortese con quella mezza inferma per bontà di cuore. Egli
soffriva a vederla così derelitta, si abbandonava a poco a poco
alla tenerezza piena di gratitudine che Cornelia gli manifestava,
felice l’uomo bello, di essere un Dio, di avere una schiava: e nel
suo tentativo di rottura con la madre, di cui l’amore gli pesava,
entrava per certo l’idea di lasciarsi sposare dalla figlia, il che
era dopo tutto una fine molto lieta, sebbene non lo confessasse
ancora, vergognoso, impacciato dal suo nome illustre e da tutte le
complicazioni, da tutte le lagrime che prevedeva.
Il silenzio si protraeva. Camilla
aveva detto alla madre, col suo sguardo acuto e micidiale come una
lama, che sapeva tutto: poi, con un altro sguardo doloroso, aveva
rimproverato Gerardo. E questi non trovò che un complimento per
ristabilire l’equilibrio fra le due donne:
— Buon giorno, Camilla… Ah! quel
vestito avana! E’ strano come i vestiti un po’ scuri vi stanno
bene!
Camilla gettò un’occhiata sul
vestito bianco della madre, poi guardò il suo vestito scuro che
lasciava appena scorgere il collo ed i polsi.
— Sì ‒ rispose ridendo ‒ non sono
passabile che quando mi vesto da vecchia.
Eva, a disagio, preoccupata
nell’intuire una rivalità a cui non voleva ancora prestar fede,
cambiò argomento.
— Tuo fratello non c’è?
— Ma sì, siamo scesi
insieme.
Giacinto, che entrava, strinse la
mano a Gerardo con fare stanco. Toccava i vent’anni e dalla madre
aveva ereditato i chiari capelli biondi, il viso ovale,
orientalmente languido, dal padre gli occhi grigi, la bocca tumida
su cui si leggevano gli appetiti senza scrupoli. Pessimo studente,
aveva deciso di non far nulla, sprezzando del pari tutte le
professioni, e, viziato dal padre, si interessava di musica e di
poesia, vivendo in una società straordinaria di artisti e di
sgualdrine, di pazzi e di banditi, fanfarone di vizi e di delitti
anche lui, ostentando il ribrezzo della donna, professando le più
perverse idee filosofiche e sociali, andando sempre agli estremi,
collettivista, individualista, anarchico, pessimista, simbolista e
perfino sodomista, per turno, senza rinunziare a fare il cattolico
per suprema correttezza aristocratica.
In fondo non era che vuoto ed un
po’ sciocco. In quattro generazioni, il sangue robusto ed affamato
dei Duvillard, dopo aver messo al mondo tre belle belve, produceva
ora, come esaurito dall’appagamento, quell’androgine abortito,
incapace perfino di grandi attentati e di grandi orgie.
Camilla, troppo intelligente per
non sentire il vuoto del fratello, lo motteggiava, e riprese, nel
vederlo stretto in una lunga redingote a pieghe, una risurrezione
romantica che esagerava:
— La mamma ti chiama, Giacinto.
Vieni un po’ a farle vedere la tua sottana. Come saresti bello,
vestito da donna!
Ma egli si schermì senza
rispondere. Aveva una paura segreta della sorella maggiore, sebbene
vivessero in una intimità che favoriva le confidenze perverse,
dicendosi ogni cosa, tentando invano di farsi stupire a vicenda. E
diede un’occhiata di sprezzo al mirabile canestro delle orchidee,
moda già antica, abbandonata ai borghesucci. Aveva attraversata la
fase dei gigli, apprezzava ora il ranuncolo, il fiore di
sangue.
I due ultimi commensali aspettati
giunsero là quasi insieme: anzitutto il giudice istruttore Amadieu,
intimo di casa, un omuncolo sui quarantacinque, messo in evidenza
recentemente da un processo anarchico.
Aveva una faccia piatta e
regolare da magistrato, tra basette bionde, faccia che tentava di
rendere penetrante mercè un monocolo, dietro a cui il suo occhio
schizzava scintille. Molto amante della società, apparteneva alla
nuova scuola, e psicologo distinto, autore d’un libro in risposta
agli abusi della fisiologia criminalista, ambizioso, innamorato
della pubblicità, spiava sempre gli affari rumorosi da cui si può
derivare la gloria.
Finalmente apparve il generale di
Bozonnet, zio materno di Gerardo, un vecchio alto ed asciutto, dal
naso d’aquila, che i reumi avevano costretto da poco a mettersi in
disponibilità.
Insignito del grado di colonnello
dopo la guerra, in premio del suo nobile contegno a S. Privat,
serbava a Napoleone III la fede giurata, sebbene fosse di famiglia
e di aderenze monarchiche. Gli condonavano fra i suoi quella specie
di bonapartismo militare, per l’amarezza con cui accusava la
Repubblica di aver ucciso l’esercito.
Del resto, era un brav’uomo che
adorava la sorella, la contessa di Quinsac, e pareva obbedisse ad
un desiderio segreto di questa, nell’accettare gli inviti della
baronessa, come per rendere più naturale e più scusabile la
continua presenza di Gerardo in casa sua.
Frattanto il barone e Duthil
tornavano dallo studio ridendo forte di un riso esagerato,
probabilmente per farsi credere affatto liberi di spirito.
Ed entrarono in sala da pranzo,
dove ardeva un gran fuoco di cui le vampe gioconde splendevano come
un raggio di primavera tra i mobili inglesi di mogano chiaro,
coperti di cristalli e di argenterie. La sala, di un verde muschio
tenero, aveva un fascino languido sotto la luce pallida. Al centro
la tavola, colla ricchezza delle posate e la bianchezza delle
tovaglie, guarnite di merletti di Venezia, sembrava fiorisse
miracolosamente sotto una esuberanza di rose thea, fiori
straordinari per la stagione e d’una fragranza squisita.
La baronessa aveva il generale a
destra ed Amadieu a sinistra. Il barone tenne a destra Duthil, a
sinistra Gerardo. Poi i ragazzi sedettero ai due capi della tavola,
Camilla fra il generale e Gerardo, Giacinto fra Duthil ed Amadieu.
E subito, fin dalle uova coi tartufi, la conversazione si avviò,
allegra e familiare, quella conversazione parigina dell’asciolvere
in cui sfilano tutti i fatti grandi e piccoli del giorno precedente
e della mattina, le verità come le menzogne di tutti i circoli, lo
scandalo finanziario, l’avventura politica, il romanzo appena
uscito, la produzione rappresentata, le storielle che non si
potrebbero dire che all’orecchio e si raccontano invece ad alta
voce.
E sotto la leggerezza del motto
spiritoso, sotto le risa che spesso vibrano stonate, ognuno serba
la propria tempesta segreta, l’interno sfacelo, un dolore che alle
volte giunge fino all’agonia.
Il barone parlò pel primo,
audace, con la solita placida impudenza, dell’articolo della Voce
del Popolo.
— Dite un po’, avete letto
l’articolo di Sagnier? E’ uno dei buoni, ha dello slancio; ma che
pazzo pericoloso colui!
Tutti si sentirono sollevati
perchè quell’articolo avrebbe oppresso gli animi se nessuno ne
avesse fatto motto.
— Siamo daccapo col Panama! ‒
gridò Duthil ‒ Ah! no perdinci, ne abbiamo abbastanza!
— L’affare delle ferrovie
africane? ‒ riprese il barone ‒ ma è limpido come l’acqua di
sorgente! Tutti quelli che Sagnier minaccia possono dormire i loro
sonni tranquilli. E’ un colpo, vedete, per far cadere il ministro
Barroux. Domanderanno un’interpellanza or ora, senza dubbio, e si
farà un bel chiasso.
— Quella stampa di diffamazione e
di scandalo ‒ disse pacatamente Amadieu ‒ è un dissolvente che
rovinerà la Francia. Ci vorrebbero delle leggi.
Il generale fece un atto di
collera.
— Delle leggi, a che pro? se non
hanno il coraggio di applicarle.
Vi fu una pausa. Il maggiordomo,
muovendo attorno alla tavola con passo tacito, presentava delle
triglie ai ferri. Il servizio era così silenzioso, nella tepida e
fragrante aria della sala, che non s’udiva nemmeno un tintinnìo di
porcellane.
E frattanto, senza che si potesse
sapere perchè, la conversazione era cambiata: una voce
chiese:
— E così, si proroga la ripresa
della produzione?
— Sì ‒ disse Gerardo ‒ ho saputo
questa mattina che il Poliuto non andrà in scena che in aprile, al
più presto.
Camilla, muta fino allora,
tutt’intenta com’era a riconquistare il giovane, guardò suo padre
con occhi lucenti. Si trattava della produzione in cui Silviana si
ostinava ad esordire. Ma il barone e sua moglie si serbarono
perfettamente sereni, non ignorando più da lungo tempo le loro
avventure reciproche. Eva era così felice dell’appuntamento
ottenuto! Non pensava ad altro, trovandosi già laggiù colla
fantasia, nel nido d’amore, mentre sorrideva automaticamente agli
ospiti. Ed il barone era troppo preoccupato delle nuove pratiche
che contava fare alle Belle Arti, con impeto sdegnoso, per
strappare a viva forza la scrittura.
Si limitò a dire:
— Come volete che rimettano in
iscena le produzioni alla Commedia? Non hanno più donne.
— Oh! ‒ riprese placidamente la
baronessa ‒ ieri in quella produzione del Vaudeville, Delfina
Vignot aveva un vestito squisito, e non c’è nessuno che sappia
pettinarsi come lei.