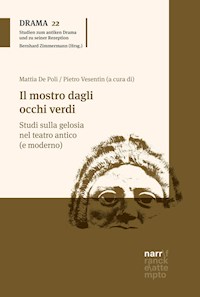
Il mostro dagli occhi verdi E-Book
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Narr Francke Attempto Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: DRAMA – Studien zum antiken Drama und seiner Rezeption
- Sprache: Deutsch
I personaggi di molte tragedie e commedie antiche, greche e latine (Eschilo, Sofocle, Euripide, Seneca, Menandro, Plauto), ma anche di drammi moderni ispirati al mondo classico (Lorenzo il Magnifico, Antonio Somma) agiscono in preda alla gelosia. Spesso nell'antichità questa emozione non è stata identificata da una parola specifica, ma la situazione permette comunque di riconoscerla. Dee e dei, donne e uomini ne possono essere affetti e agiscono di conseguenza: l'esito delle loro azioni è spesso catastrofico per sé e per gli altri e non sempre è possibile simpatizzare con le persone gelose. Dodici studi, organizzati in ordine cronologico all'interno di tre sezioni tematiche ("Il lessico della gelosia", "La divina gelosia", "Donne vs. uomini: sesso, sangue e gelosia"), indagano questa comune emozione umana attraverso l'opera teatrale.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 630
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Mattia De Poli / Pietro Vesentin
Il mostro dagli occhi verdi
Studi sulla gelosia nel teatro antico (e moderno)
© 2022 • Narr Francke Attempto Verlag GmbH + Co. KGDischingerweg 5 • D-72070 Tübingen
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetztes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Alle Informationen in diesem Buch wurden mit großer Sorgfalt erstellt. Fehler können dennoch nicht völlig ausgeschlossen werden. Weder Verlag noch Autor:innen oder Herausgeber:innen übernehmen deshalb eine Gewährleistung für die Korrektheit des Inhaltes und haften nicht für fehlerhafte Angaben und deren Folgen. Diese Publikation enthält gegebenenfalls Links zu externen Inhalten Dritter, auf die weder Verlag noch Autor:innen oder Herausgeber:innen Einfluss haben. Für die Inhalte der verlinkten Seiten sind stets die jeweiligen Anbieter oder Betreibenden der Seiten verantwortlich.
Internet: www.narr.deeMail: [email protected]
ISSN 1862-7005
ISBN 978-3-8233-8548-6 (Print)
ISBN 978-3-8233-9548-5 (ePub)
Inhalt
Prefazione
In principio era la gelosia.
Agli albori della letteratura occidentale, l’Iliade, la cui misteriosa origine si smarrisce negli abissi insondabili della storia, ha il suo inizio prima che la schiava Briseide sia rivendicata da Agamennone e la bella Elena rapita da Paride, poiché insignificanti sono le stirpi degli uomini e sulle loro aristíai incombe sempre l’ombra fatale dei superni.
Gialla è la mela che Eris, nei tempi del mito, ha fatto rotolare sulle mense divine condizionando con un singolo gesto la sorte del mondo. L’oro delle sue polpe riflette sguardi di vanità e di apprensione: trionfare, per le tre contendenti, non significa imporre una gerarchia estetica nelle case celesti, ma far brillare il proprio nome di una gloria fulgida e perpetua, catalizzare ogni attenzione di celesti e mortali. Ecco che la collera delle sconfitte, flagrante come un’onda d’urto, si diparte dalle cime dell’Olimpo, scende nel mondo e fa di Troia il teatro della vendetta, il luogo dell’eterno rancore. Ma la gelosia sopravvive ai fuochi e alle ceneri della città, continuando a intridere di veleno le pagine della letteratura classica. Con i suoi riflessi aurati incupisce gli occhi dei numi e degli umani, corrompe i corpi vigorosi degli eroi e le carni sode delle eroine, guasta i freschi palpiti dei fanciulli e accompagna i vecchi nei loro ultimi spasimi. Corre e vola fuori dal mondo antico risalendo i diverticoli della tradizione letteraria; distende le sue mille braccia nelle direzioni più diverse, porta con sé orrori e sofferenze, facendo emergere incontrollatamente gli istinti dell’uomo e della donna, ora mossi da una collera rovinosa, ora dal languore di una pulsione sensuale.
Se vi è un’occasione per riflettere sulla natura problematica dell’umano e del divino, essa è offerta, come sempre, da quel «momento archetipico» che è l’esperienza teatrale, la cui (im)permanenza e polifonia nasce per catturare il conflitto interiore e i moti dell’anima. Non è un caso che sia proprio l’Otello a prestare l’inquietante immagine che dà il titolo al libro: la gelosia è – e rimane –, anche nelle parole di Shakespeare, un orrido mostro. Non perde il suo diabolico sembiante, ma muta il colore degli occhi: scintillanti come stelle fredde, verdi come quelli di un demone.
Questo volume – dedicato alla letteratura drammatica – integra l’appuntamento tradizionale con “Il teatro delle emozioni”. Spetta alla gelosia, dopo la paura, la gioia e l’ira, farsi centro di riflessione, thema portante con cui sono chiamati a confrontarsi studiosi italiani e stranieri in diversi momenti della loro formazione e carriera. La dimensione teatrale, varia nelle sue soluzioni di scrittura (in greco, in latino, ma anche in italiano), multiforme nelle sue cronologie (principalmente teatro classico, ma anche rinascimentale e ottocentesco), nei suoi generi (comico e tragico) e, almeno in un caso, nella forma letteraria (del resto la vicinanza tra romanzo antico e teatro è attestata già presso gli antiqui auctores), viene qui indagata con molteplici prospettive – narrativa, espressiva, simbolica, antropologica, performativa, generazionale, di genere – che si integrano e si avvicendano le une alle altre; tutte parimenti valide nell’illuminare una condizione esistenziale, quella della donna e dell’uomo gelosi, che incoraggia a interrogarsi e a proporre nuove modalità di analisi da applicare al vaglio dei testi.
Tre sono le sezioni in cui, senza pretese definitorie, abbiamo scelto di organizzare i contributi: la prima dedicata al lessico della gelosia, alle sue immagini e alla sua semantica; le altre due riservate ai suoi attanti, le dee e gli dei, gli uomini e le donne, nei quali la gelosia diviene Erlebnis, esperienza vissuta e sofferta. È certamente impossibile tracciare una storia completa di questa emozione attraverso il tempo, attraverso le civiltà e le letterature, ma il libro pone al suo lettore una essenziale domanda: quale ruolo ha avuto la gelosia nella letteratura drammatica e quanto tale produzione ha contribuito allo strutturarsi dell’archetipo del/della geloso/a? Se riesce anche a rispondervi è unicamente merito delle studiose e degli studiosi che hanno generosamente offerto i loro contributi, e del prof. Bernhard Zimmermann, al quale Mattia De Poli ed io rivolgiamo il nostro più sentito ringraziamento, poiché, senza il suo aiuto prezioso, questo volume non avrebbe visto la luce. Va a lui la nostra riconoscenza, oltre che, naturalmente, ai membri del comitato scientifico, cui si deve a monte la selezione delle proposte.
Padova, 13 ottobre 2021
Pietro Vesentin
INTRODUZIONE
1.Gelosia vs. Invidia. Per una definizione delle emozioni
Abstract: The Greek novel Chereas and Callirhoe by Chariton attests that in the age of the Roman Empire the ideas of jealousy and envy were clearly distinct and corresponded to two Greek words. Nevertheless, we may assume that jealousy already had an important role in the plots of dramatic plays in the Classical age, and the Greek drama was a model for the Greek novel also in the emotional description of the characters.
Keywords: Greek novel – Greek drama – jealousy – anger – envy.
1.Caritone, Le avventure di Cherea e Calliroe: trame di invidia e gelosia
Cherea e Calliroe, i protagonisti del romanzo di Caritone, sono due giovani siracusani. La ragazza, figlia del generale Ermocrate, è di una bellezza divina e in molti affluiscono in città per chiederla in sposa: figli di re e di tiranni, provenienti dalla Sicilia e da tutto il mondo greco. Ma Eros, il dio capriccioso che ama giocare con le vite degli uomini in modo imprevedibile, decide diversamente e fa innamorare Calliroe – a sua volta riamata – di Cherea. Come in diverse commedie di Menandro, i due giovani si incontrano in occasione di una festa pubblica in onore di Afrodite, a cui Calliroe prende parte per la prima volta, accompagnata dalla madre come si conviene ad una ragazza perbene: basta un incrocio accidentale di sguardi perché entrambi restino trafitti da Eros.
Cherea è un bel giovane, appartenente ad una famiglia nobile ma avversa a quella di Calliroe. Si profila così una situazione potenzialmente tragica, come quella degli shakespeariani Romeo e Giulietta. In realtà Cherea, controparte maschile della Fedra euripidea, si logora nel chiuso della sua casa, consumato da un amore impossibile che confessa solo ai propri genitori. Quando anche il popolo siracusano viene informato della situazione, intercede per il giovane innamorato presso Ermocrate, il quale cede alla volontà dell’assemblea cittadina. Finalmente, nell’entusiasmo generale i due giovani coronano il loro desiderio d’amore e si sposano.
In poche pagine il romanzo di Caritone condensa e risolve diversi spunti drammatici, tragici e comici, approdando agevolmente ad un lieto fine, in apparenza rassicurante, e la vicenda potrebbe concludersi semplicemente così. Ma, come nel matrimonio di Teti e Peleo, la gioia della festa è incrinata dalla presenza di una figura malevola: nel mito celebrato dai poeti era la dea Eris, la Discordia; nel romanzo l’Invidia (1.2.1 ὁ Φθόνος), che agita gli animi dei numerosi pretendenti delusi di Calliroe. Questi non si rassegnano, accantonano l’odio che nutrivano l’uno per l’altro quando tutti aspiravano alla mano della bella giovane e, tormentati da un misto di rabbia e dolore (1.2.1 λύπην ἐλάμβανον μετ’ ὀργῆς), decidono di coalizzarsi contro Cherea. “Se a sposarla fosse stato uno di noi, non mi sarei adirato” (1.2.2 εἰ μέν τις ἐξ ἡμῶν ἔγημεν, οὐκ ἂν ὠργίσθην), assicura a posteriori il figlio del tiranno di Reggio, che vorrebbe punire e uccidere lo sposo, trasformando il suo matrimonio in ‘nozze di sangue’ quasi come nel dramma di Garcia Lorca. Ma anche questo sviluppo tragico rimane abortito: il tiranno di Agrigento, infatti, di fronte al prestigio di cui gode il padre della sposa, invita tutti ad agire non scopertamente ma con l’arte dell’inganno.
Il suo obiettivo è chiaro: sciogliere il matrimonio fra Cherea e Calliroe. A questo scopo “armerò contro di lui la Gelosia che, avendo come alleato Eros, compirà un grave malanno” (1.2.5 ἐφοπλιῶ γὰρ αὐτῷ Ζηλοτυπίαν, ἥτις σύμμαχον λαβοῦσα τὸν Ἔρωτα μέγα τι κακὸν διαπράξεται): così promette l’Agrigentino. Se Calliroe si profila come un baluardo inespugnabile, il novello sposo appare più incline agli errori di gioventù e più vulnerabile: “Cherea può facilmente nutrire sospetti e cadere preda della gelosia degli innamorati” (1.2.6 ὁ δὲ Χαιρέας […] δύναται ῥᾳδίως ὑποπτεύσας ἐμπεσεῖν εἰς ἐρωτικὴν ζηλοτυπίαν).
Un primo tentativo viene messo in atto subito dopo la celebrazione delle nozze: alla sera il giovane, informato che suo padre è caduto in campagna ed è in pericolo di vita, è costretto a lasciare la moglie per recarsi al suo capezzale. Durante quella notte, in assenza dello sposo, nessuno ha voglia di fare festa, ma è qui che interviene la malizia dei pretendenti delusi: di nascosto, spargono intorno alla casa i segni di festeggiamenti notturni, appendendo corone alla porta, spargendo unguenti profumati, spandendo vino e gettando a terra torce semibruciate. Al sorgere del nuovo giorno tutti i passanti si fermano a guardare “a causa di un vizio comune, la curiosità” (1.3.3 κοινῷ τινι πολυπραγμοσύνης πάθει). Il padre di Cherea guarisce inaspettatamente e il figlio si affretta a tornare dalla moglie: vedendo quella folla di fronte alla porta di casa sua, dapprima rimane stupito ma poi si precipita dentro “furente” (1.3.3 ἐνθουσιῶν). Alla vista di Calliroe, tuttavia, “mutò la sua ira in dolore” (1.3.3 τὴν ὀργὴν μετέβαλεν εἰς λύπην). Il suo cuore è tormentato, incapace di non credere a quello che i suoi occhi hanno visto e, al contempo, di credere a quello che non vuole credere: allora piange, si strappa le vesti, si chiude in un ostinato silenzio, trema, finché di fronte alle insistenti domande della moglie, “con gli occhi iniettati di sangue e la voce grossa” (1.3.5 ὑφαίμοις τοῖς ὀφθαλμοῖς καὶ παχεῖ τῷ φθέγματι) le rivela “la causa della sua rabbia” (1.3.5 τὴν αἰτίαν τοῦ χόλου). Ma ‘chiodo scaccia chiodo’ e l’ira di Cherea viene placata dalla reazione adirata di Calliroe (cf. 1.3.6 παρωξύνθη) che si sente ingiustamente accusata e protesta la propria innocenza. La coppia allora si riconcilia e tra marito e moglie torna a regnare l’armonia.
Ancora una volta la vicenda potrebbe ricomporsi e il racconto chiudersi serenamente, dopo appena poche ma dense pagine. Tuttavia, il perfido tiranno agrigentino non si arrende e si affida all’arte raffinata di un parassita del suo seguito. Simile ad un personaggio tipico della ‘commedia nuova’, egli agisce da consumato “drammaturgo” (1.4.2 ὁ δημιουργὸς τοῦ δράματος): da principio, recitando in prima persona come si dice che facessero gli antichi tragediografi, seduce l’ancella prediletta di Calliroe e poi coinvolge un “secondo attore” (1.4.2 ὑποκριτὴν ἕτερον). Questo ha il compito di entrare in confidenza con Cherea e, raggiunto l’obiettivo, mette in scena il suo dramma: manifestamente addolorato, informa il giovane sposo che la moglie lo tradisce e che il fatto è risaputo e la gente ride di lui senza alcun ritegno. Per descrivere il dolore del giovane, Caritone cita i versi dell’Iliade (18.22–24) in cui viene presentata la reazione di Achille alla notizia della morte di Patroclo, ma a differenza dell’eroe omerico Cherea non si strappa i capelli, non grida e non si agita prostrato a terra nella polvere: il protagonista del romanzo, come un personaggio delle tragedie di Eschilo, rimane per lungo tempo muto e con lo sguardo basso. Quando finalmente trova il fiato per dire poche parole, la voce non sembra più la sua e chiede di poter cogliere sul fatto la moglie con l’amante prima di togliersi la vita. Il falso amico allora allestisce una messinscena (1.4.7 συνέταττε τὴν σκηνήν) che ha per protagonisti il parassita del tiranno di Agrigento, vistosamente agghindato, e l’inconsapevole serva preferita di Calliroe che gli apre la porta in piena notte. Cherea, credendo di vedere l’amante che entra nella sua casa per recarsi da Calliroe, fa per scagliarsi contro di lui, ma questo si allontana prontamente. Allertata dal trambusto, Calliroe si rende conto che il marito è ritornato e con gioia gli va incontro, ma questi è furibondo: “Non trovò la voce per rimproverarla e, sopraffatto dall’ira, la colpì con un calcio mentre gli veniva incontro” (1.4.12 ὁ δὲ φωνὴν μὲν οὐκ ἔσχεν ὥστε λοιδορήσασθαι, κρατούμενος δὲ ὑπὸ τῆς ὀργῆς ἐλάκτισε προσιοῦσαν). Calliroe cade a terra, senza fiato, e tutti la credono morta; nonostante ciò, Cherea continua a ribollire nell’animo (1.5.1 ἔτι τῷ θυμῷ ζέων), finché viene informato della verità, e allora cade nello sconforto e nella disperazione.
2.La gelosia, una costellazione di emozioni
Nelle pagine iniziali del romanzo di Caritone invidia e gelosia vengono entrambe personificate (Φθόνος e Ζηλοτυπία), ma sono chiaramente distinte fra loro: a due diverse parole corrispondono diversi concetti. L’invidia è l’emozione che i pretendenti di Calliroe, delusi, provano nei confronti di Cherea, perché questi ha ottenuto quello che loro avrebbero voluto per sé, ovvero il matrimonio con Calliroe. La gelosia è l’emozione che il marito prova nei confronti della moglie, quando pensa che lei si sia sollazzata con altri in sua assenza o che lo tradisca con un amante. L’invidia presuppone l’avversione di un soggetto nei confronti di un altro, di solito in relazione ad un oggetto che consiste in un risultato conseguito, in una condizione raggiunta, in uno stato in cui il primo soggetto avrebbe voluto trovarsi al posto dell’altro. La gelosia, invece, presuppone una relazione triangolare e contrappone un soggetto alla persona amata a causa di un terzo soggetto, a cui la persona amata rivolge (o sembra rivolgere) quelle attenzioni che la persona gelosa vorrebbe ricevere.
Gelosia e invidia, però, spesso vengono confuse perché, oltre alle differenze, hanno anche alcune affinità, a partire da una originaria forma di desiderio: i pretendenti, infatti, aspirano a sposare Calliroe, mentre Cherea è perdutamente innomorato della bella giovane. Tuttavia, desiderio e invidia procedono in direzioni diverse, perché l’oggetto desiderato e il soggetto invidiato sono nettamente distinti: i pretendenti che si recano a Siracusa desiderano il matrimonio con Calliroe, ma invidiano Cherea che lo ha ottenuto al posto loro; al contrario, desiderio e gelosia seguono la stessa direzione: Cherea è innamorato di Calliroe e Cherea è geloso di Calliroe. Descrivendo l’invidia dei pretendenti, Caritone evoca altre due emozioni, dolore ed ira, che sono caratteristiche anche della gelosia di Cherea: nel primo sono compresenti, quasi in una miscela esplosiva; nel secondo l’ira si smorza nel dolore alla sola vista della donna amata. In ogni caso, tanto l’invidia quanto la gelosia appaiono come emozioni complesse, ovvero una costellazione di altre emozioni semplici, quali il desiderio, il dolore e l’ira.
3.Vedere, credere, ribollire. Per una fenomenologia della gelosia
In entrambi gli accessi di gelosia di Cherea, la vista – quella propria e quella altrui – ha un’importanza fondamentale. Vedere gli indizi artefatti dei festeggiamenti notturni o vedere un uomo che entra di notte in casa propria mentre lui ha detto alla moglie che sarebbe andato in campagna è la miccia che accende la gelosia, ma ad alimentare il fuoco contribuiscono sicuramente gli sguardi e le voci della gente: sono i curiosi che si fermano davanti a casa sua sorpresi e attratti dai segni dei bagordi, sono tutte quelle persone che hanno saputo del tradimento di sua moglie e si fanno beffe di lui senza alcun riguardo.
Eppure, vedere non garantisce la comprensione della verità, anzi: in ambedue gli episodi, infatti, la messinscena architettata dai pretendenti induce Cherea in errore, nutrendo la sua immaginazione, la sua fantasia. Solo nel primo caso la vista di Calliroe – quasi incarnazione della verità – ha un effetto parzialmente metabolico, perché il marito placa la propria ira trasformandola in dolore, ma Cherea resterà combattuto fra due alternative – non credere a quello che ha visto o credere ad una cosa che non vuole credere – finché la moglie non respingerà con sdegno le sue accuse. Non pago di questo primo errore, nel secondo episodio è lo stesso Cherea a chiedere di vedere le prove della sua disgrazia per credere alla notizia che gli è stata riferita e agire di conseguenza. E nuovamente l’inganno ordito ai suoi danni viene confuso con la verità e, solo dopo aver interrogato le serve di Calliroe, scopre il proprio sbaglio.
Cherea è un marito geloso dal temperamento sanguigno. Vedendo i segni dei bagordi notturni e la folla di curiosi davanti a casa sua, è sopraffatto dal furore e dalla frenesia, che poi si sciolgono in pianto e tremore mentre si straccia le vesti, ma gli occhi restano iniettati di sangue e la voce è rude. I sintomi della gelosia sono ancora più radicali nel secondo episodio: disperazione, afasia e sguardo basso, voce alterata e desiderio di morte, fino alla violenza incontrollata di un animo che si scalda fino a far ribollire gli umori interni.
Gelosia è anche volubilità: appena viene informato del tradimento della moglie, Cherea afferma di volersi togliere la vita risparmiando quella di Calliroe, ma dopo aver visto il presunto amante intrufolarsi in casa sua la furia omicida si sfoga proprio sulla donna. Solo quando scopre la verità, torna al proposito iniziale di uccidersi, da cui lo trattiene l’intervento di un amico.
4.À rebours: dal romanzo al teatro
Per Caritone la gelosia non solo è concettualmente distinta dall’invidia, ma ha anche un nome specifico che la identifica: ζηλοτυπία. Di questo romanziere greco non sappiamo quasi nulla ma solitamente viene datato al I-II secolo d.C., e non stupisce che egli abbia potuto fare uso in maniera appropriata di un termine che, insieme alla sua famiglia lessicale, in epoca arcaica non è attestato e nel IV secolo a.C. è documentato con significati che, secondo David Konstan, non coincidono esattamente con il nostro concetto di gelosia. Inoltre, questa emozione è del tutto assente nella classificazione tratteggiata da Aristotele nella Retorica e nell’Etica a Nicomaco. Lo stesso Konstan ha quindi cercato di sostenere che la cultura greco-latina non ha conosciuto l’idea di gelosia almeno fino all’età di Augusto, immaginando di poter datare in quel momento la nascita di un’emozione fino ad allora misconosciuta1. Al contrario, l’invidia insieme allo sdegno ha sia un nome che una definizione nell’opera di Aristotele e può essere più facilmente identificabile. Ne consegue che nella tragedia e nella commedia greca e latina è possibile rintracciare l’invidia ma non la gelosia.
Eppure, obietta Giulia Sissa, gli “Antichi” conoscevano molto bene l’emozione (o il complesso di emozioni) suscitata della volubilità sessuale di una persona molto amata. Non bisogna cercare i termini che possono essere tradotti con ‘gelosia’: “il problema non è di ‘tradurre’, bensì di ‘comprendere’”. Si scoprirà allora che la gelosia è “uno dei motori narrativi più potenti”, dall’epica al teatro2. Ancora leggendo le pagine iniziali del romanzo di Caritone, si nota che spesso la gelosia viene descritta come una forma d’ira, di ὀργή, ma per i Greci è sempre stato così: “in Grecia – prosegue Sissa – la gelosia, quella seria, non è nient’altro che collera. Una collera in cui eros, l’amore sensuale, ha un ruolo cruciale. Una collera erotica”3. Questa chiave di lettura permette di riconoscere il ruolo fondamentale della gelosia, ad esempio, nella trama della Medea di Euripide, come è stato recentemente ribadito anche da William Allan4, oppure nel personaggio di Deianira nelle Trachinie di Sofocle.
Come ira viene presentata anche la violenta gelosia di Polemone nella Perikeiromene di Menandro in seguito alla notizia del bacio che Glicera ha ricevuto da Moschione (v. 163). Un’ira che – come quella di Cherea nel romanzo di Caritone – viene ispirata da Agnoia, la personificazione dell’ignoranza dei fatti: Polemone non conosce la verità e per questo si adira con la donna che ama. Poco dopo averle tagliato i capelli in segno di spregio, però, è prostrato in lacrime a casa di un amico (v. 174) e, quando scopre che Glicera ha abbandonato la sua casa, dapprima pensa di riprendersela con la forza ma poi manifesta più volte l’intenzione di togliersi la vita (vv. 505, 975). Quando l’equivoco viene chiarito e l’intreccio volge ad una lieta soluzione, Polemone constata che Moschione non era l’amante di Glicera ma suo fratello, e riconosce di essersi comportato da “uomo violento e geloso” (vv. 986–987 ὁ δ’ ἀλάστωρ ἐγὼ / καὶ ζηλότυπος ἄνθρωπος). E la donna, che ha ingiustamente subito i suoi maltrattamenti, gli accorderà alla fine il suo perdono solo perché dallo sfogo di gelosia del soldato è scaturita una serie di fortunati eventi (vv. 1021–1022).
Ζηλότυπος, infine, è anche il titolo del quinto mimiambo di Eronda e designa una donna che, gelosa dello schiavo di cui è innamorata, vuole punirlo e umiliarlo per un sospetto tradimento. Dapprima Gastrone la implora di perdonare la sua colpa, protestando di aver commesso un errore a causa della sua natura umana (vv. 26–27). Poi, però, la implora di voler accertare se l’accusa che gli ha rivolto corrisponde al vero o meno (vv. 35–36) e ridimensiona quelle parole che Bitinna aveva interpretato come un’ammissione di colpa, dicendo che con tali parole intendeva placare la sua collera (v. 39 τήν σευ χολὴν γὰρ ἤθελον κατασβῶσαι). Anche in questo caso, dunque, la gelosia viene descritta come una forma d’ira, che infiamma l’animo e surriscalda gli umori, e a fatica si cerca di spegnere quel fuoco ardente. Alla fine, per intercessione di Cidilla, il perdono verrà provvisoriamente accordato a Gastrone: la serva personale di Bitinna agisce come Pateco nella Perikeiromene di Menandro, smorzando gli slanci di gelosia della padrona.
I romanzi greci, compreso quello di Caritone, hanno subito un’influenza significativa del teatro classico, tragico e comico, e anche la caratterizzazione emotiva dei personaggi ne risente. La gelosia funziona effettivamente da motore dell’azione drammatica in molte opere sceniche del V e del IV secolo a.C., e forse già Menandro ed Eronda iniziano ad identificarla con un nome specifico, lo stesso che qualifica il comportamento di Cherea e la sua relazione con l’amata Calliroe.
Bibliografia
ALLAN 2021
W. Allan, “The virtuous emotions of Euripides’ Medea”, Greece & Rome 68.1, 2021, pp.27–44.
ANDERSON 2014
G. Anderson, “Chariton: Individuality and Stereotype”, in E. P. Cueva, S. N. Byrne, A Companion to the Ancient Novel, Malden 2014, pp.13–25.
KONSTAN 2006
D. Konstan, The Emotions of the Ancient Greeks. Studies in Aristotle and Classical Literature, Toronto, Buffalo, London 2006.
LÉTOUBLON, GENRE 2014
F. Létoublon, M. Genre, “‘Respect these Breasts and Pity Me’: Greek Novel and Theater”, in E. P. Cueva, S. N. Byrne, A Companion to the Ancient Novel, Malden 2014, pp.352–370.
MARTINA 2016
A. Martina, Menandrea. Elementi e struttura nella commedia di Menandro, 3 voll., Pisa, Roma 2016.
SISSA 2015
G. Sissa, La gelosia. Una passione inconfessabile, Roma, Bari, 2015.
ZANKER 2009
G. Zanker, Herodas. Mimiambs, Oxford 2009.





























