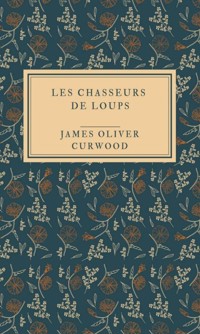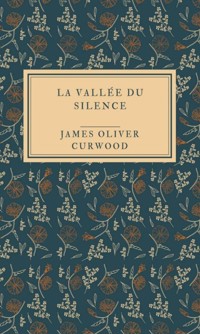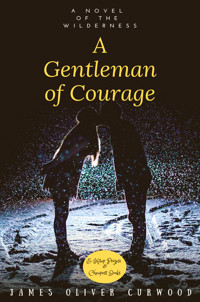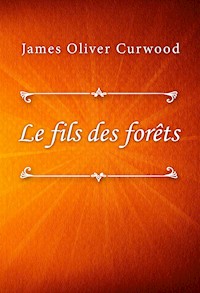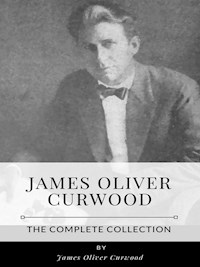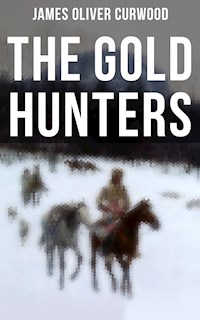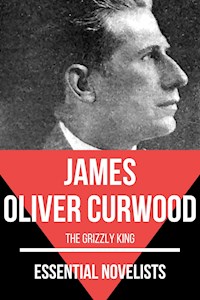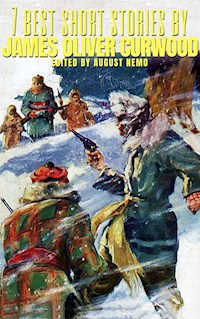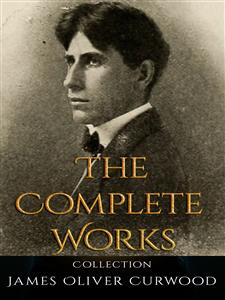1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Booksell-Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
La Vallée du Silence de James Oliver Curwood est une œuvre emblématique de la littérature aventureuse du début du XXe siècle, mettant en lumière les paysages majestueux et sauvages du Grand Nord américain. Le style d'écriture de Curwood se distingue par son lyrisme et sa capacité à dépeindre visuellement la nature, créant ainsi une atmosphère immersive qui transporte le lecteur au cœur d'une nature à la fois belle et terrifiante. Ce roman, qui illustre les thèmes de la lutte entre l'homme et la nature, ainsi que la quête spirituelle et existentielle des personnages, s'inscrit dans un mouvement littéraire qui célèbre l'individu et son rapport avec la nature à une époque où la conquête des territoires sauvages est à son apogée. James Oliver Curwood, né en 1878, était un écrivain et naturaliste passionné par la nature et les vastes étendues du Canada. Son expérience personnelle dans ces contrées sauvages et son intérêt prononcé pour la faune et la flore ont indéniablement influencé son écriture. Curwood, fervent défenseur de la protection de l'environnement, utilise sa plume pour éveiller les consciences sur la beauté fragile des écosystèmes, ce qui transparaît avec puissance dans "La Vallée du Silence". Je recommande vivement "La Vallée du Silence" à toute personne désireuse d'explorer un récit enrichissant qui allie aventure et réflexion profonde sur la coexistence entre l'homme et la nature. À travers ses personnages attachants et une narration captivante, Curwood offre une invitation à se reconnecter à la beauté du monde naturel, tout en posant des questions essentielles sur notre place dans cet environnement.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Lotte civili
Indice
PREFAZIONE.
Il figlio Ugo e l’editore Emilio Treves non vogliono che alla serie delle opere di Edmondo De Amicis manchi il libro che rappresenta l’azione da lui esercitata nella vita politica italiana con gli scritti d’argomento sociale, sparsi finora in giornali e in opuscoli di partito o raccolti alla rinfusa in edizioni di propaganda; pensando che essi pure hanno un singolare valore letterario e meritano di appartenere al retaggio universalmente noto dello scrittore.
Si sa che il De Amicis, la cui anima affettuosa era sempre stata riboccante di simpatia per gli umili e di pietà per i sofferenti, si volse risolutamente al socialismo nel 1890, quando aveva quarantaquattro anni.[1] Disse egli medesimo che il suo caloroso aderire alle nuove dottrine era stato da prima l’espressione dei sentimenti di carità e di giustizia, a cui tutta la sua persona morale era preparata, anzi nata; ma poi era anche divenuto l’effetto di un esame ragionato della questione sociale, quanto gli era stato possibile di farlo, mettendosi coscienziosamente, sebben tardi, agli studî necessarî a quell’esame. Persuasosi che “la sola idealità dei tempi nuovi, la sola che abbia ancora virtù di muovere le masse e che meriti nuovi sacrifizî di energie generose, è la redenzione delle plebi„, sentì di non poter più avere pace nè dignità di coscienza se non nel porre l’opera sua di scrittore in servigio di quella idealità, immolando qualunque suo personale interesse al compimento di tale dovere.
Nato di sentimento, maturato nella riflessione e nello studio, nudrito di amplissime letture, il socialismo del De Amicis doveva avere pronta e piena manifestazione in un romanzo, Primo maggio, ch’egli compose fra il 1890 e il 1893, e di cui si conserva il testo manoscritto. Ma quel libro, ideato nel fervido “entusiasmo apostolico dei primi giorni„, atteso con appassionata curiosità in Italia e fuori, allorchè fu compiuto non piacque più, come opera di pensiero e di arte, al suo autore; il quale, con mirabile esempio di probità letteraria, non volle dare alle stampe ciò che, prima dei lettori, la sua coscienza non poteva sicuramente approvare; non volle tentare la pubblicazione come un gioco di fortuna; e condannò il romanzo, famoso prima che noto, a rimanere inedito. Solo ne aveva messo fuori il primo capitolo, nella Nuova Antologia del 1.º maggio 1892; altri brani e frammenti ne diede liberalmente qua e là, a giornali socialisti che sollecitavano la sua collaborazione; e sarà facile al lettore riconoscerli, anche come confessioni palesemente personali, fra i racconti e dialoghi compresi in questo volume.
In quegli stessi giornali, principalmente nell’Avanti! di Roma e nel Grido del Popolo di Torino, allora e negli anni seguenti, mentre proseguiva la sua azione militante nel partito, che fra asprissime battaglie andava allora organizzandosi per la conquista dei pubblici poteri, il De Amicis pubblicò un gran numero di articoli d’occasione e scritterelli di propaganda, che ora non sarebbe possibile nè conveniente raccogliere tutti quanti. E così si dica delle molte sue pagine sparse contro il militarismo e per la pace fra i popoli.
Egli era stato soldato valoroso, ufficiale devoto alla patria e alla bandiera. Ma per la guerra aveva sempre avuto anzi orrore che amore; e, terminate le sante guerre dell’indipendenza nazionale, aveva deposto la spada, rinunziando alla carriera delle armi, per la quale non era fatto. E naturalmente, con quel medesimo spirito con cui aveva cercato nell’esercito e nella vita militare gli elementi dell’umana fraternità e l’ideale di una civiltà superiore, franca dalla violenza e dal sangue, seguitò, confortato dalla nuova fede politica, e senza però mai vituperare le istituzioni che aveva onoratamente servito, a combattere contro la guerra, a vagheggiare la società dei popoli pacificata dal progresso morale e dalla necessità stessa della comune esistenza economica.
Col titolo di Lotte civili, già consacrato nell’uso dalle varie stampe del Nerbini di Firenze (toltine i due discorsi Per il 1.º maggio e Per la questione sociale, che già si leggono, integri e corretti, nel libro delle Speranze e glorie, e il capitolo La canaglia, che appartiene al libro di Capo d’anno, pagine parlate), sono ordinati nel presente volume i più notevoli scritti minori del De Amicis per il socialismo e per la pace; nè soltanto quelli che altri prima raccolse, ma parecchi di più, tratti da giornali e da opuscoli dispersi, come Una tempesta in famiglia, Un borghese originale, Un episodio della battaglia di Custoza: cose particolarmente interessanti, alle quali la destinazione politica ha fatto torto, lasciandole ignorare agli infiniti lettori che, fuor della politica, ammirano l’arte e l’animo dello scrittore.
È giusto, è doveroso far sì che tutti possano leggere e serbare accanto agli altri libri del De Amicis anche questo, non messo insieme da lui, ma pieno del suo ingegno generoso, il quale vi appare incitato a insoliti ardimenti, a nuove prove di pensiero e di stile, dal proposito di guadagnare il consenso altrui alla sua concezione della giustizia e dell’armonia sociale. Ottenga o no tale consenso, il De Amicis è pur sempre quel maestro di rettitudine e di bontà che tutti possono amare, qualunque siano le loro opinioni; è lo scrittore profondamente sincero, a cui tutti debbono reverenza; ed è in ogni caso tale autore, che niuna parte del suo lavoro ha da rimanere abbandonata.
Torino, ottobre 1910.
Dino Mantovani.
PARTE PRIMA. RACCONTI E DIALOGHI.
Il primo passo. (FRAMMENTO DI UN ROMANZO INEDITO.)
Alberto Bianchini aveva scelto la carriera dell’insegnamento letterario, non solo per la tendenza naturale del proprio ingegno, ma anche per un sentimento capriccioso di vanità mondana: perchè gli pareva che in lui, giovane agiato, elegante, addestrato a tutti gli esercizi cavallereschi, e destinato a brillare nella società signorile, avrebbe acquistato una grazia insolita, sarebbe parso una qualità singolare ed amabile quel titolo di professore di lettere, che suol dare l’immagine d’uno studioso un po’ pedante e un po’ sciatto, rifuggente dal bel mondo per necessità o per natura. Ma questa vanità egli aveva perduta in parte nel corso dei suoi forti studi universitari, e non gliene restava più traccia quando, terminati gli studi, entrava a un tempo stesso nell’insegnamento e nell’arte.
Nell’arte era entrato di sbalzo con un’opera d’immaginazione e d’analisi: le confessioni d’un uomo che, rifatto fisicamente fanciullo, ricomincia la vita scolastica, e giudica dai banchi della scuola, con l’intelligenza e l’esperienza dell’età virile, gli studi, i compagni, gl’insegnanti, i piccoli avvenimenti d’ogni giorno; lavoro, per le sue forze, prematuro, e in molti punti manchevole; ma vivo e ardito, lampeggiante d’idee originali, e condotto, da un capo all’altro, a ondate d’eloquenza colorita e sonora, che avevano avuto una fortuna. Ma dopo questo, cui eran seguiti altri libri, il suo ingegno s’era urtato a un intoppo misterioso e insuperabile. Aveva ottenuto ancora qualche favore la «Storia d’una casa di montagna», nuova nel concetto, ma errata nel disegno, nella quale eran descritti e narrati, giorno per giorno, il lavoro di costruzione, le fatiche, le dispute, gli amori, le piccole vicende degli operai e delle operaie, dalla scavazione per le fondamenta fino alla festa tradizionale per il compimento del tetto, con una sovrabbondanza pesante di particolari tecnici, fornitigli dal muratore Peroni, abitante nella casa: poi egli non aveva fatto più altro che ricercar sè stesso senza ritrovarsi. E uscito deluso anche dalla prova degli studi d’erudizione e di critica, a cui si ribellava la sua indole impaziente e la sua calda fantasia, era vissuto lungo tempo in uno stato doloroso d’impotenza artistica, durante il quale aveva assistito alla morte lenta della sua prima gloria, cercando invano una grande idea onde far scaturire una grande passione, sentendo spegnersi, l’un dopo l’altro, tutti i suoi entusiasmi, e le sue migliori facoltà arrugginirsi nell’inerzia, e intristire nell’ombra anche la bontà del suo cuore. A ventitre anni era quasi celebre, a trentacinque era come morto.
Un piccolo avvenimento fortuito lo mise quasi a un tratto in un nuovo corso di idee. Era entrato quell’anno, a lezioni incominciate, nel primo corso del liceo Brofferio, dov’egli insegnava lettere italiane, un giovanetto di sedici anni, pallido, serio, che il Preside gli aveva annunziato un giorno avanti con cert’aria d’inquietudine, dicendogli che era fratello di un avvocato Rateri, non conosciuto da tutti e due che di nome, direttore d’un giornale socialista, la «Questione sociale», fondato di fresco. Non essendosi occupato mai di tale argomento, che gli appariva come un problema di meccanica celeste, egli non aveva mai letto il giornale, che a Torino leggevano pochissimi, e che gli altri giornali cittadini non rammentavano mai. La presenza di quel giovinetto nella scuola gli destò una vaga curiosità, che lo indusse a cercare il foglio, con la certezza di non trovarvi che dei saggi, non nuovi, di quella vacua rettorica rivoluzionaria, di cui finanche l’eco lontana l’aveva sempre seccato. Ma, leggendone un primo numero, e altri dopo, stupì.
Il giornale era scritto quasi per intero dal direttore, che si celava sotto vari pseudonimi. Il supposto rétore arruffapopoli era una mente ordinata e ragionatrice, dotata d’una forza d’argomentazione mirabile, che allacciava e serrava il lettore per modo, da dargli quasi un senso d’oppressione doloroso all’orgoglio, e aveva una potenza d’espressione tutta propria, attinta, in parte, a forti studi letterari, la quale s’aiutava in mille forme ardite e felici col latino, col francese, col tedesco, col vernacoli, e col linguaggio di tutte le scienze, condensando le idee, con uno sforzo quasi violento in uno stile pieno di asprezze e di scosse subitanee, e come rumoreggiante giù nel profondo, dove pareva di sentir martellare delle incudini, soffiare dei mantici, fremere delle folle.
Egli che ignorava ancora l’arte facile con la quale si fa il vuoto e il silenzio intorno ai propagatori delle idee odiate, si maravigliò che un pensatore e uno scrittore di quella fibra non avesse più autorità e più rinomanza. Digiuno affatto com’era delle dottrine che quegli propugnava con tanto vigore, non poteva seguitare il filo scientifico dei suoi ragionamenti, che richiedevano nel lettore studi e consuetudini intellettuali molto diverse dalle sue; onde si arrestava ad ogni tratto nella lettura come chi ha smarrito la strada in un paese straniero; ma la gagliardia delle critiche, simile a percosse di fruste metalliche, con cui flagellava i vizi e le idee della sua classe; la profonda limpidità dello sguardo col quale, attraversando i tempi, vedeva gli indizi, gli aspetti, le vicende della grande quistione a tutti gli orizzonti della storia; la fede irremovibile nella propria ragione; la superba certezza della vittoria futura, che appariva in ogni suo scritto, piantata sopra un fondamento saldissimo di meditazioni continue e pacate, gli scossero l’animo, gli suscitarono un vivo desiderio di avvicinarsi, studiando la questione, a quel singolarissimo ingegno. Un giorno quegli venne alla scuola a domandare informazioni del fratello e scambiò qualche parola con lui. Il suo aspetto gli rese anche più vivo quel desiderio. Era un uomo sui trentotto anni, alto e diritto, con un viso lungo e regolarissimo, d’una bianchezza e d’una fermezza marmorea, al quale i capelli irti e corti e la barba piena facevano una cornice nera, quasi funerea, e aveva due occhi azzurri velati, che parevan sempre fissi sopra un orizzonte lontano: una testa d’ostinato, una fronte d’uomo imperturbabile, un abito da prete spretato, una cortesia fredda, una voce aspra, e nessun gesto, come se avesse le braccia d’un morto.
Di qui ebbe l’impulso primo che lo volse agli studi sociali....
*
Un caso lo spinse innanzi prima del tempo. Desideroso di conoscere le prime manifestazioni dell’ingegno del Rateri, e un poco anche di vedere in che specie di fucina egli martellava la sua strana prosa di battaglia, andò un giorno a cercar la raccolta del primo semestre all’ufficio del giornale, che era in una strada fuor di mano di Borgo San Secondo, in due stanze a terreno, in fondo a un cortile silenzioso. Visto l’uscio aperto, entrò senza picchiare, credendo di trovar nella prima stanza un segretario o commesso che ricevesse i visitatori; e invece si trovò subito nell’ufficio di redazione, in uno stanzone lungo e nudo come un parlatorio di convento, dove, a capo d’una grande tavola senza tappeto, coperta di giornali, stava seduto il direttore, e ritto accanto a lui una signora e un operaio, che spiccavano sul vano luminoso d’un finestrone. N’ebbe un senso di rispetto, come se il desiderio della raccolta, che l’aveva condotto là, potesse parere al Rateri un pretesto puerile per fargli indovinare l’animo proprio, e quasi per offrirsi alla Causa.
Vedendolo entrare, il Rateri pronunziò il suo nome in accento interrogativo, senza poter reprimere un piccolo moto di stupore, e gli altri due lo guardarono con una curiosità evidente di saper con che scopo fosse venuto. Gli passò sul viso un leggerissimo rossore, che quelli notarono, e, rapidamente, guardando un busto di Carlo Marx che era nel mezzo d’una parete, cercò un altro pretesto alla visita. Ma non ce n’era altri che non dovesse parere anche più finto di quello.
Espresse il suo desiderio.
Allora quei tre lo fissarono con uno sguardo anche più intenso, col quale egli incrociò il suo, curiosamente, indovinando il pensiero di tutti e tre. Uno sguardo gli bastò per capire chi fossero l’uomo e la donna che vedeva per la prima volta. La donna era certo quella Maria Zara, della quale si parlava da un anno a Torino, dilaniandola, a causa della propaganda che faceva tra le operaie, per raccoglierle in associazioni, con articoli e conferenze, che si mettevano in ridicolo: una specie di Luisa Michel, come la definivano. Il suo aspetto non corrispondeva punto all’immagine che il Bianchini se n’era fatta, udendone dire gli orrori che ne dicevano. Dimostrava un trentasei o trentasett’anni: era alta di statura e pallida, e aveva gli occhi scuri e profondi, con due grandi sopracciglia nere, da cui le risaliva fino a mezza fronte una ruga sottile e diretta, che le dava un’aria di energia virile, e sviava l’attenzione della grazia originale, benchè un po’ appassita e quasi stanca, del suo viso pensieroso. Era vestita di nero, col collo nudo, semplice, e pettinata semplicemente: pareva una monaca che avesse buttato il velo, e il contrasto del suo viso spirituale e triste con le belle forme del suo corpo robusto e fermo nell’atteggiamento risoluto d’una donna abituata a parlare in pubblico, aveva non so che di strano e seducente, da cui il Bianchini fu scosso. L’operaio, meno alto di lei, un tipo di giovane russo, di viso fino ed aperto, contornato d’una barba rossiccia, e vestito di panni logori, ma pulitissimi, che lo guardava con gli occhi socchiusi d’un miope, gli parve che dovess’essere — e non s’ingannava — un tal Mario Barra, del quale la «Questione sociale» pubblicava certi articoli intorno all’«organizzazione della classe operaia», veri torrenti di parole e di pensieri monchi e disordinati, in cui si sentiva il balbettìo impaziente d’una intelligenza affollata d’idee, che per la difficoltà d’uscire s’ingorgavano come il liquido nel collo troppo stretto d’una bottiglia capovolta.
Il Bianchini notò una diversa espressione nei tre sguardi che lo fissarono: in quello del Rateri una fredda curiosità, come davanti al semplice enunciato d’un problema aritmetico; in quello dell’operaio una idea di simpatia, che s’avvicinava al sorriso; in quello della donna il senso d’una interrogazione severa e quasi diffidente, ma in cui gli parve pure di scorgere qualche cos’altro, come l’ombra d’una rimembranza. E capì che tutti e tre gli avevano letto nell’anima.
Il direttore gli rispose lentamente, come distratto, che non essendo pronta una raccolta intera, avrebbe cercato di farla mettere insieme, e che, se anche fossero mancati dei numeri, siccome era stabilito che i mancanti si ristampassero, egli sarebbe stato soddisfatto presto o tardi: frattanto, gli avrebbe mandato a casa i fogli che c’erano.
Parlando, s’era alzato egli pure, e stava in mezzo agli altri due, immobile, formando con essi come un gruppo statuario in fondo alla stanza nuda; davanti al quale il Bianchini ebbe un pensiero che gli scosse l’animo, e gli rimase impresso dentro indelebilmente insieme con l’immagine di quelle tre persone raggruppate. Erano le tre grandi forze del socialismo: un borghese; una donna, la grande ausiliatrice invocata ed attesa, senza la quale nulla si sarebbe compiuto, quella che doveva infonder la costanza ai valorosi, e suscitare gli inerti, e svergognare i codardi, e sollevare, soffiando nell’oceano umano, l’onda che avrebbe sepolto il vecchio mondo. Erano il simbolo vivente della rivoluzione futura. E con questo pensiero gli s’affacciò alla mente, quasi visibile come una realtà, l’abusata immagine dell’«alba d’un’età nuova» e gli parve un momento che quelle tre figure immobili e ardite si disegnassero sulla bianchezza di quell’orizzonte ideale.
Fu tentato di dire una parola; ma lo trattenne un senso di dignità, di cui avrebbe saputo dar piena ragione. Si ristrinse a ringraziare, ed uscì, facendo un saluto senza sorriso, a cui non risposero che i due uomini, con un cenno del capo. Uscì socialista....
Come si diventa socialisti.
........ Spronato da quel desiderio, egli si gettò alle nuove letture con la curiosità vivace di un viaggiatore che si affaccia a una terra sconosciuta, sorvolando a tutto il socialismo sentimentale e filosofico del primo periodo, per afferrarsi ai fondatori scientifici della dottrina. Era, per sua natura, singolarmente preparato a ricevere da quelle prime letture una impressione straordinaria, poichè il più vivo e il più profondo dei suoi sentimenti era quello che chiamò «fondamento d’ogni moralità» lo Scopenhauer: la pietà; raffinato in lui da una calda immaginazione. In ogni periodo della sua vita, anche quando egli aveva l’animo più offuscato dall’orgoglio, dalla sensualità, dai rancori, quel sentimento aveva trovato aperta sempre e subito la via del cuore, dal quale scacciava sull’atto, per più o meno tempo, tutti gli altri. Egli non poteva veder soffrire senza soffrire egli stesso con intensità quasi uguale a quella di chi l’impietosiva. La vista di un vecchio povero, d’un fanciullo consumato dagli stenti, d’una donna lacera e piangente, gli dava all’anima una stretta violenta, una angoscia, un impulso di pietà appassionata, che gli faceva vuotar la borsa, che gli avrebbe fatto dare anche i panni che portava addosso, se non gli fosse rimasto altro da dare.
Anche la sola idea astratta d’una creatura umana, che, in mezzo a una grande città, con o senza sua colpa, non ha un tozzo o un pugno del più vile alimento da cacciarsi in corpo per non morire, che manca di quello che non manca al cane, alla belva, all’insetto più schifoso e malefico, gli era insopportabile come un dolore fisico acuto; e per poter vivere e lavorare doveva cacciar di continuo dalla mente, con uno sforzo faticoso, il pensiero che siffatte miserie esistevano intorno a lui, che gli passavano accanto non viste per la via, che si nascondevan forse nella sua medesima casa, sopra il suo capo. Fino allora, per altro, egli non aveva sentito che la pietà della indulgenza e dei dolori individuali. Ma quando, nelle nuove letture, vide per la prima volta la miseria delle classi inferiori, studiata in tutti i paesi, esposta in tutti i suoi svariatissimi aspetti, esaminata in tutte le sue conseguenze funeste, provata con cifre spaventevoli: quando conobbe tutte insieme le forme più miserande e inumane della fatica, gli orrori delle cave, delle risaie, degli opifici avvelenati, delle terre miasmatiche, le moltitudini condannate all’ozio e alla fame, le generazioni infantili falciate dalla morte, che sta in agguato dietro al lavoro, i milioni di tane immonde dove milioni di uomini si ammontano, si ammorbano e s’imbestiano, e ritto davanti a sè, come una montagna di sozzure, il cumulo immenso di alimenti ripugnanti e mortiferi di cui si pasce quotidianamente una moltitudine innumerevole di gente che lavora per un consorzio civile da cui par segregata e reietta; allora tutta l’anima sua ne fu sconvolta, come dalla rivelazione d’un nuovo mondo. Per la prima volta egli vide scorrere davanti a sè l’enorme fiume nero della miseria, e onde di sangue, di sudore e di pianto, ciascuna delle quali travolge una vittima e manda una maledizione e un singhiozzo, e come il «Faust» del Goethe sentì tutte le angoscie dell’umanità pesare sulla sua fronte e schiacciare il suo cuore.
E nel tempo stesso egli udiva dire per la prima volta che questi mali non erano effetto di una legge misteriosa di natura, ma avevano le loro cause nelle istituzioni umane, e queste cause vedeva per la prima volta esposte e dimostrate. E si diede a studiarle avidamente. Era la parte critica della dottrina, la più forte e la più persuasiva, quella in cui regnava un quasi compiuto accordo fra le scuole più discordi, e alla quale erano opposte meno valide ragioni dagli avversari. Qui, nondimeno, errò per qualche tempo in una nebbia d’idee, cercando di afferrarne una, che gl’illuminasse tutte le altre. E ne afferrò una, che era già nella sua mente da un pezzo, ma confusa e fuggevole: cagione prima d’ogni male, il possedimento concesso a un piccolo numero d’uomini di quello che è l’origine di tutti i prodotti e di tutte le ricchezze, e il grande serbatoio di quanto è necessario alla vita comune: la proprietà privata della terra, su cui tutti nascono e muoiono, e l’uso della quale è supremo interesse di tutti; la proprietà che toglie all’uomo il diritto di partecipare al dominio della natura, e fa che milioni d’uomini, trovando già tutto posseduto al loro apparire nel mondo, nascono servi e mendichi. L’ingiustizia e il danno di una tal legge apparvero con la stessa evidenza luminosa che avrebbe avuto per lui l’assurdità di un monopolio dell’aria che respiriamo. E per lo squarcio fatto da questa nella cerchia delle sue vecchie idee, un’altra gli entrò nella mente subito dopo, legata stretta alla prima: la lucida comprensione d’un’altra causa di mali infiniti: il disordine immenso nella produzione di tutto ciò che alla società è necessario, l’anarchia della industria ridotta un giuoco d’azzardo, di cui scontano le perdite le moltitudini che non hanno parte dei profitti, una libera concorrenza che mette in perpetuo contrasto l’interesse personale con l’interesse collettivo, che fa della vita civile una guerra combattuta con le armi dell’astuzia e della frode, che mette il lavoro, funzione sociale senza protezione e senza diritti, in balìa della cupidigia e dell’egoismo, che sperpera un tesoro enorme di tempo, di forze e di ricchezza, trascurando ogni cosa utile ad altri che non frutti a chi la produce, arricchendo gli uni colle spoglie degli altri, mantenendo la società in uno stato perpetuo di affanno e di violenza, in cui si logorano le più nobili facoltà e si scatenano le più tristi passioni umane.
E infine egli comprese, per la prima volta, nelle sue origini e nei suoi effetti, il grande fatto, che non aveva mai meditato della ricchezza: intuì l’ingiustizia che presiede alla sua formazione nell’apparente, non reale libertà di contratto tra chi compra il lavoro e chi lo vende, la figliazione mostruosa del denaro che mantiene delle dinastie di parassiti, vittoriosi fin dalla nascita nella lotta per l’esistenza e conquistatori senza lotta fino alla morte; l’esenzione iniqua della ricchezza individuale dal debito che ella avrebbe verso la società per la grande parte in cui questa concorre a produrla; e riconobbe nei suoi istituti e nell’opera sua la grande feudalità finanziaria, che non contenuta da alcun freno nè di legge nè di morale, posta quasi al disopra del diritto e dello Stato, fornita di tutti i privilegi delle antiche classi spodestate, allaccia nella sua rete il commercio, l’industria, l’agricoltura, incetta e gioca le ricchezze nazionali, accaparra a suo profitto tutte le invenzioni a tutti i progressi, impone ad ogni cosa un balzello enorme che fa duplicare a tutti il lavoro, perturba coi suoi monopoli giganteschi le condizioni dell’esistenza dei popoli, e raccogliendo a poco a poco nelle proprie mani tutti i mezzi di produzione, con cui costringe una sempre maggior moltitudine d’uomini a chiederle pane e a subire le sue leggi, tende a dividere la società in una piccola schiera di dominatori che avranno tutto e in una folla immensa che non avrà nulla, separate l’una dall’altra da una disuguaglianza più odiosa, da un’avversione più feroce, da una contrarietà d’interessi più inconciliabile e più funesta di quella che separava la servitù e la signoria dell’età media.
Quetato il primo tumulto di queste idee, che lo misero in uno stato di rivolta segreta contro la società, si presentò a lui pure quell’eterna domanda: — che fare? — e allora prese ad esame i grandi rimedi, la trasformazione fondamentale di ogni ordinamento, che il socialismo proponeva. Era la parte più debole della dottrina, quella in cui è a tutti più arduo e più lungo acquistare una salda persuasione favorevole.
Egli fu lietamente meravigliato, sulle prime, trovando la teoria della ricostruzione condotta già molto più innanzi di quello che si fosse vagamente immaginato, una enorme quantità di materiali del nuovo edifizio già lavorati e quasi ordinati dal pensiero scientifico di mille intelletti poderosi e pazienti, la nuova vita sociale descritta e dimostrata possibile e quasi perfetta fin nelle sue minime funzioni e in ogni più difficile prova. Poi, voltandosi ad ascoltare le ragioni degli avversari, s’arrestò, sgomentato. Al primo urto della loro critica che affermava assurda la nuova teoria del valore, soffocata dal collettivismo la libertà individuale, distrutto dall’abolizione della proprietà privata lo stimolo al lavoro, impossibile proporzionare legalmente il compenso alla varia natura dell’opera, inconcepibile l’azione d’uno Stato proprietario d’ogni cosa e incaricato di tutte le direzioni e di tutte le iniziative, gli parve che l’edificio crollasse, ed egli indietreggiò, soverchiato per un istante dall’amarezza d’una gran delusione. Ma se non riusciva a persuadersi della possibilità dei rimedi, a che giovava l’indignazione contro le ingiustizie, a che la pietà delle miserie e dei dolori? E questi sentimenti erano già in lui così forti, che non poteva più rassegnarsi a crederli vani.
Una forza prepotente lo cacciava innanzi. Egli aveva bisogno di una fede, oramai, e la voleva ad ogni costo. E allora si mise a cercarla con la passione che vuol trovare quello che cerca e abbatte tutti gli ostacoli sulla sua via. Si lanciò a capo basso contro alla critica nemica del suo sogno, raccolse nuove ragioni contro i suoi argomenti, si dissimulò fra questi i più forti, ingrandendo nella propria immaginazione l’importanza di quelli che riusciva ad abbattere, si afferrò all’idea che la trasformazione si sarebbe compiuta per effetto di eventi imprevedibili e di forze non ancor conosciute, che i vizi dell’ordinamento proposto sarebbero stati corretti con le modificazioni suggerite ed imposte dall’esperienza, che la società nuova avrebbe creato essa medesima, come la natura negli organismi animali, gli organi necessari alle sue nuove funzioni, che dalla concordia dei milioni d’oppressi già vicini alla mèta sarebbe derivato nella società un tal mutamento morale da rendere agevole quasi miracolosamente l’attuazione d’ogni più vasta ed ardita idea; che in fine, quello che innanzi a ogni cosa premeva e s’aveva a fare era di consacrarsi alla santa causa, di proclamare e diffondere il sentimento di giustizia e della intollerabilità dello stato sociale presente, di ordinare per ora le moltitudini intorno a questa sola bandiera, poichè esse non si raccolgono che sotto alla bandiera della negazione, e di suscitare nella gioventù colta e generosa, con l’esempio e con la parola, la fiamma della fede che compie i prodigi e solleva il mondo. Così un po’ per virtù d’entusiasmo, un poco per effetto di persuasione, egli s’era formato una illusione di certezza, che la gioia d’aver dato alla sua vita un nuovo ideale gli fece creder così piena e ferma ed illuminata, da non aver più bisogno di porla alla prova ritornando a pesar le ragioni dei negatori. Datosi alla nuova idea con l’impeto della sua natura, non comunicando più che con le menti che gliela avevano infusa, trovava ogni giorno una nuova ragione in suo sostegno, esultava della sua rapida diffusione, che su di lui aveva forza di argomento, e l’accarezzava in segreto come un tesoro e n’era altero come di una conquista aspettando d’essere abbastanza forte di meditazione di studi per poter professarla arditamente e difenderla da valoroso.
Tutti i suoi ideali passati, intanto, tutte le sue ambizioni di insegnante e d’artista impallidivano davanti a quella nuova ospite dell’anima sua, come al sorgere dell’alba la fiammella del lume con cui aveva vegliato a meditarla....
Fra padre e figlio. (FRAMMENTO.)
La mattina alle dieci, quando fu tornato dalla passeggiata solita, mentre sua moglie e la ragazza erano a messa, gli capitarono in casa Alberto e la nuora.
Egli si slanciò incontro al figliuolo come se non l’avesse visto da un mese. Entrarono tutti e due nella stanza di studio, inondata di luce, tutti e due così freschi, belli, vestiti bene, splendidi di gioventù e di allegrezza, che il Bianchini non potè trattenere un’esclamazione di piacere e rimase un momento immobile ad ammirarli. Ah! quell’Alberto, quel caro figliuolo! Ogni volta che lo vedeva era tentato di cacciargli le mani in quei folti capelli biondi arricciolati, come gliele metteva quand’ora bambino, che ci si perdevano come dentro un mucchio di matassine di seta. Non era molto alto della persona, ma di membra ben proporzionate e solide, e aveva il viso di suo padre, ma raffinato di forme e nobilitato dalla luce dell’ingegno, e quella medesima aria di bontà, ma ingentilita e mista a una franca espressione d’alterezza virile. Egli risentiva sempre davanti al figliuolo la gioia d’un artista mediocre che ha imbroccato per caso un capolavoro. E godeva a metter giù davanti a lui ogni apparenza d’autorità paterna, e a dimostrargli che sentiva la sua superiorità, per fargli meglio comprendere il proprio affetto e la propria gratitudine.
Sedettero un momento tutti e tre intorno a un tavolino rotondo, di contro la finestra, donde entrava un raggio di sole, che dorava il capo del giovane, e metteva in vista la freschezza bianchissima di sua moglie, e il Bianchini parlò subito degli avvenimenti del 1.º maggio, scherzando, preparato a una scrollata di spalle del figliuolo, che viveva tutto nei suoi studi letterari, incurante d’ogni altra cosa.
— Hai visto — gli disse — hai sentito, ieri sera, quei mascalzoni?...
Il figliuolo rispose con indifferenza. Sì, aveva visto. Era rimasto un’ora sotto i portici della piazza, in fondo, davanti al caffè Rossi. E s’arrestò a quelle parole, come se gli rincrescesse di soggiungere quello che aveva in mente. Ma, domandandogli suo padre che cosa ne pensasse, espresse il pensiero.
— Che cosa vuoi — disse. — Per me.... mi fa pena vedere una società che, quando la gente che la fa vivere domanda un po’ più di benessere e un po’ meno di lavoro, per tutta risposta le mostra le baionette.
Il padre lo guardò con due grandi occhi.
— Capisco — rispose poi — ma lo domandino in un altro modo.
— È un pezzo che lo domandano in un altro modo — osservò il figliuolo sorridendo. — Che cosa hanno ottenuto finora?
Il padre tornò a guardarlo stupito.
— Ma, — disse dopo — bisogna vedere se le loro domande sono ragionevoli. Infine.... la condizione degli operai è migliorata molto, da una volta.
— È un’asserzione discutibile — rispose il giovane. — È migliorata per alcuni, è peggiorata per altri, è diventata più precaria per tutti. Ma, ammesso pure che stessero peggio una volta.... ti parrebbe giusto negare un diritto ad un negro affrancato, per la ragione che suo padre schiavo, non ne aveva nessuno?
Il Bianchini non afferrò l’argomento.
— Sta bene — obbiettò — ma.... lasciamo andare; il migliorare la propria condizione dipende anche in gran parte da loro; se facessero un po’ più d’economia, se non avessero dei vizi, se s’istruissero....
— Ma, caro papà — gli rispose con sorriso amorevole il figliuolo — quando i salari bastano appena alla vita, come vuoi che bastino a far delle economie? I vizi! Dio mio, noi lo sappiamo bene che grandi vizi si possono avere senza danaro. E che tempo è lasciato loro per istruirsi?
— Che tempo è lasciato loro per istruirsi! — ripetè il Bianchini un po’ imbarazzato. — Dunque, tu sei per le otto ore di lavoro?
— Certo.
— E credi che le otterranno?
— No.
— Vedi dunque che lo stato attuale delle cose è inevitabile.
— No, padre mio. Tu vuoi dire che lo stato attuale delle cose era inevitabile che si producesse, come fase d’ogni svolgimento di fatti; e questa è la verità. Ma è un’altra cosa. Come lo stato attuale è derivato da un altro, così un altro col tempo succederà a questo, necessariamente, per forze indipendenti dalla volontà dei privati e dei governi.
Il padre lo guardò un’altra volta con stupore; poi crollò il capo, non persuaso. E domandò recisamente:
— In che maniera?
— Ah! in quanto a questo — rispose il giovane sorridendo.... — io non posso saperlo. Si può prevedere a che arriverà la società: ma non seguire la via o le vie per cui passerà per arrivarvi.
— Vorresti dire una rivoluzione? — domandò il padre fissandolo.
— Può anche darsi. O se non una rivoluzione, una serie di scosse violente, di convulsioni sociali, che a poco a poco muteranno radicalmente lo stato attuale.
— E credi che comincerà presto questa serie di.... rivoluzioni? — domandò il Bianchini col sorriso di chi dubita se il discorso sia serio o faceto.
— Credo che sia già cominciata — rispose il figliuolo.
A queste parole il Bianchini e la signora s’alzarono tutti e due insieme ridendo, come per fargli capire che non dubitavano più d’uno scherzo.
— E da quando in qua hai queste idee? — gli domandò la moglie celiando.
E il padre ripetè la domanda, mettendogli scherzosamente una mano sulla spalla: — Giusto; da quando in qua hai queste idee?
Alberto s’alzò piccato e rispose: — Ho parlato sul serio. Come potete supporre che io scherzi sopra un argomento di questo genere?
Il padre cessò di ridere. — Perchè allora non ci hai mai espresso le tue idee?
— Perchè prevedevo che non ci saremmo intesi. Vedete bene che avevo ragione.
— Ma insomma — disse il Bianchini battendosi sulla fronte le dita riunite della mano destra — dimmi proprio chiaro e preciso quello che pensi.
Il giovane rispose con dolce pacatezza: — Ecco quello che penso. Penso che la parte che è data ai lavoratori nel prodotto generale della ricchezza non è proporzionata alla parte che essi rappresentano nell’opera generale della produzione. Penso che non è giusto che quella parte della società che fa il lavoro più necessario e più faticoso per nutrirla, vestirla e ricoverarla e dare all’altra parte il tempo e i mezzi d’istruirsi, non guadagni abbastanza da nutrirsi, vestirsi e ricoverarsi umanamente, e sia esclusa dalla possibilità di istruirsi. Penso insomma, che il lavoro non raccoglie tutti i benefizi, a cui avrebbe diritto, del progresso della civiltà, perchè questi benefizi gli sono intercettati da un difettoso e ingiusto ordinamento sociale. Ecco il mio pensiero.
La signora, con la voce placida, si intromise nella discussione. — Ma, Alberto, come vuoi che tutti si possan trovare nelle stesse condizioni di fortuna?
Il Bianchini approvò con un cenno del capo.
— Non dico questo — rispose Alberto. — Ma perchè si debbono trovare, regolarmente, nelle condizioni peggiori quelli che faticano di più e che sono più necessari? Perchè ci deve essere tanta gente che lavora troppo e non mangia abbastanza, tanta altra gente che lavorando pochissimo, vive nell’agiatezza, e tant’altra che non lavorando punto, nuota nell’abbondanza?
— Ma perchè il mondo è fatto così, figliuol mio! — esclamò il padre, allargando le braccia, maravigliato dall’ingenuità del figliuolo. — Perchè così è sempre stato e sarà sempre!
— No, papà. Così come ora non è sempre stato. C’erano la schiavitù e il servaggio, e non ci son più; c’era il feudalismo, c’era il dispotismo, e sono scomparsi; c’era l’ineguaglianza civile e politica delle classi, ed è stata, almeno legalmente, soppressa. Vedi che il mondo si è mutato; e se può mutarsi non è ragionevole il dire: — è fatto così — per provare che non c’è rimedio alle sue ingiustizie e ai suoi mali.
Il padre esitò un momento.
— Ma come dovrebbe ancora mutare — domandò poi — se dici tu stesso che abbiamo la libertà e l’eguaglianza, che è quanto dire che tutte le strade sono aperte a tutti per migliorare la propria sorte?
Il figliuolo fece un leggiero atto d’impazienza. Poco tollerante della contraddizione per vivacità di natura, lo impazientiva anche di più la contraddizione di suo padre che pure amava tanto, appunto perchè in tutte le altre questioni egli l’aveva sempre trovato cedevole, persuaso o no, alle sue idee. Gli salì alle guancie un leggiero rossore.
— Ecco l’errore — esclamò. — La libertà e l’eguaglianza furono una conquista di fatto per una parte della società; ma rimasero due parole vuote per l’altra. L’eguaglianza vera non può sussistere fin che l’esistenza del maggior numero dipende dalla volontà o dalla fortuna di pochissimi. La libertà non è che per chi ha mezzi e coltura. Chi non ha nè gli uni nè l’altra è schiavo della miseria, della sua ignoranza e del caso. La via a migliorar la propria sorte non è aperta a tutti, perchè tutti quelli che nascono in condizioni privilegiate di fortuna, si trovano già a mezza strada e l’ingombrano, e non c’è uno su mille degli altri che possa raggiungerli e aprirsi il passo fra loro. Pensaci un poco, papà. È una ingiustizia che rivolta. Se non ce ne accorgiamo è perchè i nostri interessi ci hanno fasciata la coscienza.
Il padre lo guardò un’altra volta, più profondamente stupito di prima. Poi si ribellò, ripetendo una frase udita. — Oh, infine — disse con energia insolita — il mondo è di quelli che se lo presero, che sono stati i più forti.
— Saranno stati i più forti una volta — rispose Alberto. — Ora non sono altro, in massima parte, che i più fortunati e i più furbi. — Ma ammettiamo i più forti. Vuol dire che quando, mettendosi d’accordo, saranno i più forti i lavoratori, avranno ragione di cacciarci il tallone sul collo, come noi facciamo adesso con loro.
Il Bianchini ebbe una scossa.
— Ma, Alberto! — esclamò la moglie scandalizzata, guardandolo in faccia, come se gli vedesse una faccia nuova
— Ma, figliuol mio! — disse il padre con un accento di severità triste che non aveva mai usato con lui — chi t’ha ispirato queste idee.... così poco degne di te?
Un’ondata di sangue salì al viso di Alberto
— Poco degne di me?... — rispose, frenando la voce. — Ma scusami, a me pare che fossero indegne di me quelle che avevo prima. E non ho detto la metà di quello che penso. Penso che, così com’è ora, la società è tutta ordinata e diretta a benefizio d’una piccola minoranza, la quale sfrutta tutte le forze dei lavoratori sotto la protezione delle leggi, leggi che ha fatto essa sola e per sè sola; che tutto l’edifizio sociale si regge sull’ignoranza e sull’abbrutimento delle moltitudini; che è la sola violenza che lo tiene insieme, e che questo stato di cose ci corrompe tutti, che è come un’infezione nell’atmosfera morale, la causa prima di tutte le più tristi passioni e delle azioni più nefande e della menzogna d’ogni nostra istituzione e d’ogni nostra parola; e che questo stato di cose non può durare e non durerà e che è sacro dovere di tutti il far tutto il possibile perchè non duri, se anche si dovesse sconvolgere il mondo....
La signora, turbata, con un rapido moto della mano gli chiuse le labbra. Il padre lo fissò lungamente con gli occhi spalancati, e poi, prendendogli le due mani e mettendosele sul petto, gli disse a voce bassa, con accento di affetto profondo e di sincero dolore: — Alberto, figlio mio, sei proprio tu che dici queste cose?