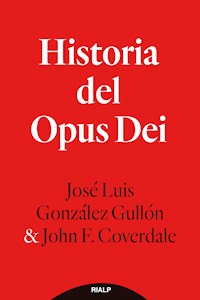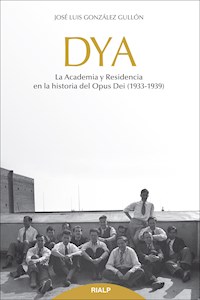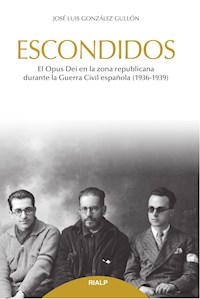4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ediciones Rialp, S.A.
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Spanisch
All'inizio della Guerra Civile Spagnola, nel 1936, il fondatore e la maggior parte dei membri dell'Opus Dei si trovavano nella zona repubblicana. Tutti cercarono ricoveri per fuggire dalla dura repressione rivoluzionaria.
Nel corso dei mesi, i rifugi e gli asili diplomatici non furono più sicuri e si tentarono le fughe e le spedizioni verso l'estero. Grazie all'attenzione di José María Escrivá, l'Opus Dei sopravvisse in mezzo alla tragedia collettiva creata dal conflitto armato.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 782
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
JOSÉ LUIS GONZÁLEZ GULLÓN
ANNI DI CLANDESTINITÀ
L’Opus Dei nella zona repubblicana durante la guerra civile spagnola (1936-1939)
Traduzione di Vittorio Varvaro A cura di Cosimo di Fazio
EDICIONES RIALP
MADRID
© 2023 by FUNDACIÓN STUDIUM
© 2023 José Luis González Gullón
© 2023 by EDICIONES RIALP, S. A.,
Manuel Uribe 13-15, 28033 Madrid
(www.rialp.com)
No está permitida la reproducción total o parcial de este libro, ni su tratamiento informático, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del copyright. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita reproducir, fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
Preimpresión: produccioneditorial.com
ISBN (edición impresa): 978-84-321-6587-0
ISBN (edición digital): 978-84-321-6588-7
SUMARIO
INTRODUZIONE
I. L’INIZIO DEL CONFLITTO ARMATO (LUGLIO - OTTOBRE 1936)
1. La sollevazione militare
Il forzato abbandono di DYA
La situazione in provincia
2. I rifugi alle prese con la violenza rivoluzionaria
Nelle abitazioni dei familiari
Jiménez Vargas lega la sua sorte a quella di Escrivá
Venti giorni di agosto in calle Sagasta
Il villino di calle Serrano e la casa dei Sellés
La famiglia Escrivá Albás in calle Doctor Cárceles
Le donne in contatto con l’apostolato dell’Opera
3. La situazione nel Levante, a Ciudad Real e a Guadalajara
II. LE CARCERI E LA CLINICA PSICHIATRICA (OTTOBRE 1936 - MARZO 1937)
1. Il comitato anarco-sindacalista di calle Ferraz 16
2. Nelle prigioni provvisorie
Sainz de los Terreros e Jiménez Vargas a Porlier
Hernández Garnica e Portillo a Sant’Antonio
3. La casa di Riposo e Salute
Don José e i suoi accompagnatori
I contatti di un bonaerense e di un tenente medico
Un cambio di strategia
4. Una famiglia nelle rovine
5. Il Levante e La Mancha
III. INTORNO ALLA LEGAZIONE DELL’HONDURAS (MARZO - LUGLIO 1937)
1. Come evadere
I renitenti e i disertori
Il rifugio e gli espatri diplomatici
2. L’arrivo nella legazione dell’Honduras
I rifugiati del mese di marzo
La sconfitta sul fiume Jarama
Il passaggio di Fernández Vallespín alla zona nazionalista
3. La vita dei profughi
Diplomatici e isolati
Un salone sovraffollato
La “galguera”
La “esperienza” della guerra
4. Le “prove del Nonno”
La speranza di José María Escrivá
Fortificare i suoi figli spirituali
Note e meditazioni
5. Il singolare governo dell’Opera
I problemi economici e alimentari
L’istanza al Governo
La fuga per via diplomatica
6. La situazione all’esterno del consolato
Zorzano, il pezzo forte
La famiglia Escrivá nell’appartamento dei González Barredo
La non completa solitudine di Rodríguez Casado
7. Il Levante felice e la Mancha generosa
Un trait d’union chiamato Francisco Botella
I movimenti di Pedro Casciaro
Un malato di ulcera
Nel carcere di Valencia
Il contatto con Daimiel
IV. LA FUGA DEL FONDATORE E DI ALCUNI SUOI FIGLI (LUGLIO - DICEMBRE 1937)
1. I preparativi
L’uscita dei “tre fratelli” Escrivá
Le attività di un intendente
L’equipaggiamento e le provviste per il viaggio
Botella e Casciaro
2. Ricongiungimento e contatti a Barcellona
Madrid, Daimiel e le destinazioni militari
L’arrivo a Barcellona
L’unione di due disertori e un profugo
3. Il passaggio dei Pirenei
Imboscati per cinque giorni
Cinque notti di salite e discese
V. UNA BATTUTA D’ARRESTO (DICEMBRE 1937 - MARZO 1939)
1. Uno scenario differente
Il ruolo di Zorzano
I lunghi mesi di asilo nelle legazioni
L’odissea nascosta di Dolores Albás e dei suoi figli
I soldati in provincia
Il singolare caso di María Dolores Fisac
2. Resistere sino alla fine
Tre reclute in fuga
Zorzano, l’asse cartesiano
I tentativi di fuga di González Barredo
Calvo, Espinós ed Hernández
Di nuovo insieme
BIBLIOGRAFIA
NOTE
Navegación estructural
Coperta
Copertina
Crediti
Sumario
Iniziare a leggere
Bibliografia
Note
INTRODUZIONE
Una contesa bellica genera un immane dramma collettivo. Viene eliminata la capacità di dialogo e le armi impongono la legge del più forte. Nelle retrovie la convivenza diventa diffidente verso i vicini e ostile verso chi è nemico. Quando poi si apre la porta al terrore, vengono fuori le più grandi bassezze nelle quali può incappare l’essere umano e, anche, i comportamenti nobili ed eroici. Di questo tipo è stata la guerra civile spagnola (1936-1939), che comportò la lotta e la repressione di famiglie e di popoli fratelli. Il suo svolgimento e le sue conseguenze hanno lasciato ferite che, per diversi motivi, sono ancora percepibili all’inizio del xxi secolo.
All’interno della complessità di un simile conflitto armato, il nostro sguardo si sofferma su quella che allora era una piccola istituzione cattolica, l’Opus Dei, che aveva sette anni e mezzo di vita. Due sono i motivi che ci spingono a studiarla. Da una parte, vogliamo conoscere in che modo José María Escrivá trasmise il messaggio dell’Opus Dei in un contesto di guerra, completamente diverso dalla vita ordinaria. In tal senso, il nostro obiettivo consiste nel comprendere lo sviluppo di questa realtà nei tre anni della conflagrazione e, più specificamente, gli aspetti fondazionali che Escrivá salvaguardò nei momenti di maggiore difficoltà1.
D’altra parte, questo nuovo lavoro deriva dall’aver dedicato la ricerca ad una monografia che analizzava la prima attività corporativa o istituzionale dell’Opus Dei: l’Accademia e Residenza DYA. Questa iniziativa fu attiva durante la fase finale della Seconda Repubblica spagnola (1931-1936). Una volta terminato quel libro, la lettura della documentazione ci spinse ad andare avanti, addentrandoci negli anni della guerra civile.
Sin dall’inizio della ricerca abbiamo verificato che l’evoluzione dell’Opus Dei e la vita dei suoi membri nella zona repubblicana furono molto differenti da quelle del settore nazionale. Anche se non erano storie giustapposte – vi furono contatti fra i due territori in guerra –, il contesto sociale di una zona era completamente diverso da quello dell’altra. Questa circostanza è ancora più evidente nel caso di Escrivá. Essendo il fondatore, la sua presenza in una zona o nell’altra del conflitto segnò decisamente la crescita dell’Opus Dei. Viste le notevoli differenze tra le due zone e avendo raccolto un’abbondante documentazione, decidemmo di scrivere una monografia che analizzasse l’Opus Dei nella zona repubblicana durante la guerra civile.
La storia dell’Opera prima del luglio 1936 è ben nota2. Ricordiamo brevemente che a partire dalla sua fondazione nel 1928 si diffuse a Madrid, in modo particolare nell’ambiente universitario. Un gruppo eterogeneo di un po’ più di centocinquanta studenti dell’Università di Madrid e delle Scuole speciali conobbe José María Escrivá, che nel 1936 aveva trentaquattro anni, e partecipò a diverse attività accademiche e di formazione cristiana nella Residenza DYA, invitato dai loro amici. Lì il fondatore gli parlava del messaggio di santità nell’ambito secolare, in mezzo al mondo.
La diffusione dell’Opus Dei interessò anche alcuni operai e giovani professionisti. Un gruppo di venti laureati fece parte della Società di Collaborazione Intellettuale, un’associazione creata da Escrivá per divulgare cultura e scienza e far conoscere lo spirito dell’Opera. Inoltre, il fondatore illustrò l’Opus Dei a un piccolo gruppo di donne – studentesse e impiegate – residenti a Madrid. Intanto preparava la prima diffusione dell’Opera a Valencia e a Parigi.
Fra gli altri aspetti di quei primi anni, ricordiamo la progressiva incorporazione all’Opus Dei di alcune persone. Nel luglio del 1936 erano ventuno uomini e cinque donne3. Conviene soffermarci sulle loro storie, perché furono i protagonisti del nostro racconto. Isidoro Zorzano, il più anziano, era arrivato all’Opus Dei nel 1930; altri professionisti, fra il 1932 e il 1934: Juan Jiménez Vargas, José María González Barredo, Manuel (Manolo) Sainz de los Terreros, Ricardo Fernández Vallespín e Miguel Bañón4. La loro età oscillava fra i trentaquattro anni di Zorzano e i ventitré di Jiménez Vargas.
Poi bisogna ricordare gli studenti dell’Università di Madrid e delle Scuole speciali. Erano giovani che avevano conosciuto e frequentato don José María in DYA nel biennio 1934-1936: José Ramón Herrero Fontana, Álvaro Portillo, José María (Chiqui) Hernández Garnica, Pedro Casciaro, Francisco (Paco) Botella, Eduardo Alastrué, Vicente Rodríguez Casado, José María (Pepe) Isasa, Enrique Alonso-Martínez, Miguel Fisac, Carlos Arancibia, Miguel Sotomayor e José Arroyo5. A questi studenti si devono aggiungere Rafael Calvo Serer ed Enrique Espinós, che avevano chiesto l’ammissione al fondatore a Valencia nell’aprile del 19366. La loro età variava dai ventitré ai sedici anni.
L’attività apostolica di Escrivá con le donne aveva raggiunto una fase di relativo stallo, perché non aveva trovato persone in grado di trasmettere lo spirito dell’Opus Dei7. Ad ogni modo, un piccolo gruppo continuava a ricorrere alla direzione spirituale con il fondatore: Hermógenes García, di trentanove anni; Felisa Alcolea Millana, di venticinque; Ramona Sánchez Elvira, di ventidue; Natividad González Fortún, di diciannove; e Antonia Sierra, di quarantuno anni, che era ricoverata nell’Ospedale Provinciale, affetta da una malattia cronica8.
L’inizio della guerra civile spagnola comportò per l’Opus Dei un’apparente ecatombe. Dalla sera alla mattina tutto l’impegno profuso fino allora sembrava finito in fumo. Questa era l’impressione che si aveva il 20 luglio 1936, quando il fondatore e gli altri membri dell’Opera abbandonarono l’unico immobile che possedevano, la Residenza DYA, restando alla mercè dei violenti. Ma quello stesso giorno cominciò una vita nascosta, quasi sempre clandestina, che mantenne viva la fiamma della speranza.
Così comincia la nostra monografia, con un capitolo iniziale che analizza l’impatto del movimento rivoluzionario scatenato nelle retrovie repubblicane. Sono elencati i rifugi, in genere presso parenti o conoscenti, che i membri dell’Opera trovarono, sia a Madrid che nel Levante o ne La Mancha; nello stesso tempo, si enumerano i vari modi in cui i membri dell’Opus Dei custodirono il loro fondatore, un compito per il quale Juan Jiménez Vargas non lesinò sforzi.
Poi, il secondo capitolo si sofferma sul momento più delicato della storia dell’Opus Dei durante la guerra civile. Fra l’ottobre del 1936 e il marzo del 1937 quattro persone dell’Opera furono incarcerate e altre due – uno fu lo stesso José María Escrivá – si nascosero in un sanatorio psichiatrico.
Il terzo capitolo, quello più importante in questa monografia, studia l’ampio raggio d’azione profuso da Escrivá dal suo rifugio nel consolato generale di Honduras a Madrid. In quella precaria sede diplomatica riuscì a riprendere i contatti con i membri dell’Opera e poté trasmettere la sua vicinanza, affinché sopportassero le difficoltà con forza e rettitudine. Si metteranno in evidenza alcuni tratti della vita di orazione e della paternità spirituale del fondatore9, i modi di socialità adottati dalle persone dell’Opus Dei e la diffusione dell’Opera in queste circostanze avverse.
L’evasione dalla zona repubblicana di José María Escrivá e di un gruppo significativo di membri dell’Opera occupa il quarto capitolo. Queste pagine dimostrano la complessità dei problemi che dovette affrontare il fondatore, deciso a compiere la volontà divina affinché l’Opus Dei si aprisse strada.
Infine, l’ultimo capitolo è dedicato alla vita dei membri dell’Opus Dei che continuarono a vivere nella zona repubblicana quando il fondatore non era più tra loro. Il racconto permette di notare la costanza di chi dovette aspettare la fine di una guerra che logorò, fisicamente e spiritualmente, la popolazione civile. Questo racconto, che riguarda quasi un anno e mezzo della contesa, dimostra fino a che punto la vita dell’Opera era unita alla persona del fondatore. Nello stesso tempo, emergono figure con una tempra speciale, come Isidoro Zorzano o Rafael Calvo Serer.
La fonte principale per la nostra ricerca è stato l’Archivio Generale della Prelatura dell’Opus Dei (AGP) a Roma. Notevole è il valore dei documenti relativi al periodo della guerra civile. Rare volte non abbiamo trovato carte che chiarissero vicende o spiegassero i motivi di un determinato comportamento. Ci sono stati sommamente utili i diversi diari di Juan Jiménez Vargas, compilati durante il secondo semestre del 1936 e quelli di Isidoro Zorzano, che comprendono l’intero conflitto armato. Queste annotazioni non hanno un carattere strettamente intimo – benché contengano molti riferimenti all’autore –, perché furono scritte con l’intento di far conoscere i primi passi dell’Opera. Un’altra fonte importante è l’epistolario del fondatore e dei membri dell’Opus Dei10.
Abbiamo consultato anche diversi archivi statali spagnoli. Da un lato, è stata utile la documentazione degli archivi militari e del Centro Documental de Memoria Histórica; lì abbiamo potuto consultare le pratiche relative ai nove membri dell’Opera che furono reclutati dall’esercito repubblicano. Dall’altro lato, abbiamo trovato importanti informazioni nell’Archivio Generale dell’Amministrazione (AGA) e nell’Archivio Generale della Città di Madrid (AVM). Allo stesso modo, ci sono stati di aiuto gli archivi del ministero degli esteri di El Salvador e del Cile, oltre ad alcuni archivi personali, come quello della famiglia Sainz de los Terreros.
Tra le fonti secondarie hanno un certo rilievo i ricordi su José María Escrivá e su Isidoro Zorzano redatti per le loro rispettive cause di canonizzazione. Malgrado i limiti propri della memoria del passato, questi ricordi offrono una serie di immagini vive di persone e vicende, che servono a comprendere meglio le decisioni prese. Qualche volta abbiamo riscontrato divergenze, o anche contraddizioni, tra alcune fonti e altre. Allora abbiamo cercato di verificare i dati in nostro possesso, tenendo conto di quelli più probabili.
Dell’infinita storiografia intorno alla guerra civile spagnola, abbiamo consultato le fonti relative ai principali avvenimenti accaduti nella zona repubblicana, in modo particolare quelli che si riferiscono alla popolazione e alla Chiesa nelle retrovie. Invece non ci siamo soffermati su certi aspetti più ampi, come la tensione che serpeggiava in Europa alla fine degli anni Trenta o l’evoluzione del regime di Franco nella zona nazionalista durante la guerra, perché non riguardarono direttamente le persone dell’Opus Dei che erano rimaste nel settore repubblicano.
Le pubblicazioni che trattano dell’Opus Dei durante la guerra civile spagnola sono in maggioranza biografie dei suoi membri; probabilmente la più conosciuta è la vita del fondatore scritta da Andrés Vázquez de Prada11. Alcuni riferimenti si trovano anche nelle monografie sui primi anni dell’Opus Dei, come il racconto di John Coverdale12. Invece l’Opus Dei è praticamente assente nella storiografia generale sulla guerra, cosa che non deve stupire perché nel 1936 era una realtà minuscola.
Pensiamo che, in buona misura, il lettore si trovi alle prese con un lavoro di micro-storia13. L’analisi della vita di poche persone – membri dell’Opus Dei, parenti e amici – sta alla base della descrizione del modo in cui trascorsero gli anni della guerra civile. Infatti, trascriveremo spesso alcuni testi dai quali emergono virtù e limiti di alcuni uomini che spesso furono sottoposti a una straordinaria tensione. Allo stesso tempo, cercheremo di rispondere ad alcune grandi domande sulla contesa, come, ad esempio, la situazione della Chiesa, i motivi della repressione e di certe forme di vita nelle retrovie repubblicane14.
Chi conosce bene la biografia di José María Escrivá o gli eventi più importanti della storia dell’Opus Dei non avrà difficoltà a comprendere i fondamenti della storia narrata in queste pagine. Tuttavia, l’esposizione è comprensibile anche per chi non ha molte notizie sull’Opus Dei. Inoltre, dato che i personaggi principali sono pochi (invitiamo a guardare le poche fotografie inserite nel testo e l’indice delle persone), sarà facile ricordare nomi menzionati spesso.
Per ciò che riguarda la repressione, ricordiamo che fu praticata da entrambe le fazioni in guerra, con aspetti in parte comuni e in parte propri, e che poi proseguì nel regime franchista. Parlandone, evocheremo una delle pagine più tristi della storia spagnola contemporanea, che ancora oggi suscita dolore e polemiche15. Nel nostro caso, concentreremo l’attenzione soltanto sulla zona repubblicana – il territorio in cui si svolse la nostra vicenda storica16 –, soprattutto quella scatenata contro la Chiesa17 e, in particolare, quella che ebbe luogo a Madrid18, dove nel 1936 risiedeva la maggioranza dei membri dell’Opera.
Conoscere l’estensione del terrore e della violenza nel territorio repubblicano è necessario perché solo così si comprendono le strategie di nascondimento e di evasione che compaiono in questa monografia19. I membri dell’Opus Dei non subirono una repressione istituzionale – l’Opera era poco conosciuta perché era stata fondata otto anni prima e inoltre i suoi membri non operavano collettivamente nella vita pubblica –, però si trovarono immersi in un regime politico e sociale che rifiutava violentemente le loro idee culturali e religiose. Il fondatore sfiorò la morte perché era sacerdote e gli altri membri perché erano degli intellettuali cattolici. Per questo motivo alcuni non si arruolarono nell’esercito repubblicano quando furono richiamati e, una volta diventati tecnicamente disertori o comunque ostili, cercarono rifugio in casa di parenti, in sedi diplomatiche o in istituzioni private20.
* * *
Un libro di storia si può comprare a un certo prezzo. È frutto di molte ore di ricerca e di scrittura, di domande complesse e di scoperte inaspettate, di soste in archivi e di scambi di opinioni con i colleghi, di incartamenti che riprendono vita e di frasi che compendiano l’esistenza degli uomini. E quando poi tutto è concluso, si prova la gioia profonda di offrire al lettore un racconto di sofferenze e di speranza.
Rimango in debito con tutti coloro che mi hanno aiutato a rievocare questo tratto di storia del passato. Ringrazio Jesús Longares, maestro degli storici; Javier Cervera Gil e Julius Ruiz, che mi hanno introdotto nei meandri delle retrovie repubblicane; Constantino Ánchel, Eduardo Baura, Joseluís González, José Luis Illanes, José Manuel Martín, Javier Medina, Fernando de Meer, Ignacio Olábarri, María Eugenia Ossandón, Antón Pazos, Pawel Skibiński e Fernando Valenciano, i quali, avendo letto la monografia, hanno dato dei preziosi suggerimenti; Francesc Castells, archivista e confidente nei momenti di stanchezza; i miei genitori, affettuosi e costantemente vicini; infine, Mons. Javier Echevarría e Mons. Fernando Ocáriz, i successivi prelati dell’Opus Dei, che mi hanno messo a disposizione l’Archivio della Prelatura.
I. L’INIZIO DEL CONFLITTO ARMATO (LUGLIO - OTTOBRE 1936)
Nel pomeriggio del 17 luglio 1936 alcune guarnigioni del Protettorato spagnolo del Marocco – costituite soprattutto dalla Legione e dai Regolari marocchini – insorsero contro il Governo. Nei giorni che seguirono quattro dei ventuno generali di divisione più la metà dei comandanti e ufficiali dell’Esercito spagnolo si sollevarono in armi in diverse località della penisola iberica. In poco tempo controllarono la Galizia, quasi tutta la striscia della Castiglia e León, la Navarra, una parte dell’Aragona, Cáceres, Siviglia e altre città andaluse, le Isole Canarie, Mallorca e il Marocco spagnolo. Invece l’insurrezione non ebbe successo nelle città più importanti del paese, come Madrid, Barcellona e Valencia, e in molte zone industriali.
Secondo i manifesti dei militari ribelli, la sollevazione era dovuta al fatto che la Spagna viveva di fatto in un regime anarchico, che aveva incrinato gravemente la convivenza. Gli insorti annunciarono che, appena conquistato il potere, avrebbero formato un direttorio militare che avrebbe annullato il sistema parlamentare fino al ristabilimento dell’ordine pubblico. Invece, non si pronunciarono a favore di un cambiamento di regime politico né fecero riferimento ai diritti della Chiesa.
Sabato 18 arrivarono a Madrid altre notizie sulla sollevazione del generale Francisco Franco nelle Canarie e del Generale Gonzalo Queipo de Llano a Siviglia. L’Esecutivo, presieduto da Santiago Casares Quiroga, annullò alcune cariche castrensi, fece altre nomine di gente affiliata alla Repubblica ed emise dei comunicati stampa nei quali assicurava che il paese era sotto il controllo del governo.
Alcuni militari che avevano previsto una rivolta nella capitale spagnola quel giorno si riunirono varie volte, ma non concordarono un piano definitivo. Questo ritardo, che denotava un alto grado di improvvisazione, neutralizzò un eventuale fattore sorpresa. Invece, molti operai rivoluzionari attribuirono a sé stessi le funzioni di vigilanza e cominciarono a pattugliare le strade con le poche armi di cui disponevano. In serata si formò un battaglione di milizie nel Circolo Socialista del Ponte di Segovia in calle San Giusto 2. Fu la prima forza di carattere volontario e paramilitare organizzata a Madrid.
1. La sollevazione militare
Durante l’anno accademico 1935-1936 José María Escrivá aveva progettato la prima espansione dell’Opus Dei, che sarebbe cominciata l’anno dopo. L’idea si fondava su tre obiettivi concreti. Il primo fu l’acquisto di un immobile per la nuova sede di DYA; il secondo consisteva nell’apertura di una residenza a Valencia; e il terzo prevedeva l’inizio delle attività apostoliche e professionali a Parigi nel marzo del 193721.
Dopo numerose trattative, il 17 giugno 1936 Isidoro Zorzano, Juan Jiménez Vargas, José María González Barredo e Manuel Sainz de los Terreros firmarono il contratto di acquisto di una grande casa situata a Madrid in calle Ferraz 1622. Si trattava di un edificio con cantina, pianterreno, due piani e un attico. Nella parte posteriore la proprietà comprendeva un cortile con un padiglione a vetri, l’abitazione del portiere un garage e un giardino che arrivava sino a calle Juan Álvarez Mendizábal. Il venditore dell’immobile era il conte del Real, Francisco Javier Azlor de Aragón, residente a Parigi.
Il 1° luglio il fondatore, insieme a vari membri dell’Opera e ai pochi residenti di DYA che ancora si trovavano a Madrid – la maggioranza se ne era andata in vacanza –, iniziarono il trasloco di mobili e suppellettili dalla Residenza DYA che stava in calle Ferraz 50 alla nuova sede di calle Ferraz 16.
Il trasloco si concluse lunedì 13 luglio. Senza indugio si misero a lavorare all’allestimento della casa. Apportare le modifiche indispensabili nei vari locali, perché la Residenza fosse abitabile in ottobre – mese nel quale aveva inizio l’anno accademico – comportava diversi interventi che li avrebbero tenuti occupati durante tutta l’estate. Fra le varie cose da fare vi era la modifica di alcuni tramezzi e la trasformazione dello scantinato in oratorio o cappella della Residenza23. E per questi lavori occorrevano operai.
A mezzogiorno Juan Jiménez Vargas arrivò in DYA con una notizia impressionante: il leader monarchico José Calvo Sotelo era stato assassinato24. Commentarono l’accaduto e poi ripresero a lavorare nella Residenza per spostare i mobili nel garage e potere così dare inizio alla ristrutturazione delle camere25. Quella notte José María Escrivá, Ricardo Fernández Vallespín, un residente e i due fratelli Larrocha – che si occupavano del servizio domestico – rimasero a dormire nella nuova sede di DYA26. Il giorno dopo ripresero i lavori che avevano in corso. In un momento di riposo ricominciarono a parlare di Calvo Sotelo e don José María raccomandò a tutti di pregare per l’eterno riposo della sua anima27.
Giovedì 16, durante un intervallo, Vicente Rodríguez Casado s’incorporò definitivamente nell’Opera. La semplice cerimonia avvenne nella stanza di Escrivá28. Un altro avvenimento di quel giorno da notare fu che don José María ricevette dalla contessa de Humanes alcuni gioielli per impiegarli nella realizzazione di un tabernacolo29.
Il forzato abbandono di DYA
Durante i due giorni successivi, i membri dell’Opera continuarono a seguire il programma di lavoro previsto nella Residenza di calle Ferraz 16, pur non dimenticando di ascoltare con preoccupazione le notizie. Escrivá chiese che comprassero una radio – lo strumento di comunicazione più importante del momento, a parte i giornali – per essere sempre al corrente degli avvenimenti.
Il giorno 18 vi furono altre novità. Raccontava Jiménez Vargas: «abbiamo impiegato molto tempo a pulire una parete del salone perché ogni tanto osservavamo i movimenti che avvenivano nella caserma di fronte»30. Si trattava del Cuartel de la Montaña, che ospitava due reggimenti – uno di fanteria e l’altro di artificieri zappatori — più un gruppo di fotoelettriche31. Quando nel tardo pomeriggio finirono di lavorare, don José María pregò quelli che rientravano nelle case dei loro genitori di telefonare per confermare di essere arrivati senza problemi.
Alle quattro del mattino di domenica 19 luglio, l’Esecutivo si dimise e fu sostituito da un altro, di carattere più moderato, diretto da Diego Martínez Barrio. Il nuovo governo durò soltanto poche ore perché alcuni settori rivoluzionari non lo accettarono. Il potere politico passò allora nelle mani di José Giral, della Sinistra Repubblicana, che autorizzò la distribuzione di armi alle milizie dei partiti e dei sindacati del fronte popolare. In poco tempo il nuovo Consiglio dei ministri ingigantì la propria autorità ordinando la depurazione dell’apparato militare e poliziesco, in modo che fosse leale alla Repubblica in guerra. Queste vicende, che si univano allo smembramento delle Cortes, posero fine al sistema democratico liberale che reggeva in Spagna dal 1931. Ebbe inizio un particolare regime rivoluzionario, formato esclusivamente da gruppi politici del Fronte Popolare32.
La tensione sociale crebbe in modo esponenziale. Si verificarono diversi assassinii – fucilazioni nella Casa del Campo – e scene di vandalismo per mano di gruppi rivoluzionari. Alcuni miliziani presero d’assalto il vescovado e crivellarono di colpi il ritratto del vescovo Leopoldo Eijo Garay. Ventiquattro ore prima il prelato aveva abbandonato la città grazie a un avvertimento datogli dal presidente del Governo33.
La famiglia Escrivá Albás visse le incertezze di questa situazione. Un gruppo di miliziani si presentò in casa, in un attico di calle Doctor Cárceles 3. Secondo quello che dissero, volevano farla finita con gli spari isolati di un franco tiratore asserragliato in qualche appartamento di quella strada. Non fecero perquisizioni – il timore della madre e dei fratelli di José María era che frugassero in un baule pieno di documenti dell’Opus Dei –; si limitarono a verificare che in casa non vi fossero persone nascoste34.
Nella Residenza DYA i membri dell’Opera passarono «la mattinata rassettando gli armadi, mentre ascoltavamo le notizie della radio»35. A mezzogiorno avvertirono un certo movimento per strada. Era il momento in cui il generale Joaquín Fanjul entrava nel Cuartel de la Montaña, assumendo il comando e dichiarando lo stato di guerra. Alcune ore dopo alcuni giovani falangisti e monarchici si aggiunsero alla forza adunata nel recinto militare36. Nelle ultime ore del pomeriggio l’Esercito, i miliziani e i cittadini in armi circondarono l’edificio.
Secondo Juan Jiménez Vargas, «il P. [Padre], che si preoccupa incredibilmente dei più piccoli aspetti che ci riguardano, senza contare tutte le preoccupazioni che oggi ha, si è anche preoccupato di cambiare Barredo di camera per metterlo in un’altra più comoda»37. Inviarono anche alcune lettere a vari residenti e amici – avevano preso l’impegno di rispondere nella prima metà di ogni mese a coloro che scrivevano – perché, a causa del trasloco, non avevano avuto tempo fino a quel momento. Quando si avvidero che alcuni soldati, miliziani e guardie si radunavano sul marciapiede pronti a circondare il Cuartel de la Montaña, portarono nella parte posteriore della casa i letti delle camere situate sulla calle Ferraz.
Nel pomeriggio di quel 19 luglio il Governo annunciò la resa del generale Manuel Goded a Barcellona. Jiménez Vargas, che seguiva le notizie, descrisse il contrasto tra le vicende esterne e quelle interne: «Se prevalesse la rivolta, si creerebbe uno stato di cose che non sembra per nulla favorevole alla nostra attività. Ma se Dio ha voluto cominciare la sua Opera in queste condizioni ambientali, Egli sa meglio di noi quello che fa e noi non dobbiamo perdere la serenità con preoccupazioni che nuocerebbero all’intensità dell’impegno al nostro lavoro nell’Opera. Qui c’è il P. [Padre] che dà l’esempio e mette a dura prova la mia pazienza, perché se c’è da caricarsi un materasso, zac!, se lo carica sulle spalle lui senza darmi altro tempo che di protestare per gli sforzi che fa; lui se la prende a ridere. Se bisogna salire al piano di sopra, lui come una freccia sale gli scalini a due a due e va a cercare le cose prima di chiunque altro; e così dalla mattina alla sera»38.
José María Escrivá cercò di rasserenare gli animi cambiando discorso ogni volta che sentiva parlare qualcuno intorno alla situazione del Cuartel de la Montaña. Ciò nonostante, secondo Juan Jiménez Vargas, «questo esternamente, ma sono sicuro che oggi non riuscirà a prendere sonno»39. A fine giornata Jiménez Vargas ritornò a casa dei genitori; appena arrivato telefonò al fondatore perché sapesse che era arrivato bene. Nel frattempo, in Residenza stabilirono dei turni di vigilanza durante la notte.
L’assalto al Cuartel de la Montaña cominciò alle 6 del mattino del 20 luglio. Tra i contendenti si contavano soldati regolari, piccoli gruppi di miliziani socialisti o anarchici, alcune guardie civili, guardie d’assalto e qualche carabiniere. Alcuni pezzi d’artiglieria, installati in Piazza di Spagna, e alcuni aerei provenienti dagli aeroporti militari di Getafe e di Quattro Venti bombardarono l’edificio. Durante l’attacco Jiménez Vargas telefonò in calle Ferraz 16. Rispose José María Escrivá dopo un po’ di tempo, perché si era rifugiato nella cantina della casa insieme a Isidoro Zorzano, José María González Barredo e i due impiegati della Residenza, Gonzalo e Jesús Larrocha. Escrivá lo pregò di telefonare a sua madre per tranquillizzarla. Poi il giovane medico accolse in casa sua Álvaro Portillo e José María Hernández Garnica, che gli chiesero notizie del fondatore. Inoltre cercò di contattare, senza successo, Vicente Rodríguez Casado.
La conquista del Cuartel si concluse poco dopo mezzogiorno, con il tragico saldo di più di 90 morti tra i militari coinvolti nella difesa, oltre a un gruppo di quelli che attaccavano40. In quel momento José María Escrivá pregava con gli altri nello scantinato di calle Ferraz 16 benedicendoli. Poi uscirono uno dopo l’altro dalla parte posteriore della Residenza e si diressero a casa dei familiari. Escrivá si presentò in strada con una tuta azzurra di lavoro utilizzata negli anni precedenti da Hernández Garnica per fare dei lavori in casa. Malgrado la tonsura che portava in testa, nessun miliziano si rese conto che era un sacerdote. Pochi minuti dopo entrava nell’appartamento di sua madre in calle Doctor Cárceles 3, perpendicolare a calle Ferraz. Anche gli altri raggiunsero i loro domicili senza troppe difficoltà.
La caduta del Cuartel de la Montaña scoraggiò gli altri accantonamenti di truppe che si erano ribellate a Madrid, ma che capitolarono poche ore dopo. Molte di quelle unità militari si sciolsero. La capitale restò sotto il controllo di milizie di vario tipo – libertarie, comuniste o socialiste —, che si appropriarono di altre armi trovate nel Cuartel de la Montaña e nel Parque de Artillería. Raggruppate in comitati di residenti o di quartiere, pattugliavano la città con grandi dimostrazioni di tiri in aria o grida per la strada41. Erano diventate di fatto le nuove forze di ordine pubblico42.
La situazione in provincia
All’alba del 17 luglio, giorno in cui nel nord Africa iniziava la rivolta militare, Ricardo Fernández Vallespín ricevette la benedizione da José María Escrivá nella Residenza DYA e subito dopo partì per Valencia su un autobus di linea. Ricardo andava a firmare il contratto di affitto di alcuni appartamenti in quella città. Questi locali erano destinati a creare la seconda residenza dell’Opera dopo la DYA43.
Appena arrivato prese alloggio all’Hotel Balear in calle de la Paz 28. Poi, accompagnato da Francisco Botella e Rafael Calvo, visitò alcuni appartamenti in calle Calatrava. Si convinse che offrivano il minimo di condizioni necessarie per installarvi una residenza di studenti. Poi Rafael Calvo se ne andò ad Alcalalí, paese natale di sua madre situato a nord della provincia di Alicante. Oltre che riposare – era sotto cura per un’ulcera duodenale di cui soffriva da vari mesi44 –, cercava un luogo sicuro, perché a Valencia circolavano voci di una rivoluzione sociale, e tanto suo padre che lui erano persone ben note come attivisti cattolici45.
La mattina dopo Ricardo Fernández Vallespín e Paco Botella incontrarono l’amministratore della casa di calle Calatrava. Durante l’incontro si diffuse la notizia che una parte dell’Esercito, in collaborazione con gruppi politici della destra, si era ribellata. Come misura di prudenza fu deciso di postergare di ventiquattro ore la firma del contratto d’affitto. Quando, però, arrivò la domenica 19, vista la situazione creatasi in città, la riunione non si tenne46.
L’inizio del conflitto sorprese nel Levante altri due studenti dell’Opera. Enrique Espinós – cugino di Paco Botella – stava a Valencia con la sua famiglia47; Pedro Casciaro villeggiava nella tenuta di campagna dei nonni paterni denominata “Los Hoyos”, nel comune di Torrevieja (Alicante); invece Miguel Fisac si trovava ancora nel domicilio familiare a Daimiel (Ciudad Real) e José María Isasa era nella casa tra i boschi dove abitavano i suoi genitori a Molina de Aragón (Guadalajara).
Nel settore controllato dai militari in rivolta rimasero quattro membri dell’Opera: Enrique Alonso-Martínez risiedeva a La Granja (Segovia), José Ramón Herrero Fontana a Logroño, José Arroyo a Béjar (Salamanca) e Miguel Sotomayor ad Algeciras (Cadice)48. Dal giorno in cui cominciò l’insurrezione fu interrotto ogni contatto con Madrid perché le comunicazioni telefoniche e il servizio postale erano sospesi. L’allontanamento dal fondatore rappresentava un rischio per la loro permanenza nell’Opera, in quanto non potevano ricevere né l’incoraggiamento di Escrivá né la formazione specifica dell’Opus Dei. Inoltre, salvo José Ramón Herrero Fontana, che aveva chiesto l’ammissione nel 1934, si erano avvicinati all’Opera soltanto da pochi mesi; due di loro – Arancibia e Sotomayor – non si erano neppure incorporati temporaneamente nell’Opera. Comunque, al momento non potevano far altro che aspettare l’evolversi degli avvenimenti.
2. I rifugi alle prese con la violenza rivoluzionaria
Grazie alle armi ricevute e al forte morale indotto dalla vittoria sui ribelli – in modo particolare con la presa del Cuartel de la Montaña –, la sinistra rivoluzionaria a Madrid si sentì legittimata a usare la forza contro tutto ciò che considerava una minaccia49. A partire dal 20 luglio le organizzazioni libertarie, socialiste e comuniste misero in atto un febbrile processo rivoluzionario che sostituì l’autorità governativa. Si trattò di una rivoluzione politica, sociale ed economica, di carattere più o meno spontaneo alle prime battute, che poi si organizzò man mano che passavano i giorni. In poco tempo i comitati dei lavoratori requisirono industrie ed edifici, emittenti radio e giornali; taxi e automobili private; furono organizzati sistemi di distribuzione dei prodotti alimentari confiscati e pagati con buoni emessi dai sindacati; infine, alcuni carcerati simpatizzanti del Fronte Popolare furono messi in libertà50.
Avvenne anche una sterzata nella vita sociale. Non si ammetteva l’uso del lei, data l’uguaglianza fra tutti; la moglie ora era una compagna e l’amico un camerata; si salutava con il pugno chiuso e un neutro salute sostituiva il tradizionale addio come formula di congedo. Anche il modo di vestire – che manifestava la posizione sociale – adottò un aspetto proletario, sicché i berretti, le tute e i sandali sostituirono i cappelli, gli abiti e le scarpe. Per la strada si moltiplicarono le pattuglie di miliziani che chiedevano a tutti i documenti; le uniche auto che circolavano, a gran velocità, portavano la bandiera rossa comunista o socialista e anche la bandiera rossa e nera della Confederazione Nazionale del Lavoro (CNT) e della Federazione Anarchica Iberica (FAI).
La società civile si vide retrocessa in coda a un gran numero di enti rivoluzionari; fra gli altri «atenei libertari e case del popolo socialiste, radio comuniste e gruppi di difesa confederale, sezioni sindacali di corporazione e di quartiere, residui di brigate poliziesche o caserme di milizie»51. Siccome non esisteva un unico programma rivoluzionario – ogni organizzazione aveva propri progetti e propri desideri, si scatenò un enorme disordine sia nel modo di sostituire le strutture dello Stato sia nell’uso degli apparati repressivi.
Un obiettivo comune fu la localizzazione e la sottomissione del nemico politico. Sotto il nome di fascisti, reazionari o faziosi furono inglobati i militari e i poliziotti, il clero secolare e regolare, i proprietari e gli industriali, oltre ai dirigenti delle destre. La loro ricerca sfociò in una spirale di violenze arbitrarie, che includeva ispezioni, requisizioni, saccheggi, carcerazioni, torture e assassinii52.
Le milizie, costituite in polizia di partito, incalzavano con intensità crescente i rivali politici. Ogni comitato rivoluzionario elaborò liste di villini e appartamenti che dovevano essere ispezionati per procedere alla detenzione dei nemici reazionari53. I nomi che facevano parte di questi elenchi furono ottenuti grazie alle denunce – certe volte fatte dal portiere di una casa o da una persona del servizio domestico – e agli schedari di persone e di gruppi denominati fascisti.
I rivoluzionari ritennero che alcuni fascisti fossero meritevoli della pena capitale54. In genere le sentenze di morte furono pronunciate in locali requisiti dalle organizzazioni politiche o sindacali55. Lì gli autonominati tribunali rivoluzionari interrogarono e “giudicarono” le persone accusate di crimini politici. A parte la scarsa affidabilità delle denunce, chi era presentato come reazionario, doveva dimostrare sul momento la propria innocenza, perché i verdetti possibili erano soltanto tre, e le milizie popolari li eseguivano immediatamente: la messa in libertà, la detenzione in carcere o la esecuzione.
Anche se non fu centralizzata – vi furono numerosi gruppi di indagini, pattuglie di controllo e brigate –, la violenza venne organizzata. Trascorsi i primi giorni di caos, il Governo fece proprio il processo rivoluzionario avviato e tentò di ristabilire il controllo. Fra le altre misure, il 4 agosto istituì il Comité Provincial de Investigación Pública affinché non vi fosse contrapposizione tra la forza pubblica e le milizie armate. Questo Comité Provincial, che dipendeva dalla Direzione Generale della Sicurezza, diresse varie azioni repressive, in parallelo con la polizia. Era formato da persone dei partiti e dei sindacati frontepopulisti. Coordinò l’azione della maggioranza dei tribunali rivoluzionari, che impartivano “giustizia” ventiquattro ore al giorno, e dei gruppi di miliziani e delle brigate anarchiche, socialiste e comuniste, che si assunsero l’incarico delle carcerazioni, degli interrogatori e delle esecuzioni delle condanne a morte56. Per le esecuzioni, in genere portavano i rei in auto – facevano fare loro la passeggiata – in un cimitero o in un pianoro fuori città57.
Secondo i rivoluzionari, la quintessenza della Spagna che doveva scomparire era composta da «i militari, i nobili, i finanziatori della grande industria, i grandi proprietari terrieri, la banca, la Chiesa»58. I socialisti e i comunisti ritenevano che i chierici e i dirigenti cattolici, insieme alla borghesia, controllavano la società – l’educazione, il denaro, le coscienze – attraverso il grande mito da loro stessi creato: Dio. Allo stesso modo gli anarchici pensavano che la Chiesa fosse il più grande ostacolo per raggiungere la libertà e la fraternità di tutti gli uomini59. Benché alcuni fossero inorriditi dall’assassinio, altri decisero che, se si voleva eliminare un ordine sociale che stimolava la disuguaglianza e l’odio, occorreva “purificarlo” mediante, fra l’altro, l’eliminazione fisica dei sacerdoti e di alcuni laici eminenti, oltre la distruzione o la confisca dei luoghi di culto e dei beni ecclesiastici60. Queste misure, indubbiamente traumatiche, si consideravano indispensabili per ottenere una società perfetta, lontana da qualsiasi dimensione religiosa alienante.
La violenza anticlericale affiorò fin dai primi tempi della sollevazione. La mattina del 18 luglio fu assalita la parrocchia di San Ramón al Puente de Vallecas; morì un bambino, figlio del sacrestano della parrocchia. Nel pomeriggio la parrocchia di Sant’Andrea fu data alle fiamme. Nella giornata successiva trentaquattro edifici religiosi furono saccheggiati e incendiati solo a Madrid61. Come conseguenza, diventò impossibile trovare nella capitale una chiesa aperta; per esempio, l’ultima notizia che abbiamo di membri dell’Opera che andarono a una Messa pubblica è del 26, giorno in cui entrarono nel Sanatorio del Rosario in calle Principe di Vergara.
In realtà, il culto pubblico venne sospeso. Il Governo collaborò a questa misura quando il 27 luglio decretò l’appropriazione immediata degli edifici che gli ordini religiosi avevano utilizzato per l’insegnamento e «quelli che, benché non dedicati a ciò, fossero attualmente non occupati»62; e anche l’11 agosto, quando approvò la chiusura delle istituzioni religiose che avessero commesso un qualunque atto che «possa ritenersi di partecipazione diretta o indiretta o di aiuto mediato o immediato al movimento sedizioso»63.
Ma, a parte gli aspetti legislativi e degli attentati agli edifici religiosi, il «furore anticlericale»64 mostrò il suo aspetto peggiore nei confronti delle persone. I gruppi rivoluzionari giustiziarono a loro libero arbitrio sacerdoti e religiosi. Li uccisero con un colpo alla testa o anche dopo torture di estrema crudeltà. L’annientamento del clero fu un atto assolutamente razionale che tentò di raggiungere l’obiettivo65. Nella capitale Madrid risiedevano millesettecento sacerdoti (millecento secolari e seicento regolari); settecento quattro – il 41,4 per cento del totale – morirono assassinati66. Il 95,1 per cento di questi crimini avvenne durante il secondo semestre del 1936. Se lo paragoniamo al resto della società, il clero fu il gruppo socio-professionale che subì più fucilazioni nella Madrid repubblicana, con il 18,11 per cento del totale di assassinii commessi67.
Il 14 settembre Pio XI ricevette in udienza un gruppo di spagnoli in esilio. Il Pontefice ebbe parole di consolazione per «voi, depredati e rapinati di tutto; voi, espulsi e ricercati per essere assassinati nelle città e nei villaggi»68. Per contrasto, aggiunse che la dura repressione aveva provocato «uno splendore di virtù cristiane e sacerdotali, di eroismo e di martirio»69. Restio a prendere una posizione ufficiale, Pio XI concluse il suo discorso invitando ad amare i nemici «con un amore composto soprattutto di compassione e di misericordia»70.
In quelle settimane sia la notizia dei continui assassinii per motivi religiosi, sia le altre forme di terrore rivoluzionario, avevano eliminato in buona parte dei cattolici spagnoli qualunque prospettiva di ritorno all’ordine democratico della Seconda Repubblica. In ottobre parecchi vescovi, cominciando dal primate, il cardinale Gomá, si pronunciarono senza riserve a favore del partito nazionalista71. Molti cattolici decisero che, al di là del ripristino dell’ordine sociale, la vittoria degli insorti era indispensabile per preservare la religione in Spagna. In modo particolare, il tradizionalismo culturale riprese a guardare al passato, si proiettò nel presente e concluse che era cominciata una nuova crociata per la difesa della fede e dell’identità nazionale. Contro lo spietato nemico del cristianesimo non c’era da fare altro che combattere, per Dio e per la Spagna, sino alla fine72.
Nelle abitazioni dei familiari
La rivolta militare avvenne nel pieno della stagione estiva. Molti membri dell’Opera si trovavano a Madrid e collaboravano ad allestire la Residenza DYA per il successivo anno accademico; altri si erano sparpagliati per la penisola. Nella capitale erano rimasti cinque professionisti – Isidoro Zorzano, Juan Jiménez Vargas, José María González Barredo, Manuel Sainz de los Terreros e Miguel Bañón –; quattro studenti – Álvaro Portillo, Eduardo Alastrué, Vicente Rodríguez Casado, José María Hernández Garnica — oltre al gruppo iniziale di donne. Nel Levante c’era un professionista – Ricardo Fernández Vallespín – e quattro studenti: Pedro Casciaro, Francisco Botella, Rafael Calvo Serer ed Enrique Espinós. A questi uomini bisognava aggiungere altri due studenti: Miguel Fisac, che viveva a Daimiel (Ciudad Real) e José María Isasa, che abitava a Molina de Aragón, un paese della provincia di Guadalajara73.
La violenza arbitraria, la paura di un pericolo ignoto e l’incertezza della piega che avrebbero potuto prendere gli avvenimenti segnarono la vita dei madrileni estranei ai movimenti rivoluzionari. Man mano che si sentivano le notizie sulla repressione sfrenata, l’ansia cresceva nelle famiglie che si sentivano potenzialmente o realmente perseguitate. Le perquisizioni sistematiche e ripetute di case private, le telefonate di sconosciuti, le notizie di persone scomparse e le denunce anonime crearono in molte famiglie una situazione di angoscioso allarme74.
Durante i giorni successivi alla rivolta il fondatore dell’Opus Dei e i suoi figli spirituali si rifugiarono nelle abitazioni dei loro parenti e restarono in attesa. Fin dall’inizio José María Escrivá stabilì una serie di priorità. La prima consisteva nel procurare l’integrità fisica di ognuno dei suoi figli nell’Opera, cosa che, al momento, sembrava ottenuta a Madrid. Invece appariva incerta per quelli che si trovavano fuori dalla capitale; per questo motivo cercò di stabilire dei contatti mediante le telefonate o i servizi postali.
In ogni caso, la situazione di guerra mise in evidenza la realtà, del resto ben nota, che l’Opera dipendeva dal suo fondatore; in realtà l’istituzione, essendo molto giovane, non aveva un’approvazione canonica, benché contasse sull’approvazione orale delle autorità diocesane75. In tal senso l’inizio della contesa bellica si presentava come una prova ad alto rischio per l’Opus Dei. Se il fondatore fosse stato assassinato, sarebbe stato molto difficile che l’Opera potesse andare avanti. Ebbene, davanti ai pericoli della guerra, l’atteggiamento di Escrivá riguardo a sé stesso fu di abbandono nelle mani di Dio e di accettazione dei suggerimenti di Juan Jiménez Vargas.
Questo giovane medico aveva una personalità matura, che univa un carattere forte a un’anima appassionata al momento di prendere iniziative. La sua fede in José María Escrivá come fondatore dell’Opera era incrollabile. Juan lo aveva aiutato all’inizio dell’apostolato dell’Opus Dei con gli studenti, e in modo particolare nei preparativi per l’apertura dell’Accademia e Residenza DYA. Ora capiva che doveva proteggere il fondatore e, allo stesso tempo, eseguire i compiti che gli assegnava. E benché corresse un grande rischio personale perché era stato segretario della Agrupación Escolar Tradicionalista, considerata nemica del Fronte Popolare, si dispose all’azione.
Già il 20 luglio Juan Jiménez Vargas s’incontrò con Álvaro Portillo e con José María Hernández Garnica; poi ebbe dei contatti telefonici con don José María Escrivá e con Vicente Rodríguez Casado. Con i dati ricavati, e col suo particolare stile letterario, scrisse questo appunto: «Risulta che io, che ho una sensibilità di cemento, alla fine ho più motivi degli altri di stare tranquillo perché so come stanno tutti»76. Per esempio, quel giorno don José María gli disse per telefono che aveva pensato di ritornare in calle Ferraz 16 prima di sera perché la casa era abbandonata. Juan rispose che, data la situazione, era meglio aspettare il giorno dopo.
Nelle prime ore del 21 luglio Jiménez Vargas si recò nell’appartamento di calle Doctor Cárceles. S’incontrò con Escrivá, che indossava una tuta azzurra. Il fondatore ribadì il suo desiderio di ritornare in DYA con sua madre e i suoi fratelli perché là non c’era nessuno. Di nuovo il dottore lo convinse di non farli uscire dal loro domicilio, giacché la situazione per le strade era molto rischiosa, con i miliziani armati che sparavano in aria, con voci che parlavano di numerosi morti, anche fra i sacerdoti77.
Durante la settimana successiva, Jiménez Vargas ebbe varie riunioni con Escrivá, Portillo, Zorzano, Hernández Garnica e Rodríguez Casado; parlò per telefono con Bañón, Saiz de los Terreros e González Barredo; poi, per incarico di don José María, inviò cartoline postali a Rafael Calvo Serer e a Ricardo Fernández Vallespín. Inoltre – sempre per incarico del Padre –, fece visita alla famiglia di Ricardo per tranquillizzarla e per interessarsi di uno dei fratelli, Carlos, che era alunno dell’accademia militare e che era riuscito a scappare, illeso, dal Cuartel de la Montaña. Ugualmente, avvisò la cuoca e i dipendenti della Residenza DYA perché non andassero là sino a nuovo ordine. E siccome gli rimaneva del tempo libero, scrisse a macchina alcuni appunti sulle lezioni di formazione cristiana che erano state fatte in DYA.
In quei giorni Jiménez Vargas si avvicinò tutte le mattine a calle Ferraz 16. Quello stesso martedì 21 osservò che «c’erano molti vetri rotti, alcuni colpi sulla facciata e i vetri del portone erano in frantumi»78; parlò dell’accaduto con gli Escrivá e, secondo quanto aggiunge, «con il P. [Padre] abbiamo detto che, se vince l’insurrezione, dovremo trovare i soldi per rifare la facciata»79. Il giorno dopo entrò con Zorzano nella Residenza per rimettere un po’ d’ordine imprescindibile. Portarono via la spazzatura, staccarono la corrente elettrica per evitare cortocircuiti, nascosero l’abito talare del fondatore e presero le loro carte d’identità, una cartella e alcune chiavi. Stavano constatando i danni provocati dai proiettili, quando suonò il campanello. Allarmati, aprirono la porta. Era José María Albareda, docente dell’Istituto Velázquez di Madrid e conosciuto da Escrivá80.
Gli ultimi giorni di luglio passarono lentamente nell’appartamento di calle Doctor Cárceles abitato da don José María con sua madre, María Dolores, e i fratelli Carmen e Santiago. Non potendo celebrare la Messa, il fondatore pregava e offriva a Dio alcune mortificazioni volontarie, come non bere acqua per un certo tempo. Il giorno 23 scoprì in casa un messale e, per devozione, disse la “Messa secca”, che consisteva nel recitare le preghiere liturgiche della Messa – salvo la formula della consacrazione – e nel fare una comunione spirituale in sostituzione della comunione eucaristica.
Era particolarmente preoccupato per la sorte dei suoi figli nell’Opera. Mantenne i contatti con quelli che poteva, telefonando o ricevendo alcune visite, tra le quali quella di Hermógenes García, che conversò con lui nel pomeriggio del 23 luglio81. Si preoccupò anche di sua madre, molto inquieta per la situazione che si era creata; così raccomandò a sua fratello Santiago di non parlare di notizie sull’andamento della guerra in sua presenza.
Da parte sua, Manolo Sainz de los Terreros godeva di una certa sicurezza grazie ai suoi «documenti di funzionario dello Stato, come ingegnere del Ministero delle Opere Pubbliche»82. Abitava nella casa paterna, in calle Sagasta 33, insieme col fratello Ramón – della Marina militare, che fu arrestato il 21 luglio – e una domestica di settant’anni chiamata Martina; suo padre, vedovo, e due suoi fratelli piccoli villeggiavano a Fuenterrabía.
Ogni giorno Manolo andava al suo posto di lavoro nella sede della ditta di costruzioni “Alejandro San Román” al numero 10 della stessa calle dove abitava. In accordo col suo carattere piuttosto strano e ingenuo, si presentava per la strada vestito come se fosse un buon miliziano – anche se non ci riusciva del tutto –, come scrisse: «Scarpe senza calze, pantaloni di Mahón, in maniche di camicia, con la barba e spettinato»83.
Gli altri professionisti e studenti dell’Opera per il momento non uscivano di casa, se non per qualche motivo urgente. Un caso particolare fu quello di José María Hernández Garnica che faceva il servizio militare, anche se allora godeva di un permesso per motivi di studio. Siccome non desiderava prendere servizio nel suo reggimento, si rifugiò, insieme ad altri giovani della famiglia, in casa dello zio Pablo Garnica, in calle Jorge Juan. Pochi giorni dopo «arrivò un gruppo di miliziani che perquisirono la casa, introducendosi nell’appartamento. I rifugiati però ebbero il tempo di scendere nel giardino interno dell’edificio, saltare uno steccato e raggiungere la calle Goya, dove si dispersero»84. Non avendo un altro rifugio disponibile, José María fu costretto a ritornare a casa di sua madre in calle Conde de Aranda 14.
Il 25 luglio, festa dell’Apostolo Giacomo, Juan Jiménez Vargas andò in calle Doctor Cárceles di buon mattino. Cercò di dare buone notizie – secondo la radio di Parigi il Governo repubblicano non poteva durare più di alcuni giorni – allo scopo di tranquillizzare la madre di don José María. Poi andò fino alla Residenza DYA per prendere una carta d’identità che González Barredo aveva dimenticato prima della sollevazione. Aveva appena chiuso il portoncino sulla strada, quando sentì che suonavano insistentemente il campanello. Si raccomandò all’Angelo Custode e aprì. Apparvero cinque miliziani della CNT, che entrarono dicendo che requisivano la casa. Il capo del gruppo dopo un po’ dichiarò di essere un ex-cuoco del conte del Real. Secondo Juan, «aveva una stupenda [pistola] Star calibro nove lungo, che faceva invidia»85. Jiménez Vargas mostrò loro il suo tesserino della Federazione Sportiva Universitaria, che, dato che si diceva che fosse controllata dalla FUE – Federazione Universitaria Scolastica, un gruppo studentesco di sinistra –, fece piacere agli anarchici. Tuttavia, perquisirono la casa minuziosamente. Per oltre un’ora Juan cercò di non allontanarsi dal capo della pattuglia, perché era quello che gl’ispirava meno fiducia. Capì subito che volevano rubare oggetti di valore e che erano meravigliati che il padrone fosse cambiato.
Jiménez Vargas tentò di confonderli. Disse che l’edificio era ancora di proprietà del conte e che c’era il progetto di aprire una Residenza che sarebbe stata diretta da un cittadino straniero, un tale Zorzano. I miliziani si mostrarono scettici sulla vera finalità della Residenza quando trovarono alcuni elenchi di nomi, i documenti di un domestico e diversi inni della Gioventù Cattolica. Entrati nella stanza del Padre, scoprirono le discipline e i cilici. Bestemmiarono e Juan rispose con brutte parole, cercando di non dare importanza al fatto che avessero un cappellano. Poi, forzarono la cassaforte e presero il denaro – con un certo cinismo consegnarono a Juan una specie di ricevuta della somma requisita – e portarono via anche i gioielli regalati dalla contessa de Humanes. Il capo del gruppo dichiarò che la casa restava confiscata ed esposero sul balcone una bandiera della CNT86.
Poi uscirono dalla Residenza. Alla vista dei curiosi assiepati sul marciapiedi, Jiménez Vargas fu obbligato a entrare in una macchina. Allora pensò che lo avrebbero condotto nella Casa de Campo; invece fu fortunato perché andarono a casa dei suoi genitori per continuare la perquisizione. Allora si preoccupò veramente perché in camera sua conservava il diario di DYA, un elenco di persone che frequentavano la residenza e le tessere della Agrupación Escolar Tradicionalista. Arrivato nella sua camera, come annotò poi, «mi piazzai davanti al cassetto in cui conservo le cose dell’O. [Opera], che era l’ultimo in basso. Mi fece aprire l’armadio della biancheria. Sicuramente fu l’Angelo Custode perché lo aprii completamente, bruscamente, coprendo il cassetto con lo sportello dell’armadio»87. Dopo aver perquisito l’armadio, il capo dichiarò che ormai aveva visto quanto necessario e che sarebbero andati al domicilio del direttore della Residenza. A quel punto intervenne la madre di Juan. In preda ai nervi, disse che avrebbe accompagnato il figlio dovunque lo avessero portato; ma il capo della pattuglia rispose «che non doveva preoccuparsi perché la CNT non fa quello che si racconta»88. Lo lasciarono libero e se ne andarono.
Juan aspettò qualche minuto, e poi andò a casa di don José María per raccontargli quello che era successo. Poi andò via con Álvaro. Per scaricare la tensione accumulata, «commentavamo che ora deve vincere necessariamente la sollevazione perché altrimenti resteremo senza casa. Avendo messo tutto nelle mani di Dio, eravamo molto tranquilli e persino felici e nessuno avrebbe immaginato quello che stava succedendo vedendoci scherzare per la strada»89. Quel pomeriggio era abbastanza sereno, tanto che riuscì a visitare una monaca che si era ammalata90. *
Jiménez Vargas lega la sua sorte a quella di Escrivá
Dieci giorni dopo l’inizio della sollevazione, il panorama era poco incoraggiante. La rivolta militare aveva vinto in una metà della Spagna ed era avvenuta con il controllo della vita politica e sociale; invece, non aveva avuto successo nell’altra metà, che rimaneva sotto il governo repubblicano. Era ormai chiaro che il conflitto si sarebbe risolto soltanto mediante una guerra, che – così si pensava – sarebbe durata poco, intorno a un mese.
La divisione della Spagna in due parti comportò il graduale consolidamento delle rispettive posizioni, con il conseguente rigetto di quella contraria, vista come un nemico da combattere fino alla sua resa o al suo annientamento. La propaganda prese spazio. Per gli insorti, l’altra parte era una zona rossa, destinata a essere sottomessa alle forze comuniste; per il governo repubblicano, invece, le destre si erano alleate con l’esercito e con la Chiesa per eliminare il sistema democratico, cosa che le escludeva dal gioco politico una volta raggiunta la pace. Non c’era dubbio che la Spagna del dopoguerra sarebbe stata completamente diversa da quella stava per morire.
Alla fine di luglio a Madrid serpeggiò una certa stanchezza e una buona dose di pessimismo dovuto alla situazione di tensione che si viveva nella capitale, alla quale si univa la lotta che l’esercito repubblicano sosteneva pochi chilometri più a nord, sui monti di Guadarrama e di Somosierra. In città le milizie popolari di Sinistra Repubblicana, la CNT, i comunisti e i socialisti continuavano a indagare, con impegno, sull’identità politica delle persone, e in modo particolare su quella degli uomini in età di leva militare. L’incessante attività repressiva di questa forza pubblica era fondata sul timore che nelle retrovie si organizzasse un movimento contro-rivoluzionario91.
Le credenziali che una persona possedeva – i documenti rilasciati prima del 18 luglio – diventarono alleati indispensabili per muoversi e circolare per le strade, e alcune volte un salvacondotto e un’assicurazione sulla vita. L’unico documento di identità ufficialmente riconosciuto era un foglio senza foto chiamato certificato personale. Assai spesso una tessera professionale e un certificato di lavoro potevano servire anche alla identificazione. Ora, invece, il certificato personale o le tessere professionali non erano sufficienti per identificarsi davanti alle pattuglie dei miliziani. I passanti dovevano presentare «la tessera sindacale o politica di un qualunque partito o sindacato aderente al Governo, salvo rarissime eccezioni come la tessera della polizia o di giornalista o quella di funzionario pubblico»92.
Pensando ancora a una guerra di poche settimane, i membri dell’Opera cercarono di adattarsi alle nuove circostanze93. José María Escrivá non possedeva alcun documento di identificazione, a parte il certificato personale; questo, insieme alla persecuzione che si era scatenata contro il clero, rendeva inevitabile il suo isolamento. Continuavano a stare nascosti anche altri professionisti e studenti che temevano per la loro vita. Vicente Rodríguez Casado, invece, poteva avvalersi di una tessera della Croce Rossa, in quanto assisteva i feriti in un ospedale94. Juan Jiménez Vargas aveva la tessera di medico oltre a quella della Federazione Sportiva Universitaria, che gli davano un minimo di copertura95; inoltre, per mettersi a posto, presentò i suoi documenti della Facoltà di Medicina nel caso volessero chiamarlo per occuparsi dei feriti di guerra. Manolo Sainz de los Terreros possedeva una credenziale di ingegnere del Ministero delle Opere Pubbliche oltre a un documento sindacale che gli avevano dato gli operai della ditta per l’edilizia “Alejandro San Román”96; inoltre si procurò un bracciale con i colori repubblicani e un timbro ufficiale. Infine, Álvaro Portillo disponeva di un documento di riconoscimento di aiutante delle Opere Pubbliche, lavoro che svolgeva nella Direzione di Ponti e Fondamenta97.
La situazione di José María Escrivá era la più critica a causa della ricerca, degli interrogatori e, assai spesso, degli assassinii del clero. I sacerdoti sapevano che, se fossero stati identificati dai miliziani, le probabilità di rimanere in vita erano assai scarse. Quasi tutti in un primo momento scelsero di rifugiarsi nelle case dei familiari. Poi cercarono dei nascondigli migliori o tentarono di fuggire in zone in cui non fosse in atto la repressione religiosa98. Tra i primi sacerdoti assassinati a Madrid si conta Pedro Poveda, amico di Escrivá, che fu ucciso il 28 luglio. La notizia della sua morte arrivò a González Barredo e a Jiménez Vargas due giorni dopo, ma non lo dissero a Escrivá per evitargli un nuovo dispiacere.
Il 29 luglio il governo mobilitò i giovani spagnoli di ventitré e ventiquattro anni. Juan Jiménez Vargas, che aveva ventitré anni, non fu arruolato perché gli avevano concesso una proroga per motivi di studio. Comunque, siccome era probabile che di lì a poco lo richiamassero, a richiesta di José María Escrivá andò a vivere nell’appartamento di calle Doctor Cárceles. In tal modo, secondo il suo ragionamento, non sarebbe stato localizzabile se lo avessero cercato a casa sua e, soprattutto, avrebbe dato compagnia a Escrivá. Quando si fu sistemato, parlarono della situazione di DYA e dell’Opera. Escrivá fece questo commento: «Gli sembra molto naturale la situazione del nostro alloggio [il nascondiglio] perché non stava bene che, mentre in Spagna si perseguita la Chiesa, noi stessimo molto comodamente»99. Il giorno successivo fecero orazione per un po’ e pregarono – secondo l’annotazione di Jiménez Vargas – «per la vittoria dell’esercito, perché dice il V. [Padre] che è l’esercito della croce come a Lepanto o a Las Navas de Tolosa, pur con tutte le miserie umane, come anche quelli»100. Il medico notò la fortezza del fondatore, dimostrata nello sforzo continuo per pregare e non perdere la serenità. Accadeva spesso che ripetesse un “fiat”101, come atto di accettazione degli avvenimenti.
In un altro momento, mentre pregavano, il fondatore aggiunse – in riferimento alle persone che si erano appropriate indebitamente di DYA – «che li perdona e che anch’io li perdoni. Io – aggiunge Juan Jiménez Vargas nelle sue note – li perdono, anche se in realtà non ho nulla da perdonare perché non ho mai avuto rancore. A me, personalmente, non hanno fatto niente»102.
Jiménez Vargas assunse come compito personale la protezione del fondatore. Oltre ad adottare le opportune misure precauzionali, valutò ripetutamente se era più conveniente fuggire. Al momento la soluzione di stare al riparo in calle Doctor Cárceles non sembrava cattiva. È vero che don José María era un sacerdote conosciuto nel quartiere di Argüelles; ma erano convinti che nessuno lo aveva visto entrare nella casa il 20 luglio, e d’altra parte la situazione della sua famiglia – una signora vedova che ufficialmente viveva con due figli, dei quali il maschio era ancora un adolescente – non faceva sorgere molti sospetti. Ad ogni modo, e come misura addizionale di mascheramento, don José María si lasciò crescere i baffi.
Passarono i giorni. Il fondatore pregò e cercò di avere un contatto con tutti i suoi figli spirituali perché la mancanza di notizie lo distruggeva. Per lettera chiese che indirizzassero la loro corrispondenza in calle Ferraz 50, perché il portiere della casa era uomo di fiducia. In realtà un gruppo di miliziani si presentò lì chiedendo dei residenti di DYA, ma – a parte il fatto che poterono verificare che l’appartamento era sfitto – il portiere finse di ignorare il nuovo recapito. Grazie a questo aiuto, Manolo Sainz de los Terreros ogni tanto passava dalla portineria di calle Ferraz 50 per ritirare le lettere. Così ricevettero notizie di alcuni amici della Residenza e degli altri dell’Opera, in modo particolare di quelli che si trovavano nel Levante. Per esempio, il 27 luglio aprirono un telegramma di Ricardo Fernández Vallespín nel quale comunicava che a Valencia stavano tutti bene. Subito Jiménez Vargas rispose con un altro telegramma da parte di Escrivá.
Per motivi di sicurezza i membri dell’Opera andarono poche volte nell’appartamento di calle Doctor Cárceles. Quando arrivavano, davano informazioni che alcune volte erano vere e che, invece, altre volte non erano che bufale. Un giorno Sainz de los Terreros venne a trovarli con la notizia, tristemente vera, della morte della contessa de Humanes.
L’arrivo del mese di agosto coincise con un momento di noia per Juan Jiménez Vargas, data la paralisi alla quale era obbligato. Per il suo carattere propenso all’attività, la reclusione lo impazientiva: «Stare tutto il giorno chiuso, tranquillo, a perdere tempo e senza potermi muovere è orribile e non rimarrei se non fosse perché il P. [Padre] starebbe peggio se uno di noi non stesse con lui»103. Uno sfogo possibile si sarebbe potuto trovare nel rapporto con il padre Morata, un agostiniano che viveva nascosto in un altro appartamento e che si era abituato a pranzare in casa degli Escrivá Albás. Ebbene, secondo Jiménez Vargas, malgrado la sua conversazione e la vasta cultura – era un arabista –, il religioso aveva un lieve difetto che rendeva difficile la convivenza.