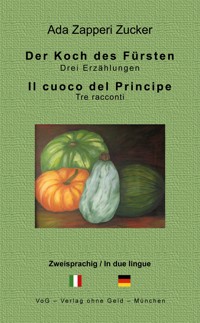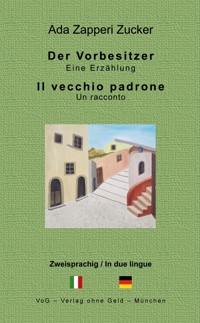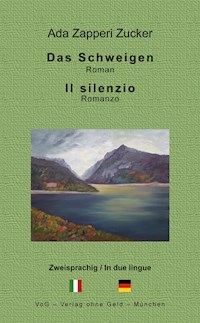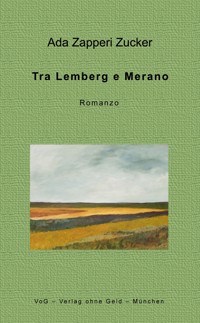
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag ohne Geld
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Un romanzo storico a cavallo fra due epoche, prima e dopo la Grande Guerra. Un'accurata analisi psicologica ma soprattutto storica, per - mette di assistere alla fine di un mondo che getta uno sguardo sugli abissi futuri, sia da un punto di vista politico che sociale: le prime avvisaglie di emancipazione femminile, la revi - sione del ruolo maschile anche se appena ac - cennata, i rivolgimenti che cambiano radical - mente le suddivisioni politiche nella carta geografica, soprattutto dell'Europa orientale. Ma anche una storia di rapporti umani, fra uomini e donne, come accade in tutte le regioni e le epoche del mondo. E infine un esperimento az - zardato, e cioè il tentativo di uscire dalla finzione letteraria per entrare nella realtà del XXI secolo, compiuto con un viaggio nell'attuale Lemberg, dopo due Guerre mondiali, dopo tanti sconvolgimenti politici, per incontrare una cit - tà che cerca una propria identità storica; una città dove si scoprono parti di un grande passa - to anche culturale rappresentato da una delle più belle stazioni ferroviarie d'Europa, un favoloso Teatro, strade costeggiate da ville lussuose in stile Liberty e tanto altro ancora. Un'espe - rienza estremamente interessante con la quale si chiude il romanzo in una nuova attualità.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 262
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Questo romanzo nel 2012 ha vinto il primo premio del concorso letterario Casentino in Poppi (Toscana) ed è stato pubblicato col titoloTeatro di ombredalla Edizioni Helicon, Rieti
Una versione in lingua tedesca è stata pubblicata nel 2020 col titoloZwischen Lemberg und Merandal Verlag ohne Geld, Monaco di Baviera
Ada Zapperi Zucker è nata a Catania. A Roma ha iniziato gli studi di canto e pianoforte per poi concluderli alla Musikhochschule di Vienna. Insegna canto in Germania e in Sudtirolo.
Ha collaborato al Dizionario Biografico degli italiani dell’Istituto Treccani, all’Enciclopedia dello Spettacolo e all’Enciclopedia Universo De Agostini.
Cantante lirica ha svolto la sua attività prevalentemente all’estero, soprattutto in Austria e Germania. Col pittore sudtirolese Gotthard Bonell ha studiato pittura e partecipato a diverse mostre.
I suoi scritti letterari hanno ottenuto vari premi nazionali e internazionali, i più importanti sono:
2020
Secondo Premio
San Domenichino
per
Due donne del Sud
2017
Menzione d’onore
Casentino,
per il romanzo
La casa del nonno
2015
Primo Premio
San Domenichino
per i racconti
La Cucchiara
2012
Primo Premio
Casentino
per il romanzo
Teatro di ombre
2012
Premio
Stiftung Kreatives Alter,
Zurigo, per i racconti
Le inquietudini della sora Elsa
2011
Primo Premio
Chianti
, per il romanzo
Il silenzio
2008
Primo Premio
Giovanni Gronchi,
per i racconti
La scuola delle catacombe
Indice
PARTE PRIMA
1906 LEMBERG
L'albero del diavolo
Estate
Tanta Melanie
La governante
Gli Huzuli
Una serata mal riuscita
Un sogno
Axenia
Incantamento
Pan Bodynski
Turbamenti
Amore?
Porte
Soliloqui
Grandi cambiamenti
Aria nuova
Fine della guerra
Rivoluzione?
Vecchi amori
Lemberg cento anni dopo
Bibliografia
PARTE PRIMA
1906
LEMBERG
L'albero del diavolo
L’estate del millenovecentosei fu particolarmente calda. In campagna giorno e notte non si respirava più.
La signora Franziska Bodynska, pani Bodynska per la sua gente, dopo essersi rigirata inquieta fra le lenzuola umidicce, si alzò, stanca, più che stanca, scontenta. Un’altra notte finita, ecco l’unico motivo di sollievo col quale iniziare una nuova giornata.
Dormiva male e quel poco di sonno, fra un risveglio e l’altro, era sempre disturbato da sogni inquietanti: da qualche tempo aveva preso a sognare di una porta che si chiudeva. Nient’altro. Ma bastava perché si svegliasse, ansante, preda del più insensato terrore. Niente di più innocuo di una porta che si chiudeva da sola, spinta da una mano misteriosa: cosa vi si nascondeva dietro? E di chi era la mano che la spingeva? Lì dietro, ne era certa, stava accadendo qualcosa che la spaventava oltre misura, non sapeva cosa. Da sveglia frugava disperata nella memoria e non riusciva a collegare quella scena con qualcosa accaduta nella realtà. Pensava a tutte le porte della sua infanzia, perché almeno di questo era certa, lì c’era di mezzo la sua infanzia, però non ne ricordava una in modo particolare.
La notte le era nemica. Odiava andare a letto, preferiva sonnecchiare distesa su un divano, vestita e sempre pronta ad alzarsi; ma la sera, quando il cielo cominciava a oscurarsi, non amava più neanche i divani; sapeva che si avvicinava l’ora ufficiale del sonno e si comportava proprio come una bambina capricciosa, lei che da piccola non lo era mai stata, questo poteva ricordarlo con estrema sicurezza. A letto, poi, restava per ore sveglia, o almeno così credeva, finché il prossimo incubo le dimostrava il contrario.
Finalmente, quando vedeva la luce filtrare attraverso le imposte della finestra, si decideva a tirare il cordone della campanella. Voleva alzarsi, aveva bisogno di aiuto, di un incoraggiamento anche. In lei c’era l’inerzia, la passività della bambina abituata a lasciarsi maneggiare, vestire, lavare, priva di iniziativa, o meglio priva di ogni volontà. Non si trattava di un capriccio: non amava toccare il proprio corpo, neanche per vestirsi, lavarsi. Un disagio che si portava dietro ormai da anni, forse da sempre. Quel corpo le era estraneo. Preferiva vedersi vestita di tutto punto, così come la vedevano gli altri.
Mai le era venuto anche solo il pensiero di guardarsi allo specchio nuda, neanche da ragazza. Non si trattava di eccessivo senso del pudore, solo di rifiuto di sé, un rifiuto radicale del quale non era affatto cosciente. Ora, a quarant’anni si considerava una donna anziana e meno che mai accettava il proprio corpo. Soltanto sul viso cercava ogni mattina i segni che avrebbero dovuto confermare il suo declino, qualche piccola ruga ai lati degli occhi, la pelle un po’ avvizzita, due pieghe marcate agli angoli della bocca: lo spettacolo della propria decadenza le toglieva quell’ultimo briciolo di slancio che l’avrebbe aiutata a iniziare la giornata. Poi passava alle trecce sciolte, quelle stesse trecce che per anni avevano rappresentato un motivo di orgoglio, forse anche l’unica vera bellezza in una persona di per sé modesta in ogni sua espressione. Era stato detto, in altri tempi, che erano seconde soltanto a quelle dell’imperatrice Elisabetta. Ora avevano perso in corposità e in lucentezza oltre che in volume. Perfino il colore biondo rossiccio si smarriva nel castano più banale, senza contare la mortificazione dei fili bianchi sempre più numerosi. Solo gli occhi, di un verde smeraldo, quasi da gatto, continuavano a mantenere la trasparenza propria del cristallo, gelido e inaccessibile; e un’innocenza disarmante, infantile che turbava, metteva a disagio i suoi interlocutori: il suo non voler diventare adulta si rispecchiava in quegli occhi ora sempre più spesso offuscati da un velo di malinconia.
Stancamente si lasciò aiutare dalla sua vecchia domestica ad allacciare il corsetto, a mettere a posto i lunghi capelli, senza alcuna partecipazione, continuando a scrutarsi nello specchio forse cercando un’immagine che non riusciva a trovare.
Infine uscì.
Da quando era in villa, e cioè dall’inizio di giugno, aveva preso l’abitudine, prima di fare colazione, di uscire col carrozzino; amava fare un giro nel suo podere, respirare l’aria fresca carica ancora degli umori notturni, lasciarsi portare fuori casa, ancora mezzo addormentata, come una bambina piccola nella sua carrozzina, priva di volontà, in una sorta di sonnolenza nella quale si trascinava poi lungo tutta la giornata.
Lontano, quasi una fata Morgana, apparivano le montagne avvolte ancora da una leggera foschia. I primi raggi del sole avrebbero messo in fuga quei vapori leggeri che vagavano ancora sulla campagna sottostante.
Pani Bodynska non degnava le montagne di uno sguardo.
Neanche le piante del suo giardino incontravano il suo interesse: solo un albero, un vecchio albero ormai cavo, a un centinaio di metri dalla villa, isolato su un piccolo pianoro, attirava la sua attenzione. Era come se proprio da quella pianta si aspettasse il miracolo, il qualcosa di straordinario che avrebbe finalmente spezzato la monotonia delle sue giornate. Forse voleva soltanto accertarsi della sua presenza, ogni mattina, che non fosse sparito come un fantasma della notte insieme al suo abitante. Perché di questo, come tutta la gente della zona, era convinta: quell’albero era abitato.
L’albero, che aveva dato nome a tutta la contrada, (Pod diabelskim drzewem – All’albero del diavolo) aveva una sua storia particolare, piuttosto macabra, tipica della regione. Un centinaio di anni prima, si raccontava, appeso a un grosso ramo di quell’albero era stato trovato un uomo. Impiccato. Si poteva vedere da lontano come penzolava, appena mosso dal vento. Un peso leggero, del resto, poche ossa con qualche grammo di carne, tenute insieme da quattro stracci puzzolenti. L’uomo, un ubriacone conosciuto da tutti per la sua brutalità, non si sapeva bene di che cosa vivesse e se aveva un soldo lo spendeva subito nella bettola del villaggio.
Nessuno pensò a un suicidio: perché avrebbe dovuto farlo? Se fosse stato per miseria, tutto il villaggio avrebbe dovuto organizzare un suicidio collettivo. Non ci si uccide per fame, questo lo sapevano tutti; la morte arriva da sola, conosce la strada, non è necessario chiamarla.
La gente del luogo aveva però bisogno di una spiegazione. Furono tirati in ballo il diavolo, i coboldi, esseri tutt’altro che innocenti, gnomi, briganti. Ci fu chi affermò fosse la vendetta di una vecchia donna dove ogni tanto passava qualche ora della notte, ma nessuno riusciva ad immaginare come avesse potuto issarlo così in alto e alla fine impiccarlo.
Dopo lunghe discussioni si arrivò a una conclusione: era stato impiccato, di questo nessuno dubitava e c’era di mezzo il diavolo.
Da allora l’albero, compresa tutta la zona circostante, acquistò il nome di ‘albero del diavolo’ mentre sarebbe stato più appropriato chiamarlo ‘albero dell’impiccato’. In tal caso però sarebbe venuto a mancare il lato magico, molto importante per il rituale che subito si istituì: chiunque passava in prossimità dell’albero doveva segnarsi tre volte e sputare. Chissà perché bastasse sputare tre volte all’indirizzo del diavolo, davanti, dietro, a sinistra e poi? La destra restava scoperta, nessuno però ci fece mai caso. Del resto si sa che il tre è per sua natura un numero magico.
Ad ogni modo, essendo il posto piuttosto sopraelevato, anche da lontano era sempre possibile vedere qualcuno gesticolare convulsamente, quasi fosse stato assalito da uno sciame di vespe.
A dar ragione alla teoria del diavolo, poco tempo dopo un fulmine si abbatté durante una notte di tempesta proprio su quell’albero colpendolo in pieno, inutile aggiungere che questo avvenne per la festa di Sant’Elia, il dio del fulmine. In quella regione, dove la religione cristiana conviveva pacificamente con la mitologia, ciò poteva avere un solo significato: Sant’Elia aveva tentato di uccidere il diavolo. Un duello ad armi pari però, tanto è vero che il diavolo, usando uno dei tanti trucchi che solo lui conosceva, anche questa volta era riuscito a farla franca; l’albero infatti si era spaccato in due, qualche ramo e parte della corteccia aveva preso fuoco con danni più o meno gravi, in ogni caso non tali da impedirgli di continuare a viverci indisturbato fino al prossimo duello. Una potenza superiore ci aveva soffiato sopra, nessuno ebbe dubbi.
L’albero, infine, col suo satanico inquilino cominciò a deperire.
Ogni nuova stagione metteva sempre meno foglie. Solo sui rami più alti. A volte accadeva che per due e anche tre anni non si muovesse niente; tutti allora pensavano che ormai fosse suonata l’ultima ora. Poi, quando uno meno se lo aspettava, ecco apparire i primi germogli alquanto malaticci, privi di forza, che stentavano ad aprirsi. Un tentativo destinato a fallire. Nessun santo era in grado di aiutare il povero albero, dato che il diavolo ne succhiava le sue linfe per sopravvivere lui stesso. Questa l’opinione generale.
In realtà si trattava di un’antica quercia, maestosa nel suo squallore, vecchia di qualche centinaio di anni; un albero pieno di storia, testimone silenzioso di chissà quante vicende umane. Le forti radici, nonostante le intemperie, i fulmini e le guerre che non poche volte avevano sconvolto la regione, affondavano ancora saldamente nella terra, quasi una sfida contro il tempo e contro ogni magia. Del resto anche senza la leggenda del diavolo la gente lo avrebbe rispettato con religiosità primitiva, anzi venerato come una divinità antica rimasta lì per caso, lasciata indietro, dimenticata durante il grande esodo degli dei dal mondo. Mai avrebbero usato del suo legno per riscaldare le stufe durante le fredde giornate invernali.
Ovvio che un albero abitato dal diavolo non poteva essere abbattuto e tanto meno sradicato, se non volevano cadere in disgrazia per generazioni e generazioni.
Pani Bodynska non avrebbe mai ammesso di essere superstiziosa. Pur simulando una certa indifferenza non mancava mai di ascoltare i racconti della governante, storie di spiriti, vampiri, briganti, leggende spesso risalenti a fatti realmente accaduti che la fantasia popolare variava, ingigantiva, modificava fino a farne nascere qualcosa di soprannaturale: il gusto per il prodigioso era molto radicato in quella regione. Conosceva molto bene la storia dell’impiccato e dell’albero del diavolo e mai avrebbe dato ordine di togliere di mezzo quel vicino infernale. In fondo godeva segretamente di avere nelle sue proprietà una reliquia, un fossile di antiche sacralità. Chissà, forse era un dio vero e proprio, l’ultimo dio deciso a non lasciare la sua terra, nonostante l’abbandono dei suoi confratelli.
Per questo motivo chiedeva ogni giorno al suo cocchiere di passare davanti all’albero del diavolo, anzi pretendeva che rallentasse il passo del cavallo per poterlo osservare più da vicino, nonostante le proteste del pover’uomo che si segnava con una mano mentre con l’altra cercava di far correre il suo animale. Questo era indubbiamente l’unico momento in cui fra cavallo e cocchiere non esisteva nessuna intesa, dato che se con le redini lo invitava a rallentare, con la voce gli comandava tutto il contrario.
Estate
La passeggiata mattutina di solito proseguiva lungo stradine solitarie, attraverso grandi campi coltivati a grano; mari verdi e poi dorati, ondeggianti al minimo spirare di vento, che sparivano lontano, al confine con l’orizzonte.
Durante la stagione della mietitura file di contadini falciavano il grano dall’alba al tramonto.
Ogni giorno pani Bodynska ripeteva lo stesso percorso attratta da quella scena. Era affascinata dalla sincronia nel movimento delle braccia e delle gambe, lenta, regolare come una danza, ignara dello sforzo muscolare, della concentrazione ed esperienza che quel lavoro richiedeva. Gli incidenti, anche se rari, lasciavano un ricordo permanente in chi ne era rimasto vittima, e non soltanto: costituivano un tema di non trascurabile importanza per chi ne era stato anche solo testimone; la sera poi, seduti nella solita bettola dell’ebreo – gli ebrei avevano una specie di esclusiva per quel tipo di rivendita –i contadini si dilungavano in racconti molto circostanziati sull’accaduto, con aggiunte e commenti di varia natura.
Lei non sapeva niente di incidenti né della miseria della sua gente. Evitava infatti accuratamente di passare dal villaggio, quattro capanne di legno col tetto di paglia che scendeva spiovente fino a mezza parete tanto da coprire buona parte delle finestrelle, impedendo così alla luce di penetrare in quell’unico locale dove si cucinava, si dormiva, spesso in compagnia di qualche gallina o di un maialino, più spesso di un malato; dove si consumava la vita, giorno per giorno uguale, senza speranza di miglioramento. Un fazzoletto di terra si stendeva davanti a ognuna di quelle casupole; in quei piccoli orti, ben recintati, agli animali non era permesso di entrare, per nessuna ragione. Ma nonostante le cure cui erano fatti oggetto, non producevano mai abbastanza per sfamare le famiglie, di solito assai numerose.
Lungo la strada di terra battuta che attraversava quell’agglomerato di case era possibile vedere di tutto: bambini sporchi e seminudi, file di oche che contendevano il terreno a galline e maialini, rifiuti di varia natura, senza escludere escrementi umani e animali, dato che mancavano fognature e qualsiasi altro tipo di servizi. In primavera quella strada si trasformava in un’immonda cloaca mista alla neve che si scioglieva, al fango, alla spazzatura che regolarmente veniva buttata fuori dalla porta di casa. Qua e là venivano poste assi di legno per passare da una sponda all’altra, col rischio di scivolare in quella melma, e non doveva essere un pericolo da poco se una volta, così riferiscono i giornali del tempo, vi annegò un bambino.
Dalle file dei mietitori a volte si alzava una voce di donna rozza, stridula, che intonava un canto, per segnare il ritmo, ma anche per scacciare la stanchezza e la monotonia di quel lavoro. Canti ripetuti meccanicamente senza tener conto del significato delle parole; forse ognuno cantava in una lingua diversa sulla stessa melodia. La seconda strofa veniva subito intonata da tutti, in un coro assai disordinato, mentre la voce solitaria si alzava sovrastando le altre, quasi in una sfida sonora. Non erano canti allegri: raccontavano di miseria, di inverni gelidi e estati calde, di amori traditi, nostalgia di gioie perdute o mai conosciute. Melodie struggenti, antiche, di origine slava, conosciute da tutti in quella regione, un vero crogiolo di popoli e di lingue diverse: Polacchi, Rutenio Ucraini, Huzuli o Huculi, Armeni, Bojki, Rumeni, Zingari ed Ebrei di mezza Europa emigrati in Galizia per sfuggire ai pogrom e alle persecuzioni che subivano da secoli.
Ogni giorno affascinata da quei canti, da quella sorta di danza dei falciatori, Pani Bodinska chiedeva al cocchiere di andare al passo. Abbandonata sui cuscini, socchiudeva gli occhi abbagliati dal primo sole riparandosi sotto un minuscolo ombrellino di pizzo bianco, quasi uno schermo fra sé e il resto del mondo. I contadini la guardavano appena. La conoscevano tutti e la salutavano solo se proprio non era possibile fare altrimenti. La consideravano una straniera, una che trascorreva qualche mese l’anno da quelle parti, abitava nella casa padronale come un’estranea, pur essendo la moglie del padrone e dopo un certo tempo spariva. Di lei non restava neanche il ricordo. Quegli occhi sembrava vedessero oltre le persone stesse, persi in chissà quali visioni lontane e trasmettevano un senso di distanza, un gelo che sconcertava. Se a volte si trovavano a fare qualche commento su di lei concordavano tutti su un punto: era arrogante, avara, dura di cuore.
Chi invece veniva rispettata e segretamente riconosciuta come la vera padrona della villa era la governante, Frau Mitzi Greiner.
Il cocchiere di casa, figlio di un ruteno – lui ci teneva però a essere considerato polacco – quando la sera seduto nella solita bettola del villaggio tra un bicchiere e l’altro si dava un mucchio di arie sproloquiando sulle faccende dei suoi padroni, affermava che la governante era la sola a comandare in villa.
«Frau Mitzi ha ordinato…» diceva, oppure «Frau Mitzi ha deciso…» Di Pani Bodynska non faceva mai il nome, quasi non esistesse. Secondo lui anche il padrone ascoltava i consigli, le decisioni della Frau Mitzi, e lui sapeva il fatto suo, essendo al loro servizio già da moltissimi anni.
Tutti conoscevano Frau Mitzi, tutti sapevano del potere che esercitava in quella casa. Accompagnata da un domestico carico di ogni bendidio la vedevano venire quasi ogni giorno nel villaggio. Entrava in ogni casa, si interessava di ognuno, si informava sulle loro storie di malattie e miseria, sempre le stesse, e distribuiva severa ma giusta a ogni famiglia quel tanto che portava. I quattro mesi fra giugno e settembre erano l’unico periodo dell’anno in cui era possibile placare in qualche modo la fame, anche se non proprio ogni giorno. Nessuno chiedeva chi la mandasse, supponendo più un ordine del padrone che non di quella donna svagata; anzi erano convinti, e non a torto, che lei non ne sapesse niente.
Pani Bodynska conosceva quei canti. Da circa vent’anni li sentiva e risentiva ogni estate e benché non ne riconoscesse la melodia, – per lei tutti uguali, li definiva anzi ‘canti barbari’ – aveva finito col farci l’abitudine. Lo strazio di quelle melodie le penetrava nelle ossa, nell’anima. Una nenia che aveva il potere di rilassarla, anzi di cullarla in un sonno leggero, rasserenante. Mezzo assopita faceva allora segno al cocchiere di proseguire. Lui sapeva dove andare.
Da quando la figlia, sposata da qualche mese a un ufficiale dell’esercito austriaco, era andata a vivere con lui nella capitale, pani Bodynska aveva preso l’abitudine di allungare il suo giro fino a una stradina accidentata, piena di buche e di polvere d’estate, fangosa in primavera per via del disgelo e quasi intransitabile in autunno per gli acquazzoni che da quelle parti si abbattevano con violenza quasi primordiale. Era anche accaduto che la carrozza, rimasta incagliata in una buca assai profonda, piena di fango, fosse stata tirata fuori da un paio di buoi, andati a prendere d’urgenza – una urgenza che si era protratta per tutta una mattinata. D’altra parte il povero cavallo mai sarebbe riuscito a tirarla fuori da solo.
Non si trattava di un’eccezione, tutto il sistema stradale della Galizia era in condizioni disastrose e nessuno se ne meravigliava.
Quella stradina aveva poi un’altra particolarità: di colpo s’interrompeva, attraversata dalle rotaie della ferrovia, senza passaggio a livello e roba del genere. Finiva semplicemente per proseguire poi dall’altra parte, all’infinito, fra vasti campi di grano. Al momento della costruzione della ferrovia erano state poste delle traversine fra una rotaia e l’altra per agevolarne il passaggio, pensando a qualche carro tirato da buoi. Niente di più.
Pani Bodynska non aveva intenzione di andare oltre. Mai andò oltre. Aveva raggiunto la meta delle sue passeggiate mattutine, le rotaie. Non voleva altro.
Se arrivava in tempo riusciva perfino a vedere il treno passare sbuffando fumo come per salutarli. Il macchinista a ogni buon conto fischiava già da lontano per avvertire un eventuale passante, e chissà, forse riconosceva ormai quel carrozzino che sembrava attenderlo quasi ogni mattina.
Quel treno veniva da Lemberg, la capitale della Galizia, e l’indomani mattina sarebbe arrivato a Vienna, la città della sua nostalgia. La signora si sollevava sui cuscini e lo seguiva con gli occhi fino a che spariva nell’orizzonte. Restava ancora qualche minuto in attesa. Osservava l’ultimo sbuffo di fumo sciogliersi nell’aria, mentre il leggero sferragliare del treno si perdeva in lontananza. Allora si abbandonava sui cuscini e il cocchiere sapeva che era il momento di tornare a casa.
Nostalgia, questa l’origine delle sue malinconie. E più gli anni passavano, più le si infiltrava nell’anima, come un veleno. E come un veleno agiva su di lei paralizzandola ogni giorno di più, impedendole di vivere, soffocandola come un corsetto che sempre più la stringeva.
Solo a Vienna era possibile respirare l’aria del gran mondo – al quale del resto non era mai appartenuta – soltanto Vienna le avrebbe potuto offrire la vita di società cui forse segretamente aspirava. Lì avrebbe potuto frequentare teatri, concerti di prim’ordine, essere vicina alla grande cultura europea, della quale in realtà mai aveva sentito bisogno.
Ogni volta però che il marito le offriva un viaggio, un lungo soggiorno a Vienna, veniva presa dal panico. Trovava delle scuse, si ammalava, rinunciava a priori. La prospettiva di un viaggio la riempiva di inquietudine. Rifuggiva ogni sorta di cambiamenti. Forse temeva un vuoto maggiore nella grande città, l’angoscia dell’anonimato, della solitudine dato che dopo tanti anni di lontananza aveva perso quasi ogni contatto con le conoscenze del passato. Un lungo soggiorno a Vienna avrebbe inoltre spezzato quell’ultimo filo di illusione; sarebbe venuto a mancare il motivo fondamentale della sua inquietudine, un piacere sottile del quale inconsciamente si nutriva e dava un senso alla sua vita. Si rifugiava in una specie di clausura volontaria, incapace di affrontare quel mondo cui credeva essere stata strappata con la forza, e soffriva, perdendosi sempre più in quella sofferenza.
In fondo Lemberg con la sua eleganza, i bei negozi, i caffè viennesi, i lussuosi alberghi forniti di tutti i comfort moderni, il Teatro e i Musei, le belle case padronali, l’Università, le chiese barocche e le bellissime Sinagoghe, e infine il Corso con le sue donne eleganti e gli ufficiali austriaci nelle loro uniformi luccicanti di bottoni e di mostrine dorate offriva tutto ciò che sarebbe dovuto bastare a una donna come lei. Lemberg il monte del leone – dal nome del suo fondatore, Lew von Halicz, (altri fanno il nome del principe ruteno Daniil Romanowitsch che nel 1256 vi gettò le fondamenta per una fortezza) era stata assimilata, circa duecento anni dopo, dal re polacco Kasimir II alla Polonia e una decina di anni dopo aveva acquistato i diritti di Magdeburgo diventando in tal modo una città a tutti gli effetti. Seguì un periodo di grande fioritura commerciale e la repubblica di Venezia, con la quale manteneva intensi rapporti d’affari, le aveva regalato un leone alato, che per molto tempo ebbe un posto d’onore di fronte al Municipio.
Lemberg, soprannominata a ragione ‘la piccola Vienna dei Carpazi’ per la sua bellezza architettonica, la sua intensa vita culturale e la sua eleganza, per lei era invece una piccola città di provincia, una specie di avamposto, l’ultimo confine di civiltà europea. Simbolicamente dietro le sue mura iniziava il paese dei barbari, la steppa, un luogo che era possibile definire solo con un motto: ‘Hic sunt leones.’ Questa la sua opinione.
Già quel miscuglio di lingue la disorientava ancora dopo più di venti anni. Non aveva voluto imparare il polacco per una sorta di arroganza, di superiorità. Il ruteno poi non lo considerava neanche una lingua a tutti gli effetti, secondo lei solo russo storpiato da gente incolta, un dialetto e niente di più. E anche i polacchi erano, secondo lei, ignoranti e analfabeti. Stranamente in una persona così riservata e modesta come pani Bodynska si manifestava tutta l’arroganza austriaca del XIX secolo.
Tante Melanie
Il padre di Franziska, Oberst Joseph Rill, alla fine del 1884 era stato trasferito come comandante della grande guarnigione di Lemberg. A malincuore e fra mille proteste, la piccola famiglia, cioè la moglie e la figlia, allora appena sedicenne, lo avevano seguito: madre e figlia considerarono quel trasferimento una punizione, anzi una condanna del tutto immeritata. Il padre, offeso, anche perché nonostante la lontananza dalla capitale si trattava in ogni caso di un avanzamento di grado, non mancava di sottolineare la bellezza di Lemberg, la vita che vi si svolgeva a confronto delle tante cittadine di provincia, veri avamposti della civiltà, dove avrebbero potuto finire.
La reazione di Franziska fu di chiusura, o meglio di rifiuto verso il mondo che la circondava, lo sguardo tenacemente rivolto indietro, verso la vita trascorsa a Vienna, una vita che d’altra parte nel ricordo acquistava tinte e atmosfere ben lontane dalla realtà.
La passeggiata lungo i Boulevards costellati di negozi con gli ultimi arrivi della moda, dove era facile incontrare il meglio della società del luogo, era un rito cui ogni pomeriggio si sottometteva solo per volontà della madre. Quell’essere messa in mostra, la cura con la quale la madre l’acconciava, la strigliava quasi fosse un cavallo in vendita, la mortificava; in lei mancava ogni segno di civetteria, di vanità femminile. Come da bambina, lasciava che la madre la maneggiasse come una bambola, passiva, priva di volontà, incapace di reagire. Non puntava mai i piedi, rinunciava già in partenza ad ogni scontro con la madre, perché sapeva di perdere in ogni caso la partita, qualunque essa fosse stata. In occasione delle passeggiate pomeridiane il padre, sicuro di sé e alquanto vanitoso, sfoggiava la sua smagliante uniforme, la madre i cappellini più eleganti, mentre lei, goffa e infelice, non osava camminare accanto a quella bella donnina che ancheggiava con raffinata civetteria al braccio del marito, attirando gli sguardi di tutti gli uomini che incontrava.
La passeggiata si concludeva immancabilmente in uno dei tanti caffè viennesi: seduti a un tavolino, davanti a un Melange o a una tazza di tè, osservavano non senza invidia gli ultimi rappresentanti dell’aristocrazia polacca, vecchi proprietari terrieri blasonati, fieri delle antiche tradizioni non meno dei loro baffi, mescolati ai nuovi ricchi, i cosiddetti ‘Ölbarone’ –i nuovi magnati del petrolio.
Nella seconda metà del XIX sec. come in America, nella regione intorno a Drohobycz era stato scoperto il petrolio. Dal giorno alla notte alcuni poveri contadini con gli stracci addosso erano diventati veri milionari con grossi conti in banca. Bisognava allora vedere con quanta alterigia si sedevano ai tavolini dei caffè più rinomati, soprattutto al ‘Grand Cafè’, noto come il ‘Rendez-vous der Nafthawelt’ dove lasciavano mance da far strabuzzare gli occhi ai camerieri, senza contare i diamanti grossi come noccioline che sfoggiavano al dito mignolo mentre con studiata indifferenza aprivano uno dei tanti giornali (150 di lingua diversa) che con ogni probabilità non potevano leggere perché analfabeti.
La madre aveva un solo pensiero, un solo cruccio: sistemare l’unica figlia nel migliore dei modi possibili e si dava un gran da fare alla ricerca di un buon partito, informandosi sempre dettagliatamente sulle disponibilità finanziarie di ogni presunto pretendente. In realtà disponeva solo di una modestissima dote e secondo le tradizioni familiari, sia sue che del marito, anche alla figlia era riservata la stessa sorte, cioè avrebbe dovuto sposare un ufficiale dell’esercito. Niente di più.
Solo che la madre ne aveva abbastanza di uniformi militari.
«L’amore e il matrimonio sono due cose ben distinte e separate» soleva ripetere alla figlia, come una litania. «Non conosco una sola coppia che si sia sposata per amore. Per amore si sposano solo i domestici e la povera gente. Solo chi non possiede neanche la camicia che ha addosso pensa all’amore. Una ragazza che si rispetti non corre dietro al primo innamorato e tanto meno pensa poi di sposarlo. Meglio sarebbe evitare di innamorarsi» concludeva sempre con fermezza, «l’amore non ha mai reso felice nessuno, porta solo inquietudine. Un buon matrimonio si basa prima di ogni cosa sulla stabilità finanziaria, che non deve assolutamente mancare, e poi sul rispetto reciproco: l’amore è solo un intralcio inutile.»
Alle timide proteste della figlia rispondeva sempre che non si riempisse la testa di romanzi francesi. «L’amore è solo un prodotto del cervello, un’illusione inebriante ed effimera come una coppa di champagne, che ha la caratteristica di sfumare appena entra in ballo la quotidianità della vita in comune.» E lei sapeva di che cosa parlava. Non aggiungeva mai di esser stata anche lei vittima di questa illusione, di aver sposato per amore e di aver sperimentato sulla propria pelle la noia, la delusione di un matrimonio d’amore messo a dura prova dalle difficoltà finanziarie e dalla banalità di ogni giorno.
Con quello che guadagnava il marito aveva tribolato per anni, barcamenandosi alla meglio per salvare le apparenze di un ménage adeguato al loro ceto. Ma quante rinunce, quante mortificazioni! Mai il lusso di un viaggio all’estero, vacanze in prestigiosi luoghi di villeggiatura, gioielli, pellicce, vestiti all’ultima moda. Le ristrettezze finanziarie le avevano tolto ogni gioia di vivere, si lamentava, avevano frustrato ogni piacere, umiliato le sue giuste aspirazioni di essere alla pari con le altre signore, mogli sì di ufficiali, ma con beni di famiglia, che impinguivano i magri stipendi dei mariti. Per la figlia sognava ben altro!
Senza contare che il suo matrimonio si era concluso solo per via di un testamento che avrebbe dovuto appianare ogni difficoltà futura; la Tante Melanie, sorella di suo nonno, vedova già da molti anni e senza figli, aveva deciso di lasciare tutto il suo patrimonio alla nipote, o meglio pronipote, futura signora Rill, per la quale nutriva una particolare simpatia. E questo, nonostante una quantità di parenti del marito attendessero con visibile impazienza la morte della vecchia. Dopotutto si trattava del patrimonio del marito.
La Tante Melanie visse assai a lungo, sempre scusandosi della propria longevità, convinta di defraudare con la propria vita una giovane famigliola. Ogni volta che incontrava il padre dell’ormai signora Rill, non mancava mai dire con un certo rammarico:
«Sono ancora qui, come vedi… la morte mi ha dimenticata.» Con grande imbarazzo di tutti.
Franzi bambina, ogni volta che la madre usciva con lei e al cocchiere della carrozzella di piazza dava l’indirizzo, Haitzingergasse, sapeva che sarebbe andata dalla loro benefattrice, colei dalla cui morte dipendeva il tanto sospirato benessere. La madre non parlava d’altro! La vecchietta, sempre più piccola e magra, quasi in procinto di sparire, le riceveva con estrema cortesia; chiamava la sua serva, vecchia quanto lei, e ordinava di preparare il tè. Si sedevano poi attorno al tavolo in una stanza sovraccarica di mobili neri cui, secondo una moda del tempo, erano incastonati pezzi di madreperla. L’atmosfera era come in un sepolcro. Una quantità di sedie, poltrone, mobiletti e tavolini impediva il passaggio da una parte all’altra della stanza; quadri, ninnoli vari, cuscini polverosi riempivano ogni angolo, ogni parete. Qui d’inverno si gelava, dato che per economia la stufa veniva accesa solo in cucina e neanche tutto il giorno, mentre d’estate si soffocava per il caldo.