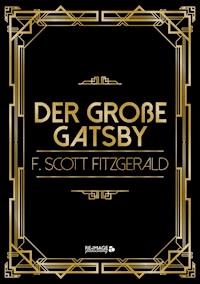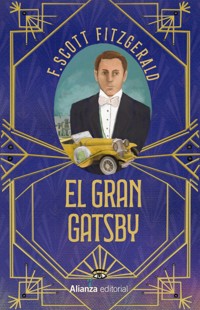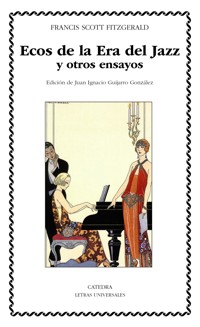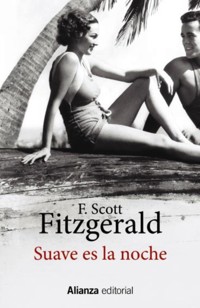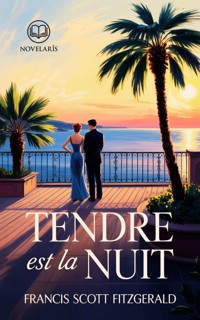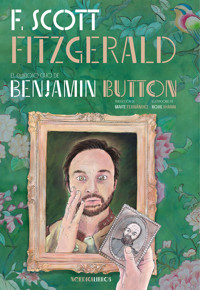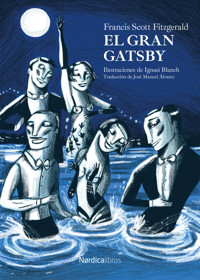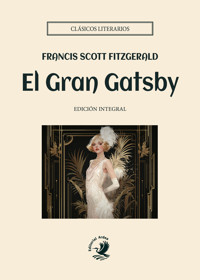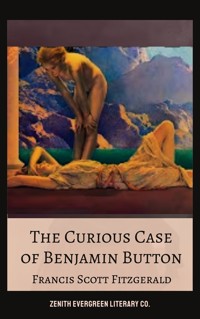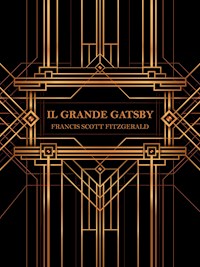
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: David De Angelis
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Englisch
Il Grande Gatsby (
The Great Gatsby) è un romanzo di Francis Scott Fitzgerald pubblicato per la prima volta a New York il 10 aprile 1925 e definito da T.S. Eliot «il primo passo in avanti fatto dalla narrativa americana dopo Henry James».
Ambientato a New York e a Long Island durante l'estate del 1922,
Il Grande Gatsby è il più acuto ritratto dell'anima dell'età del jazz, con le sue contraddizioni, il suo vittimismo e la sua tragicità. La storia, che seguendo la tecnica di Henry James viene raccontata da uno dei personaggi, narra la tragedia del mito americano che aveva retto il paese dai tempi dello sbarco a Plymouth Rock e può essere considerata l'autobiografia spirituale di Fitzgerald che, ad un certo punto della sua vita, chiuso con l'alcolismo e con la vita da playboy, voleva capire quali fossero stati gli ostacoli che avevano fatto inabissare la sua esistenza.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Indice dei contenuti
Capitolo 1
Capitolo 2
Capitolo 3
Capitolo 4
Capitolo 5
Capitolo 6
Capitolo 7
Capitolo 8
Capitolo 9
PROPOSITI GENERALI
Il grande Gatsby
di
F. Scott Fitzgerald
Traduzione ed edizione 2020 a cura di ©David De Angelis
Tutti i diritti sono riservati
Allora indossa il cappello d’oro, se quello la smuoverà;
Se puoi saltare in alto, salta anche per lei,
Finché lei non griderà “Amore, amore dal cappello d’oro, che salti in alto,
Io devo averti!”
THOMAS PARKE D’INVILLIERS
Capitolo 1
Nei miei anni più giovani e più vulnerabili mio padre mi diede un consiglio che da allora ho sempre tenuto vivo nella mia mente.
“Ogni volta che ti viene da criticare qualcuno,” mi disse, “ricordati solo che non tutte le persone del mondo hanno avuto i vantaggi che hai avuto tu.”
Non disse altro, ma siamo sempre stati insolitamente comunicativi in modo riservato, e compresi che ciò che voleva dire andava ben oltre quelle semplici parole. Di conseguenza sono propenso a tenere da parte tutti i giudizi; un’abitudine che mi ha fatto conoscere molte indoli curiose e mi ha anche reso vittima di non pochi seccatori accaniti. La mente anormale è veloce a individuare questa qualità e ad attaccarcisi quando essa appare in una persona normale, e così accadde che all’università fui ingiustamente accusato di essere un politico, poiché ero al corrente delle afflizioni segrete di uomini sconosciuti e sfrenati. La maggior parte delle confidenze non erano richieste; di frequente ho simulato il sonno, la preoccupazione, o una frivolezza ostile quando mi sono reso conto, a causa di un qualche segno inconfondibile, che una rivelazione intima stava tremando all’orizzonte, poiché le rivelazioni intime dei giovani uomini, o almeno i termini in cui le esprimono, sono di solito plagiarie e guastate da evidenti omissioni. Sospendere il giudizio è una questione di speranza infinita. Ho ancora un po’ di paura di perdere qualcosa se mi dimentico che, come mio padre suggerì snobisticamente, e io snobisticamente ripeto, il senso delle fondamentali regole di decenza viene
distribuito inegualmente alla nascita.
E, dopo aver vantato questo mio modo di tollerare, arrivo ad ammettere che esso ha un limite. La condotta può essere fondata sulla dura roccia o su un terreno paludoso, ma oltre un certo punto non m’importa su cosa sia fondata. Quando tornai dall’Est lo scorso autunno sentii di volere che il mondo fosse in uniforme e che stesse per sempre su una specie di attenti morale; non volevo più escursioni tumultuanti con occhiate privilegiate all’interno del cuore umano. Solo Gatsby, l’uomo che dà il nome a questo libro, fu esente dalla mia reazione; Gatsby che rappresentava tutto ciò per cui ho un autentico disprezzo. Se la personalità è una serie ininterrotta di azioni riuscite, allora c’era qualcosa di magnifico in lui, un’amplificata sensibilità alle promesse della vita, come se lui fosse connesso a uno di quei macchinari complessi che registrano i terremoti a quindicimila chilometri di distanza. Questa sensibilità non aveva nulla a che fare con quella fiacca impressionabilità che viene nobilitata con il nome di “indole creativa”; era una straordinaria dote per la speranza, una prontezza romantica tale come non ne ho mai trovata in nessun’altra persona e che è improbabile che io possa mai trovare ancora. No, Gatsby risultò a posto alla fine; è ciò che lo logorava, quella polvere sporca che galleggiava nella scia dei suoi sogni, che chiuse temporaneamente il mio interesse per le vane afflizioni e le bolse euforie degli uomini.
Le persone della mia famiglia sono state persone distinte e agiate di questa città del Midwest per tre generazioni. I Carraway sono un po’ come un clan e abbiamo una tradizione secondo cui discendiamo dai duchi di Buccleuch, ma il vero fondatore della mia stirpe fu il fratello di mio nonno, che venne qui nel cinquantuno, mandò un sostituto nella Guerra Civile e cominciò l’attività di ferramenta
all’ingrosso che mio padre porta avanti ancora oggi.
Io non ho mai visto questo prozio ma si ritiene che gli assomigli, se si fa riferimento al dipinto piuttosto indurito che sta appeso nell’ufficio di mio padre. Mi sono laureato a New Haven nel 1915, solo un quarto di secolo dopo mio padre, e un poco più tardi ho partecipato a quella migrazione teutonica ritardata conosciuta come Grande Guerra. Mi sono gustato il contrattacco tanto a fondo che sono tornato indietro insonne. Invece di essere il caldo centro del mondo, il Midwest ora sembrava l’orlo frastagliato dell’universo, così decisi di andare nell’Est e di imparare l’attività di compravendita delle obbligazioni. Tutti quelli che conoscevo erano coinvolti in tale attività quindi supposi che potesse dare sostentamento a un uomo in più. Tutte le mie zie e i miei zii ne discussero a fondo come se stessero scegliendo un collegio per me e alla fine dissero “Beh, sì” con volti molto seri ed esitanti. Mio padre concordò di finanziarmi per un anno e dopo vari ritardi andai nell’Est, in modo permanente (così pensai), nella primavera del ventidue.
La soluzione pratica stava nel trovare delle stanze in città, ma era una stagione calda e avevo appena lasciato una campagna di ampie distese erbose e alberi amichevoli, così quando un giovane uomo in ufficio suggerì che prendessimo una casa insieme in un posto da pendolari mi sembrò un’ottima idea. Trovò la casa, una villetta a un solo piano segnata dalle intemperie, per ottanta dollari al mese, ma all’ultimo momento l’azienda lo mandò a Washington e io andai in campagna da solo. Avevo un cane, o almeno lo ebbi per qualche giorno finché non scappò via, e una vecchia Dodge e una donna finlandese che mi faceva il letto e preparava la colazione ed emetteva saggezza finlandese mormorando tra sé e sé davanti al fornello elettrico.
Fui solo per un giorno o quasi finché una mattina un uomo,
arrivato più di recente rispetto a me, mi fermò per strada. “Come si arriva a West Egg?” chiese disperatamente. Glielo dissi. E mentre continuavo a camminare non fui più solo. Ora ero una guida, un apripista, un colonizzatore originale. Mi aveva casualmente conferito la libertà del quartiere.
E così con lo splendore del sole e con le grandi esplosioni di foglie che crescevano sugli alberi, proprio come le cose crescono nei film, ebbi quella convinzione familiare secondo cui la vita, con l’estate, ricomincia da capo.
C’era tantissimo da leggere, tanto per cominciare, e tantissima buona salute da cogliere da quella giovane aria fresca. Comprai una dozzina di volumi sull’attività bancaria, sul credito e sulle obbligazioni, e questi stavano sul mio scaffale rossi e dorati come denaro nuovo arrivato dalla zecca, promettendo di rivelare i segreti splendenti che solo Mida e Morgan e Mecenate conoscevano. E avevo la forte intenzione di leggere molti altri libri. Ero piuttosto interessato alla letteratura all’università (un anno scrissi una serie di editoriali assai solenni ed espliciti per lo “Yale News”), e ora stavo per riportare tutte queste cose nella mia vita e diventare di nuovo il più limitato di tutti gli specialisti, “l’uomo a tutto tondo”. Questo non è solo un epigramma; dopo tutto, la vita la si può vedere molto meglio se la si guarda da una sola finestra.
Fu dovuto al caso il fatto che affittai una casa in una delle comunità più strane del Nord America. Accadde su quell’esile isola tumultuante che si estende a est di New York e dove ci sono, tra altre curiosità naturali, due insolite formazioni di terra. A trenta chilometri dalla città un paio di uova enormi, identiche nei contorni e separate solo da una baia di cortesia, si protendono nel più addomesticato corpo d’acqua salata dell’emisfero occidentale: la grande aia bagnata della laguna di Long Island. Non sono dei perfetti
ovali: come l’uovo della storia di Colombo sono entrambi schiacciati, piatti, dal lato dove fanno contatto. Ma la loro somiglianza fisica dev’essere fonte di perpetua confusione per i gabbiani che ci volano sopra. Per chi è senz’ali, un aspetto che colpisce parecchio è la loro dissomiglianza in ogni particolare a eccezione della forma e delle dimensioni.
Io vivevo a West Egg, la... Beh, la meno alla moda delle due, anche se questa è un’etichetta assai superficiale per esprimere il contrasto bizzarro e non poco sinistro esistente tra loro. La mia casa era proprio sulla punta dell’uovo, a soli cinquanta metri dalla laguna, e stava pigiata tra due posti enormi che venivano affittati per dodici o quindicimila a stagione. Quello sulla mia destra era un affare colossale sotto ogni aspetto; era un’effettiva imitazione di qualche Hôtel de Ville della Normandia, con una torre da un lato, nuova di zecca sotto una sottile barba di edera incolta, e una piscina di marmo e più di quaranta acri di prato e giardino. Era la residenza di Gatsby. O meglio, dato che non conoscevo il signor Gatsby, era una residenza abitata da un gentiluomo con quel nome. La mia casa era un pugno in un occhio, ma un pugno in un occhio piccolo, e non era stata considerata, perciò avevo una vista sull’acqua, una vista parziale sul prato del mio vicino, e la consolante vicinanza dei milionari: tutto per ottanta dollari al mese.
Dall’altra parte della baia di cortesia i bianchi palazzi dell’elegante East Egg luccicavano lungo l’acqua, e la storia di quell’estate comincia per davvero la sera in cui guidai fin là per cenare da Tom Buchanan. Daisy era figlia di un secondo cugino e avevo conosciuto Tom all’università. E appena dopo la guerra trascorsi due giorni con loro a Chicago.
Suo marito, tra varie imprese fisiche, era stato uno dei più potenti attaccanti che abbiano mai giocato a football a New
Haven; una figura nazionale per certi aspetti, uno di quegli uomini che raggiungono una tale eccellenza acuta e limitata a ventun anni che tutto quello che viene dopo sa di anticlimax. La sua famiglia era enormemente ricca (anche all’università la sua disinvoltura con il denaro era motivo di rimprovero) ma ora aveva lasciato Chicago ed era venuto a est in una maniera che ti toglieva proprio il fiato: per esempio, aveva portato una scuderia di cavalli da polo da Lake Forest. Era difficile rendersi conto che un uomo della mia stessa generazione fosse abbastanza ricco da fare ciò. Perché vennero a est non lo so. Avevano passato un anno in Francia, senza un motivo particolare, e poi avevano vagato di qua e di là irrequietamente ovunque la gente giocasse a polo e fosse anche ricca. Ora si trattava di uno spostamento permanente, disse Daisy per telefono, ma io non ci credetti; non potevo vedere nel cuore di Daisy ma sentivo che Tom avrebbe continuato a vagare per sempre cercando un po’ nostalgicamente la forte turbolenza di una qualche irrecuperabile partita di football. E così accadde che una calda sera ventosa guidai fino a East Egg per vedere due vecchi amici che quasi non conoscevo affatto. La loro casa era ancor più elaborata di quanto mi sarei aspettato: una vivace villa coloniale georgiana rossa e bianca che dava sulla baia. Il prato cominciava dalla spiaggia e correva verso la porta frontale per mezzo chilometro, saltando su meridiane e vialetti di mattoni e giardini ardenti, e infine raggiungeva la casa risalendo un lato con luminose piante rampicanti come se lo facesse per l’impeto della sua corsa. Il davanti era spezzato da una serie di portefinestre che ora luccicavano di oro riflesso, e che erano spalancate verso il caldo pomeriggio ventoso, e Tom Buchanan, con indosso abiti da equitazione, stava con le gambe divaricate nella veranda frontale.
Era cambiato rispetto ai suoi anni a New Haven. Ora era un
uomo robusto di trent’anni, dai capelli paglierini, con una bocca piuttosto sgraziata e un contegno altezzoso. Due fulgidi occhi arroganti avevano stabilito il proprio dominio sul suo volto e gli davano l’apparenza di sporgersi sempre aggressivamente in avanti. Neanche l’effeminata ostentazione dei suoi vestiti da equitazione poteva nascondere l’enorme potenza di quel corpo; sembrava riempire quegli stivali luccicanti, e quando si mise a tendere il laccio superiore si potè vedere un grosso fagotto muscoloso spostarsi non appena la sua spalla si mosse sotto la sua giacca sottile. Era un corpo capace di un leveraggio enorme: un corpo crudele.
Il suo tono di voce da tenore, aspro e roco, accresceva l’impressione di irritabilità che trasmetteva. C’era un tocco di sprezzo paterno in esso, anche verso le persone che gli piacevano, e c’erano uomini a New Haven che non lo avevano potuto soffrire.
“Ora non pensare che la mia opinione su queste faccende sia quella definitiva,” sembrava che dicesse, “solo perché sono più forte e più uomo di te.” Eravamo nella stessa società studentesca, e anche se non fummo mai intimi ebbi sempre l’impressione che lui mi approvasse e che volesse piacermi con un suo senso di nostalgia aspro e provocatorio.
Parlammo per qualche minuto nella veranda soleggiata.
“Mi sono preso un bel posto qui”, disse, con gli occhi che guizzavano intorno agitati.
Facendomi girare con un braccio mosse un’ampia mano piatta lungo la vista frontale, includendo nel suo movimento un giardino incassato italiano, mezzo acre di alte rose pungenti e un motoscafo col muso schiacciato e all’insù che sobbalzava contro la marea al largo.
“Apparteneva a Demaine, il petroliere.” Mi fece di nuovo girare, improvvisamente e garbatamente. “Andiamo dentro.”
Camminammo attraverso un alto atrio per arrivare in uno spazio luminoso di color roseo, fragilmente vincolato alla casa da delle portefinestre a entrambe le estremità. Le finestre erano socchiuse e luccicavano bianche contro l’erba fresca dell’esterno, che sembrava farsi un po’ strada dentro la casa. Una brezza soffiò attraverso la stanza, soffiò le tende in dentro da un lato e in fuori dall’altro, come pallidi vessilli, facendole attorcigliare verso la torta nuziale glassata del soffitto, e poi increspare sul tappeto color vino, creando un’ombra su di esso come fa il vento sul mare.
L’unico oggetto completamente stazionario in quella stanza era un enorme divano su cui due giovani donne erano tenute a galla come su una mongolfiera ancorata. Erano entrambe in bianco e i loro vestiti si increspavano e ondeggiavano come se fossero appena state spinte lì indietro dal vento dopo un breve volo intorno alla casa. Devo essere stato per qualche momento ad ascoltare lo sferzare e lo schioccare delle tende e il gemito di un quadro appeso al muro. Poi ci fu un rimbombo come Tom Buchanan chiuse le finestre sul retro, e il vento catturato si estinse nella stanza, e le tende e i tappeti e le due giovani donne scesero lentamente sul pavimento fluttuando.
La più giovane delle due era un’estranea per me. Era completamente distesa dal suo lato del divano, completamente immobile e con il mento leggermente alzato come se sopra ci stesse tenendo in equilibrio qualcosa che aveva buone probabilità di cadere. Se anche mi vide con la coda dell’occhio non ne diede indizio; in verità mi fece quasi sussurrare delle scuse per averla disturbata con il mio ingresso.
L’altra ragazza, Daisy, fece un tentativo di alzarsi: si piegò leggermente in avanti con un’espressione coscienziosa, poi rise, con una risatina sciocca, incantevole, e risi anch’io, e lei
venni avanti nella stanza.
“Sono p-paralizzata per la felicità.”
Rise di nuovo, come se avesse detto qualcosa di molto arguto, e tenne la mia mano per un momento, alzando lo sguardo per guardarmi in viso, assicurando che non ci fosse nessuno al mondo che avrebbe voluto vedere così tanto. Quello era un modo di fare che aveva lei. Indicò, con un sussurro, che il cognome della ragazza equilibrista era Baker (ho sentito dire che Daisy sussurrasse solo per far sì che le persone si piegassero verso di lei; una critica irrilevante che non rendeva in alcun modo meno delizioso quel modo di fare).
Ad ogni modo, le labbra della signorina Baker si agitarono, mi fece un cenno con la testa quasi impercettibilmente e poi, rapidamente, inclinò di nuovo indietro la testa; l’oggetto che stava tenendo in equilibrio ovviamente aveva barcollato un po’ e le aveva dato un po’ di spavento. Di nuovo una specie di scusa si presentò sulle mie labbra. Quasi ogni esibizione di completa sicurezza di sé attira un tributo incantato da parte mia.
Volsi di nuovo lo sguardo a mia cugina che iniziò a farmi domande con il suo tono di voce basso e penetrante. Era il tipo di voce che l’orecchio segue su e giù come se ogni discorso fosse una composizione di note che non saranno suonate mai più. Il suo volto era triste e grazioso e aveva dei punti luminosi, degli occhi lucenti e una lucente bocca passionale, ma c’era un’eccitazione nella sua voce che gli uomini che le avevano voluto bene trovavano difficile dimenticare: una compulsione che cantava, un “Ascolta” sussurrato, una promessa secondo la quale lei aveva fatto cose gaie ed emozionanti appena un attimo prima e c’erano cose gaie ed emozionanti che incombevano di lì a un’ora.
Le dissi di come avevo fatto tappa a Chicago per un giorno
durante il mio viaggio verso est e di come una dozzina di persone avevano inviato il loro affetto tramite me.
“Gli manco?” esclamò estaticamente.
“L’intera città è desolata. Tutte le automobili hanno la ruota posteriore sinistra verniciata di nero come una ghirlanda mortuaria e c’è un pianto persistente tutta la notte lungo la costa settentrionale.”
“Che bello! Torniamo indietro, Tom. Domani!” Poi aggiunse, in modo non pertinente, “Devi vedere la bambina”.
“Mi farebbe piacere.”
“È addormentata. Ha due anni. Non l’hai mai vista?”
“Mai.”
“Beh, devi vederla. È...”
Tom Buchanan, che si era aggirato per la stanza in modo agitato, si fermò e poggiò una mano sulla mia spalla.
“Che fai, Nick?”
“Mi occupo di obbligazioni.”
“Con chi?” Glielo dissi.
“Mai sentiti”, commentò fermamente. Questo mi infastidì.
“Li sentirai”, risposi seccamente. “Li sentirai se resti nell’Est.”
“Oh, resterò nell’Est, non ti preoccupare”, disse, dando un’occhiata a Daisy e poi di nuovo a me, come se fosse in allarme per qualcos’altro. “Sarei un maledetto sciocco se vivessi da qualunque altra parte.”
A questo punto la signorina Baker disse “Assolutamente!” con una tale subitaneità che io sussultai; era la prima parola che aveva emesso da quando ero entrato nella stanza. Evidentemente colse di sorpresa sé stessa tanto quanto me, dato che sbadigliò e, con una serie di movimenti agili e lesti, si mise in piedi nella stanza.
“Sono indolenzita,” si lamentò, “sono rimasta distesa su quel sofà da quando ho memoria.”
“Non guardare me”, replicò Daisy. “Ho provato a farti andare a New York tutto il pomeriggio.”
“No, grazie,” disse la signorina Baker ai quattro cocktail appena portati dalla dispensa, “sono assolutamente in forma.”
Il padrone di casa la guardò incredulo.
“Lo sei!” Bevette il suo cocktail come se fosse una goccia in fondo a un bicchiere. “Come tu faccia a concludere qualcosa non riesco proprio a capirlo.”
Guardai la signorina Baker domandandomi che cosa fosse che lei “concludeva”.
Mi piaceva guardarla. Era una ragazza snella, dal seno minuto, con un portamento diritto che lei accentuava buttando il corpo indietro all’altezza delle spalle come un giovane cadetto. I suoi occhi grigi, affaticati dal sole, contraccambiavano il mio sguardo con cortese curiosità reciproca da un viso pallido, incantevole e scontento. Ora mi venne in mente che l’avevo vista, o avevo visto una sua foto, da qualche parte in precedenza.
“Lei vive a West Egg”, commentò sdegnosamente. “Conosco qualcuno là.”
“Io non conosco proprio...”
“Gatsby lo deve conoscere.”
“Gatsby?” chiese Daisy. “Quale Gatsby?”
Prima che potessi rispondere che era il mio vicino di casa la cena fu annunciata; infilando il suo braccio teso imperativamente sotto il mio, Tom Buchanan mi portò fuori dalla stanza come se stesse spostando una pedina su un’altra casella.
Lievemente, languidamente, con le mani poste delicatamente sui fianchi, le due giovani donne ci precedettero all’esterno in una veranda rosata che dava sul tramonto, dove quattro candele, sul tavolo, tremolavano nel vento che si era
attenuato.
“Perché le candele?” obiettò Daisy, corrucciata. Le spense con le dita. “Tra due settimane sarà il giorno più lungo dell’anno.” Ci guardò tutti, raggiante. “A voi non capita di aspettare sempre il giorno più lungo dell’anno e poi ve lo perdete? Io aspetto sempre il giorno più lungo dell’anno e poi me lo perdo.”
“Dobbiamo organizzare qualcosa”, sbadigliò la signorina Baker, sedendosi al tavolo come se stesse andando a letto.
“Giusto”, disse Daisy. “Cosa organizziamo?” Si girò verso di me, con aria impotente. “Che cosa organizza la gente?”
Prima che potessi rispondere, i suoi occhi si fissarono sul suo mignolo con un’espressione sbigottita.
“Guardate!” si lamentò. “Mi son fatta male.”
Guardammo tutti: la nocca era nera e blu.
“Sei stato tu, Tom”, disse con fare accusatorio. “So che non volevi ma lo hai fatto. Ecco quello che ottengo per aver sposato un bruto, un esemplare grosso e goffo di...”
“Odio la parola goffo,” obiettò Tom bruscamente, “anche se è detta per scherzo.”
“Goffo”, insisté Daisy.
A volte lei e la signorina Baker parlavano all’improvviso, senza essere invadenti e con un’incoerenza canzonatoria che non era mai proprio chiacchiera, e che era fredda come i loro vestiti bianchi e i loro occhi impersonali in cui vi era assenza di ogni desiderio. Erano qui, e accettavano Tom e me, facendo solo uno sforzo cortese per intrattenere o per essere intrattenute. Sapevano che di lì a poco la cena sarebbe finita e poco più tardi anche la serata sarebbe finita e sarebbe stata messa via con noncuranza. Era drasticamente diverso dall’Ovest, dove una serata veniva fatta incalzare da una fase all’altra verso la sua fine in un’attesa continuamente delusa oppure in una pura paura nervosa del momento della fine.
“Mi fai sentire incivile, Daisy”, confessai al mio secondo bicchiere di un vino rosso piuttosto notevole ma che sapeva di sughero. “Non puoi parlare di raccolti o cose simili?”
Non volevo dire nulla di particolare con quel commento ma fu preso in modo inaspettato.
“La civiltà sta andando a pezzi”, proruppe Tom violentemente. “Sono diventato terribilmente pessimista su come andranno le cose. Hai letto ’La nascita degli imperi di colore‘ di un tale Goddard?”
“No, perché?”, risposi, piuttosto sorpreso dal suo tono.
“Beh, è un bel libro, e tutti dovrebbero leggerlo. L’idea è che se non stiamo attenti la razza bianca sarà... sarà totalmente sommersa. È tutta roba scientifica; è stato provato.”
“Tom sta diventando molto profondo”, disse Daisy con un’espressione di tristezza spensierata. “Legge libri profondi che contengono dei paroloni. Qual era quella parola che...”
“Beh, sono tutti libri scientifici”, insisté Tom, dandole un’occhiata impaziente. “Questo tizio ha elaborato tutta la questione. Sta a noi che siamo la razza dominante fare attenzione o queste altre razze prenderanno il controllo delle cose.”
“Dobbiamo abbatterli”, sussurrò Daisy, ammiccando spietatamente verso il sole ardente.
“Dovreste vivere in California...” esordì la signorina Baker, ma Tom la interruppe muovendosi pesantemente sulla sedia.
“L’idea è che noi siamo nordici. Io lo sono, tu lo sei e tu lo sei e...” Dopo un’esitazione infinitesimale incluse Daisy con un lieve cenno del capo e lei mi fece di nuovo l’occhiolino. “E abbiamo prodotto tutte le cose che vanno a creare la civiltà... Oh, la scienza e l’arte e tutto quanto. Capite?”
C’era qualcosa di patetico nella sua concentrazione, come se il suo compiacimento, più acuto che in passato, non fosse più abbastanza per lui. Quando, quasi immediatamente, il
telefono squillò all’interno e il maggiordomo lasciò la veranda, Daisy colse al volo l’interruzione momentanea e si piegò verso di me.
“Ti dico un segreto di famiglia”, sussurrò entusiasticamente.
“Riguarda il naso del maggiordomo. Vuoi sapere del naso del maggiordomo?”
“È per questo che sono venuto stasera.”
“Beh, non è sempre stato un maggiordomo; una volta lucidava l’argenteria per della gente a New York che gestiva un servizio a tavola per duecento persone. Doveva lucidarlo dalla mattina alla sera, finché non cominciò a nuocergli al naso...”
“Le cose andarono di male in peggio”, suggerì la signorina Baker.
“Sì. Le cose andarono di male in peggio e alla fine dovette lasciare quel lavoro.”
Per un istante l’ultima luce del sole cadde con romantico affetto sul fiammeggiante volto di lei; la sua voce mi sospingeva in avanti, col fiato sospeso, mentre ascoltavo. Poi il bagliore svanì, e ogni luce l’abbandonò con un rimpianto persistente, come dei bambini che lasciano una strada piacevole al crepuscolo.
Il maggiordomo fece ritorno e mormorò qualcosa all’orecchio di Tom, al che Tom si accigliò, spinse indietro la sedia e andò dentro senza dire una parola. Come se la sua assenza accelerasse qualcosa all’interno di lei, Daisy si piegò di nuovo in avanti, con una voce radiosa e melodiosa.
“Sono davvero contenta di vederti a questa tavola, Nick. Mi fai venire in mente... una rosa, proprio una rosa. Non è così?” Si volse verso la signorina Baker per chiedere conferma.
“Proprio una rosa?”
Non era vero. Non sono neanche vagamente come una rosa. Lei stava solo improvvisando, ma un ardore emozionante
sgorgava da lei come se il suo cuore stesse provando a uscire per raggiungerti nascosto in una di quelle parole trafelate e conturbanti. Poi di colpo gettò il suo tovagliolo sul tavolo, si scusò ed entrò in casa.
La signorina Baker e io scambiammo un breve sguardo consapevolmente privo di significato. Stavo per parlare quando lei si tirò su, allarmata, e disse “Sh!” con un tono d’ammonimento. Un tenue mormorio appassionato era udibile nella stanza accanto e la signorina Baker si piegò in avanti, senza vergogna, per provare ad ascoltare. Il mormorio fremette sull’orlo dell’intellegibile, si abbassò, salì animatamente e poi cessò del tutto.
“Questo signor Gatsby di cui ha parlato è il mio vicino di casa...” dissi.
“Non parli. Voglio sentire cosa succede.”
“Sta succedendo qualcosa?” chiesi innocentemente.
“Vuol dire che lei non sa?” disse la signorina Baker, onestamente sorpresa. “Pensavo che lo sapessero tutti.”